|
 Sant'Alfio
si sviluppa a 531 metri sul livello del mare e conta 1.769 abitanti. La
citta' colpisce soprattutto per la bellezza naturalistica dei dintorni. In
effetti da qui e' possibile effettuare varie escursioni. La prima
interessa i "Crateri del 1928" che furono creati da una potente
eruzione dell'Etna. Essi sono raggiungibili partendo dalla contrada
Magazzeni in direzione della contrada Ripe della Naca dove e' possibile
ammirare i conetti di scorie saldate create dall'eruzione. Una seconda
escursione interessa il Sentiero Natura Monti Sartorius, un'escursione che
permette di ammirare i crateri a bottoniera dei Monti Sartorius, i
boschetti di ginestra dell'etna e la formazione di betulla endemica. Una
terza escursione riguarda il Parco Comunale di Contrada Cava, affascinante
dal punto di vista naturalistico perche' raccoglie vari esempi di
vegetazione, dalla macchia mediterranea ai boschi di castagno, di leccio e
di cerro, ma interessante anche dal punto di vista storico perche'
permette di ammirare i primi insediamenti rurali d'origine seicentesca. Sant'Alfio
si sviluppa a 531 metri sul livello del mare e conta 1.769 abitanti. La
citta' colpisce soprattutto per la bellezza naturalistica dei dintorni. In
effetti da qui e' possibile effettuare varie escursioni. La prima
interessa i "Crateri del 1928" che furono creati da una potente
eruzione dell'Etna. Essi sono raggiungibili partendo dalla contrada
Magazzeni in direzione della contrada Ripe della Naca dove e' possibile
ammirare i conetti di scorie saldate create dall'eruzione. Una seconda
escursione interessa il Sentiero Natura Monti Sartorius, un'escursione che
permette di ammirare i crateri a bottoniera dei Monti Sartorius, i
boschetti di ginestra dell'etna e la formazione di betulla endemica. Una
terza escursione riguarda il Parco Comunale di Contrada Cava, affascinante
dal punto di vista naturalistico perche' raccoglie vari esempi di
vegetazione, dalla macchia mediterranea ai boschi di castagno, di leccio e
di cerro, ma interessante anche dal punto di vista storico perche'
permette di ammirare i primi insediamenti rurali d'origine seicentesca.

Davanti allo Stretto: Castelmola,
Taormina, Giardini e la Baia di Naxos viste dalla piazza Belvedere di
Milo (CT)
Completa
l'aspetto naturalistico della citta' il cosi' chiamato "Castagno dei
100 cavalli" Il
Castagno dei Cento Cavalli secondo il noto botanico torinese Peyronal ha
un'età di 3000 - 4000 anni ed è l'albero più antico d'Europa e il più
grande d'Italia.
A soli 300 metri di distanza, in contrada Taverna di Mascali, si trova il
secondo albero più grande d'Italia con un'età di oltre 1000 anni il
cosiddetto "Castagno della Nave".
Alcuni, negli anni passati, hanno scritto delle mal ridotte
condizioni del Castagno dei Cento Cavalli; è facile dimostrare il
contrario, basti pensare che già alla fine del '700 Jean Houel nel Voyage
de la Sicile, de Malta e Lipari (1784 II pg 76-80) lo descrive "in
uno stato non ottimale" e Alberto Fortis (1780 "Della coltura
del castagno) rincara sostenendo che "esso trovasi attualmente
degradato......" mentre nel 1967 l'eminente professore
dell'Università di Padova Lucio Susmel, riportando le notizie scritte a
fine ottocento dal botanico Parlatore lo classificò come non più
esistente, salvo a ricredersi dopo una simpatica corrispondenza con un
intellettuale del luogo.
Vale la pena citare lo scrittore Vincenzo Consolo che su Specchio
del 16/10/1999 ha definito il Castagno dei Cento Cavalli "un prodigio
della natura, una miracolosa sopravvivenza di un profondissimo tempo"
per smentire quanti vorrebbero privarci di questo "superbo orgoglio
di una vita che non si spegne".
Il Comune di Sant'Alfio negli ultimi anni ha profuso un forte impegno
per salvaguardare il millenario Patriarca; sono stati eseguiti diversi
interventi sulla pianta consistenti essenzialmente nella potatura delle
parti secche e nella cura e manutenzione dell'albero. Tali interventi sono
stati operati seguendo i suggerimenti tecnici per il risanamento e la
conservazione guidata dell'albero tratti da uno studio eseguito dai
docenti Oscar Alberghina, Giovanni Granata e Santi Longo dell'Università
di Catania nonchè sotto la sorveglianza di un'apposita commissione
tecnico scientifica composta da rappresentanti del Comune, della
Forestale, della Soprintentenza BB.CC. e dell'Università e con la
collaborazione della Provincia Regionale di Catania. In atto l'albero gode
di buona salute ed è ricoperto di una sana e rigogliosa vegetazione.
E'
considerato l'albero più antico e più grande d'Europa. Il nome è legato
alla tradizione secondo cui, sotto le sue enormi chiome, durante un
temporale trovarono piacevole... riparo la regina Giovanna d'Aragona e il
suo seguito di cento cavalieri. Cantato e descritto da numerosi
viaggiatori e studiosi nel '700 e nell'800, il Castagno è oggi meta di
visitatori di tutto il mondo oltre che di botanici per i quali costituisce
interessante oggetto di studio.
Dal
punto di vista artistico la citta' si ricorda soprattutto per la
seicentesca Chiesa Madre intitolata ai "tre fratelli martiri" S.
Alfio, San Filadelfo e San Cirino che da qui passarono seguendo il loro
percorso per il luogo destinato al loro martirio. La Chiesa e'
impreziosita dalla presenza di alcuni altari in marmi policromi e svariati
affreschi tra i quali spiccano quelli ottocenteschi presenti nell'abside
che rafffigurano il "Trionfo dei Tre Martiri".
Tra
le Chiese minori cittadine occorre citare quella ottocentesca del
Calvario, situata in un luogo privilegiato che consente di ammirare
splendidi panorami sullo Ionio che domina nella parte bassa del paese, e
quella dei Nucifori che si ricorda soprattutto il busto della Madonna di
Tindari, molto venerato dagli abitanti di S. Alfio.

Mick
Hucknall canta l’Etna
Tra
un concerto e un'esibizione trova anche il tempo per produrre del vino, del
buon vino siciliano. Mick Hucknall, voce storica del gruppo inglese dei
Simply Red, ha scovato la sua isola di Paradiso nelle pendici dell'Etna, in
una cantina-palmento del 1760 adibita a museo vitivinicolo e sala
degustazione nella zona di Sant'Alfio e in un vigneto di circa 5 ettari che
si trova ad Alberello.
 Novemila viti per ettaro, con una selezione di vitigni autoctoni etnei
(nerello mascalese, nerello cappuccio, carricante, minnella e grecanico)
perfetti per la produzione dell'Etna Doc, ma anche venticinquemila bottiglie
annue confezionate. Sono questi i numeri della sua tenuta, dalla quale
provengono l'Etna rosso, estratto dalla vigna ultra centenaria di
Castiglione di Sicilia, e l'Etna bianco che ha origine a Sant'Alfio.
Novemila viti per ettaro, con una selezione di vitigni autoctoni etnei
(nerello mascalese, nerello cappuccio, carricante, minnella e grecanico)
perfetti per la produzione dell'Etna Doc, ma anche venticinquemila bottiglie
annue confezionate. Sono questi i numeri della sua tenuta, dalla quale
provengono l'Etna rosso, estratto dalla vigna ultra centenaria di
Castiglione di Sicilia, e l'Etna bianco che ha origine a Sant'Alfio.
Cronache di Gusto ha intervistato Mick Hucknall, per parlare della Sicilia e
della sua enologia con un produttore che ha prestato il suo estro anche alla
musica.
Dopo
10 anni dal tuo investimento in Sicilia, sei ancora contento?
“Più che contento io direi che sono ancora innamorato dell'Etna, dei miei
vini e delle mie bellissime vigne ad alberello”.
Cosa
pensi del vino siciliano in genere?
“In Sicilia ho avuto modo di assaggiare tanti bei vini, ma solo pochi vini
buoni veramente siciliani”.
Quando
bevi il tuo vino?
“Nei momenti importanti, quando devo condividere un piacere o una
ricorrenza con i miei collaboratori o i miei amici. Alcune volte quando sono
solo e desidero essere sull'Etna”.
Nel
Regno Unito come hanno accolto la notizia che sei un produttore di vino?
“Direi senza tanto clamore, perchè ho cercato sempre di comunicare
questa mia passione, questo mio hobby, nell'assoluta normalità:
un'attività mia privata e non legata al mio lavoro di musicista”.
Ci
puoi suggerire uno slogan per promuovere la Sicilia o l'Etna del vino?
“Di fare dei vini veramente e culturalmente siciliani!”
Cosa
ne pensi della cucina siciliana?
“Dico spesso che la cucina francese, che amo molto, è la cucina della
domenica, mentre la cucina quotidiana è quella siciliana!”
P.Pi.
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/199-numero-159-del-01042010/4448-gg-mick-hucknall-canta-letna.html

Eruzione del 07-Ago-2014
La Chiesetta Magazzeni situata a circa 6 km dal centro abitato di
Sant'Alfio è stata eretta nel 1958 come sacro memoriale dello scampato
pericolo del paese e delle campagne, dalla eruzione del 3 Novembre 1928.
La lava che minacciava il paese mise la
popolazione in allarme, tanto che coloro i quali avevano in pericolo la
proprietà cercarono di salvare il salvabile.
La folla accorse nella Chiesa Madre invocando l'aiuto di Dio e dei Santi
Patroni.
Fu così che i più anziani rimasero nella Chiesa a pregare, mentre gli
altri partirono in processione verso Magazzeni con le sacre Reliquie dei
Santi.
Quanti avevano visto il fuoco della lava esortavano la processione a
tornare indietro dato l'incombente pericolo, ma il popolo rispondeva
abbiamo con noi i tre Santi e non abbiamo paura.
Il popolo inginocchiato gridava e supplicava Viva Sant'Alfio, la lava
fece ancora qualche passo avanti e poi si fermò.
Il 4 Novembre nella notte si apriva a quota 1300 s.l. un'altra bocca la
cui lava sommerse interamente il paese di Mascali, la coincidenza fra il
fenomeno e le preghiere elevate a Dio per intercessione dei Santi, è
stata interpretata come un fatto prodigioso.

|

scene girate ad
Acireale,
stazione Circumetnea di Giarre, Sant'Alfio
|
 |
 |


L'ALBERO
PIU' GRANDE E VECCHIO D'EUROPA - Il Castagno dei Cento
Cavalli
Autorevoli
studi botanici lo descrivono come l'albero più grande (per la sua
circonferenza di circa 52 metri) e più vecchio d'Europa (la sua età è
stimata tra i 2000 e i 4000 anni).
Testimonianza della sua vetustà sono le innumerevoli stampe e dipinti di
artisti stranieri dei secoli scorsi, che trovatesi a passare innanzi
all'albero più grande che avessero mai visto si fermavano ad immortalarne
le forme.
Il tempo, le intemperie e la cattiveria dell'uomo, hanno in qualche modo
cambiato il suo aspetto esteriore, che si presenta diviso in tre tronconi
originati da un unico ceppo.
Vero e proprio "monumento vegetale" costituisce sicuramente uno
dei motivi per andare a visitare Sant'Alfio.
In
questo modo Jean Houl dopo una sua visita al castagno dei cento cavalli ne
rese la storia. Oggi non c'è più la casa al suo interno ma tuttavia
conserva un fascino ed una floridezza inalterati, a testimonianza che spesso
, le meraviglie della natura sono superiori a quella dell'arte.
"la sua mole è tanto superiore a quella degli altri alberi, che mai si
può esprimere la sensazione provata nel descriverlo.
Mi feci inoltre, dai dotti del villaggio raccontare la storia di questo
albero si chiama dei cento cavalli in causa della vasta estensione della sua
ombra. Mi dissero come la regina Giovanna d'Aragona recandosi dalla Spagna a
Napoli, si fermasse in Sicilia e andasse a visitare l'Etna, accompagnata da
tutta la nobiltà di Catania stando a cavallo con essa, come tutto il suo
seguito. Essendo sopravvenuto un temporale, essa si rifugiò sotto
quest'albero, il cui vasto fogliame basto per riparare dalla pioggia questa
reggina e tutti i suoi cavalieri. Questo albero sì decantato e diametro
così considerevole è interamente cavo, cioè sussiste per la sua scorza,
perdendo con l'invecchiare, le parti interne e non cessando perciò di
incoronarsi di verdura. L a sua cavità essendo immensa, alcune persone del
paese costruirono una casa nella quale vi è un forno per seccarvi castagne
e mandorle"
http://www.prolocosantalfio.it/ilcastagno100cavavalli.htm
Lucio Dalla al Castagno dei Cento Cavalli per una Lectio Magistralis
5 agosto 2011 - Una
lectio magistralis tenuta da uno degli interpreti più intensi della canzone
italiana in una location di rara bellezza naturalistica.
 Nello
spiazzo attiguo al Castagno dei Cento Cavalli – un esemplare botanico tra i
più antichi d’Europa – accanto alle coltivazioni tradizionali della vite e
del nocciolo, nel territorio di Sant’Alfio, nel catanese, si è svolta, al
calar del sole, la lectio magistralis di Lucio Dalla. Nello
spiazzo attiguo al Castagno dei Cento Cavalli – un esemplare botanico tra i
più antichi d’Europa – accanto alle coltivazioni tradizionali della vite e
del nocciolo, nel territorio di Sant’Alfio, nel catanese, si è svolta, al
calar del sole, la lectio magistralis di Lucio Dalla.
L’iniziativa è stata patrocinata dalla Provincia regionale di Catania per
sviluppare il tema “il mito e leggenda tra passato e presente; la funzione
pedagogica e sociale dell’immaginario fantastico”. All’incontro hanno
partecipato l’assessore provinciale alla Pubblica istruzione Salvo
Licciardello e il consigliere provinciale Salvo Patanè.
Lucio Dalla, introdotto dal poeta Angelo Scandurra, ha accompagnato alla
tastiera l’artista Marco Alemanno che ha letto brani tratti da “Viaggio in
Sicilia e a Malta” di J. Houel, “Ricordi del viaggio In Sicilia” di E. De
Amicis, “Viaggio in Italia” di J. W. Goethe ed il “Polifemo innamorato” di
Santo Calì, la cui appassionata e magica lettura ha rapito il pubblico
presente.
Poi il momento più atteso dell’evento letterario, quando Lucio Dalla ha
dissertato sul significato profondo del mito e del valore sociale della
leggenda, anche con riferimenti al suo essere personaggio mitico.
E trattando un argomento così fortemente evocativo e dominato dal racconto
dell’immaginario fantastico, non ha potuto fare a meno di concludere con due
tra le più amate canzoni del suo vasto repertorio musicale: “Itaca” e “4
Marzo 1943.
L’assessore Licciardello, ringraziando il musicista per la sua Lectio
Magistralis ha invitato Dalla a rendersi disponibile ad altre iniziative
promosse dalla Provincia regionale di Catania. “La valorizzazione del
territorio – ha affermato l’assessore – ha bisogno di uomini straordinari
come Dalla, che ha sempre dimostrato un amore viscerale per l’Etna e i
nostri paesini pedemontani ”.
 Profumo
è la parola chiave che descrive meglio di ogni altra la pasticceria
Russo, piccolo e storico laboratorio di Sa Profumo
è la parola chiave che descrive meglio di ogni altra la pasticceria
Russo, piccolo e storico laboratorio di Sa nta
Venerina, paese etneo. Profumo di dolci, di cannella, mosto cotto,
canditi, chiodi di garofano, mandorle e liquirizia in un mix che ci
riporta indietro. Al tempo in cui a spadroneggiare non erano solo
cannoli e cassate, di cui qui per scelta non parleremo, ma i mille altri
dolci di Sicilia, quelli creati in varietà infinite nei piccoli borghi
di provincia. Delizie aromatiche, paste secche e biscotti di ogni tipo. nta
Venerina, paese etneo. Profumo di dolci, di cannella, mosto cotto,
canditi, chiodi di garofano, mandorle e liquirizia in un mix che ci
riporta indietro. Al tempo in cui a spadroneggiare non erano solo
cannoli e cassate, di cui qui per scelta non parleremo, ma i mille altri
dolci di Sicilia, quelli creati in varietà infinite nei piccoli borghi
di provincia. Delizie aromatiche, paste secche e biscotti di ogni tipo.
E’ il 1880 quando il signor Lucio, nonno dei fratelli
Russo, attuali proprietari dell’omonima pasticceria, appena
diciannovenne e figlio di ebanisti, decide di partire per Catania e
lavorare in una bottega di dolci. Gli basta un mese per fare bagaglio
della propria esperienza, ritornare al paese, aprire un suo laboratorio
e inventare i “biscotti ca’ liffia” da vendere nei battesimi organizzati
dalle famiglie benestanti.
Per ogni battesimo chili e chili di paste tra cui ne
spiccavano tre, come piramidi: uno per il parroco, uno per la levatrice
e uno per la madrina, ospiti d’onore.
Sono passati 135 anni da quel momento, ma la
specialità dei fratelli Russo è sempre la stessa. Stessa ricetta, stessa
preparazione, stesso ingrediente: la “liffia”. Cacao con aggiunta di
zucchero e acqua, un’emulsione che viene “alliffiata”, raffinata, con la
sua lavorazione. Ne viene fuori una glassa che mani sapienti fanno
scivolare sul biscotto.
Il profumo diventa allora qu ello
della storia. Tre generazioni che continuano nello stesso mestiere. A
impastare, mescolare, riempire, decorare, infornare con la calma e la
pazienza che solo i veri pasticceri e i veri artigiani possono avere. ello
della storia. Tre generazioni che continuano nello stesso mestiere. A
impastare, mescolare, riempire, decorare, infornare con la calma e la
pazienza che solo i veri pasticceri e i veri artigiani possono avere.
Da buon figlio di ebanista, il signor Lucio diede la
giusta importanza all’arredamento acquistando un mobile da una antica
farmacia in chiusura, che servisse da vetrina per i dolci e separé tra
la bottega aperta al pubblico e il piccolo laboratorio.
Quel mobile è ancora li, imponente e caldo, vigile
pastore dei dolci esposti in vetrina.
Ancora è lì, presentato con lo stesso orgoglio da
Anna, la sorella più piccola dei Russo. Un po’ in contrasto con la sala
destinata ai clienti, meno curata nei dettagli, poco accogliente e fredda
d’inverno. Un contrasto accettabile perché rispecchia autenticamente le
peculiarità dei fratelli, divenuti pasticceri contro la volontà dei loro
genitori.
Accogliente, fiera e intelligente, Anna è l’anima
della pasticceria Russo. E’ lei che tiene unita la famiglia mediando tra
il laboratorio e la sala, tra i fratelli, tra l’azienda e i clienti, tra
il passato e il futuro della pasticceria. E’ l’unica dei tre ad avere
una figlia e due nipoti, speranza di continuità di una tradizione ormai
secolare nella produzione di dolci che va preservata e tramandata.
Introverso, delicatamente schivo, Salvatore sta alla
cassa, accenna un sorriso distaccato senza mai riuscire a lasciarsi
andare. Gentile su richiesta, senza troppo pretendere, è lui che si
occupa con attenzione e meticolosa dedizione della contabilità
dell’azienda familiare.
E poi Maria Nevia. Curiosa, creativa, vivace e
testarda. La vera pasticcera: il cuore dei Russo. Infinitamente
appassionata. Da 49 anni lavora, stampa e decora la pasta reale.
Altra specialità composta da zucchero e mandorle che
insieme danno vita ad un’imitazione della natura nelle sue infinite
forme.
Una pasta che si trasforma nei frutti locali, nelle
mele dell’Etna (le cosiddette puma cola) o nelle fragole di Maletto, nei
fichi d’india, negli agrumi (mandarini e tarocchi), e poi frutta secca
come i pistacchi di Bronte.
E ancora in ortaggi, cozze, “masculine ra magghia” e
pesci di ogni tipo, tutto rigorosamente siciliano. Impossibile alla
vista distinguere tra il vero e il falso.
Dai Fratelli Russo non potete perdere la mostarda
fatta con mosto cotto, ridotto della metà, e cenere di sarmenti in
infusione. Niente zucchero aggiunto. Bastano i sarmenti (tralci di viti)
ad addolcire l’uva ed eliminarne l’acidità. Il tutto viene poi filtrato,
addensato e messo negli stampi per la stagionatura. Ne vengono prodotte
due tipologie. La mostarda fresca, consigliata
per i più golosi, è una crema gelatinosa e scura ricoperta di cannella,
da mangiare al cucchiaio. A pezzi invece quella stagionata, presentata
su foglie di alloro che anticamente avevano la funzione di allontanare
gli insetti durante la stagionatura.
In un’antica pasticceria siciliana è obbligatorio
assaggiare la cotognata. Provarla significa entrare nelle case di ogni
singola famiglia dell’isola ossessionate dalle tradizionali e cicliche
preparazioni legate ai periodi dell’anno.
Preparata con mele cotogne, frutto aspro utilizzato
solo per preparare marmellate e, per l’appunto, le cotognate, fatte
indurire in stampi di terracotta, talmente belli da diventare col tempo
oggetti di arredo.
Consigliamo di assaggiare le tortine paradiso,
versioni in miniatura della torta paradiso, inventate dal padre dei
Russo, Giuseppe, che volle trovare il modo di non buttare via i tuorli
delle uova usate per creare le paste di mandorla.
Ne vennero fuori delle tortine golose ma un po’ dure,
motivo per cui vennero in seguito ammorbidite con l’aggiunta di albume.
Da provare anche i pasticcioni o le paste secche
fatte con la “zuccata”, una zucca lunga dalla buccia verde e dalla pasta
bianca, che viene fatta decantare su sale grosso per perdere acidità e
lavorata poi con lo zucchero. Ottima anche come frutta candita.
Infine, nonostante la nostra scelta iniziale, non
possiamo fare a meno di consigliare il cannolo, meglio ancora se con
crema pasticciera e spolverata di cannella regina. Se poi fate colazione
e i vostri palati non si sono stancati di peccare di gola, prendete una
granita alla mandorla amara e un croissant al miele dell’Etna.
Lo so, siamo in Sicilia, mica in Francia, ma sappiamo
fare tutto.

Via Vittorio Emanuele, 105 – S. Venerina (CT)
Tel/Fax +39 095 953202
email: informazioni@dolcirusso.it
http://www.dissapore.com/grande-notizia/pasticceria-russo-santa-venerina-recensione/

|
Santa
Venerina (C.A.P. 95010) dista 223 Km. da
Agrigento, 151 Km. da Caltanissetta, 24 Km. da
Catania, alla cui provincia appartiene, 116 Km.
da Enna, 69 Km. da Messina,
267 Km. da Palermo, 128 Km. da Ragusa, 82 Km. da
Siracusa, 374 Km da Trapani.
Il
comune conta 7.692 abitanti e ha una superficie
di 1.879 ettari per una densità abitativa di 409
abitanti per chilometro quadrato. Sorge in una
zona litoranea collinare, posta a 337 metri
sopra il livello del mare.
Il
municipio è sito in piazza Regina Elena, tel.
095-953717 fax. 095-7001101.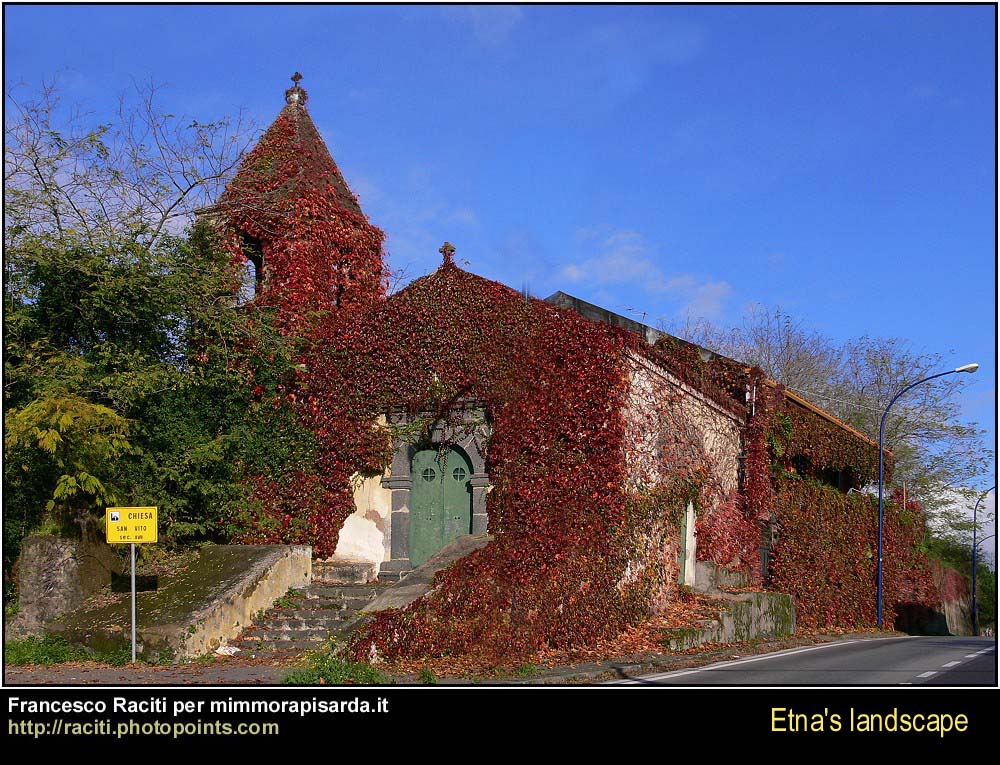
Consigliata una visita alla pasticceria
Russo.
La produzione agricola locale è basata sulla
coltivazione dell'uva da mosto, della frutta,
degli agrumi e sulle nocciole.
Già
abitato in età bizantina e romana, come
attestano resti di terme e un antico oratorio
propri di quelle epoche, il territorio di Santa
Venerina fu compreso in quello della vicina
Acireale fino al 1934 quando ottenne la
costituzione del comune. Il suo nome è legato
alla Patrona di Acireale Santa Venera modificato
da un amoroso vezzeggiativo.
Dedicata a Santa Venera è la Chiesa Matrice con
all'interno settecenteschi dipinti di Alessandro
(1720-1793) e Pietro Paolo (1697-1760) Vasta.
Nella limitrofa frazione di Dàgala del Re è
possibile ammirare resti di un tempietto
cristiano con pitture parietali.
Tra
le manifestazioni locali grande interesse desta
il Presepio Vivente che si tiene annualmente nel
mese di dicembre nella pubblica piazza.
Per
arrivare a Santa Venerina da Catania, nel modo
più veloce, bisogna uscire al casello di Giarre
dell'Autostrada Catania-Messina. |
|

IL VANTO DI SANTA
VENERINA SONO DUE FAMIGLIE.
NON SONO PARENTI TRA
LORO, MA IL LORO COGNOME E' UN MARCHIO DI QUALITA'.
|
 DISTILLERIA
RUSSO DISTILLERIA
RUSSO
La Distilleria
Fratelli Russo, le cui origini risalgono al lontano 1870,
sorge su una ridente collina ai piedi dell'Etna, non lontano
dall'incantevole costa ionica, nel paese di S.Venerina, in
provincia di Catania.
Attraverso varie generazioni essa ha continuato e sempre più
perfezionato nel tempo l'antica arte dei mastri distillatori
isolani. Attualmente i fratelli Salvatore e Giuseppe hanno
apportato all'azienda di famiglia notevoli innovazioni. Il
nuovo impianto di distillazione, utilizzando tecnologie
all'avanguardia, ha permesso loro di produrre in proprio,
nel pieno rispetto dell'ambiente e con un notevole risparmio
energetico, distillati di grande pregio e di altissima
qualità che si pongono in modo competitivo nei mercati
internazionali.
Attraverso la produzione di distillati, di liquori tipici e
di rosoli artigianali, l'azienda si è posta l'obiettivo di
custodire la tradizione, esaltare le fragranze di Sicilia ed
esprimere amore alla propria terra nella garanzia della
genuinità e della qualità. Le materie prime impiegate
(agrumi, erbe, frutti vari) provengono, ove possibile, da
coltivazioni biologiche. Appena raccolte, esse vengono
subito lavorate con metodi artigianali, così da mantenere
intatti i loro inconfondibili aromi e le loro proprietà
benefiche.
L'azienda,
grazie all'impegno profuso nel rivalutare e nel far rivivere
le più antiche ricette della tradizione siciliana, ha
ottenuto lusinghieri riconoscimenti a carattere
internazionale.
La Grappa dell'Etna è stata premiata nel 2000 con la
medaglia d'argento a Pechino, e ha vinto nel 2005, ad Asti,
insieme alla Grappa di Moscato di Pantelleria, l'Alambicco
d'oro, premio di eccellenza delle Grappe, promosso dall'
Anag, riconoscimento già ottenuto nel 2003 dalla Grappa di
Nero d'Avola. Il Limoncello di Sicilia è stato premiato nel
2003 con la medaglia d'oro a Shanghai. Il Rosolio di
Cannella ha ottenuto la medaglia d'argento a Londra nel 2003
e in Germania nel 2004. L'Amaro di Sicilia è stato premiato
nel 2004 a Bruxelles con la medaglia d'oro.
riportando
ovunque consensi unanimi. Il consumatore sa di potersi
fidare della ditta Russo perchè è sicuro di poter contare su
anni di esperienza e sulla serietà e professionalità che da
sempre la contraddistinguono.
http://www.russo.it
DOLCI RUSSO
Santa Venerina è
un piccolo paesino ai piedi dell'Etna, eppure giungono qui
persone da tutta la Sicilia, ma anche dall'estero, una
clientela esigente e selezionata, per assaggiare i dolci buonissimi della Pasticceria Russo. L'attività della
pasticceria inizia nel 1880 su iniziativa di Lucio, nonno
degli attuali titolari, i fratelli Lucio, Nevia, Annamaria e
Salvatore. Siamo quindi alla terza generazione di
pasticceri. I fratelli Russo puntano, da sempre, sulla
qualità delle materie prime e sul rispetto dei metodi
tradizionali nella preparazione dei dolci. Gli aromi
speziati della cannella, dei chiodi di garofano, delle
mandorle, dei pistacchi, degli agrumi della terra etnea...
rivivono qui tra gli arredi in stile liberty e gli oggetti
sparsi un po' per tutta la pasticceria.
buonissimi della Pasticceria Russo. L'attività della
pasticceria inizia nel 1880 su iniziativa di Lucio, nonno
degli attuali titolari, i fratelli Lucio, Nevia, Annamaria e
Salvatore. Siamo quindi alla terza generazione di
pasticceri. I fratelli Russo puntano, da sempre, sulla
qualità delle materie prime e sul rispetto dei metodi
tradizionali nella preparazione dei dolci. Gli aromi
speziati della cannella, dei chiodi di garofano, delle
mandorle, dei pistacchi, degli agrumi della terra etnea...
rivivono qui tra gli arredi in stile liberty e gli oggetti
sparsi un po' per tutta la pasticceria.
Troverete tutti quei dolci che prima si facevano in casa e
che ora nessuno sa fare più.
Per esempio i
mustazzoli col vin cotto. Oppure le mostarde di uva: una
specie di budino secco fatto appunto col mosto d'uva, da
mangiare sia calde al piatto che stagionate. Bellissima e
buonissima la frutta dpasta reale sapientemente lavorata e
colorata da autentici artisti. La cotognata aromatizzata con
l'alloro, i biscottini al sesamo, i biscotti di mandorla
classici o con aggiunta di cioccolato, nocciola, pistacchio,
limone, arancia, mandarino.In primavera-estate i gelati,
specialmente le granite nei gusti tradizionali: mandorla,
caffè, cioccolato, limone, o alla frutta: fragola, pesca,
gelsi, con o senza la panna, ma sempre accompagnata dalle
fragranti brioche o dai croissant al miele, davvero
irresistibili. Ci sono poi le cuddure (tradizionali
ciambelle pasquali) e gli immancabili cannuoli. Attenzione,
però, dalla pasticceria Russo le sfoglie dei cannuoli
vengono fatte a mano e tirate ad una ad una col mattarello.
Sono buonissimi e sprigionano un profumo inconfondibile che
delizia l'olfatto e il palato appena si entra nella
pasticceria. Ed è questo profumo, il profumo della
tradizione, il profumo della passione di chi ci lavora, il
profumo della genuinità... il vero segreto della pasticceria
Russo che, infatti, non ha bisogno di pubblicità: basta il
passaparola. Quasi tutti i dolci sono spediti in eleganti
confezioni di latta, cosicché la "dolcepassione" possa
essere assaporata da tutti ancora per molti giorni.
Aperto tutti i giorni dalla 7.30 alle 14 e dalle 15.30 alle
22. Domenica orario continuato.
http://www.dolcirusso.it/
 |




|
Il
Parco dell'Etna è stato il primo ad essere istituito in Sicilia
nel marzo del 1987. Non èun caso. L'Etna infatti non è soltanto
il vulcano attivo più alto d'Europa, ma una montagna dove sono
presenti colate laviche recenti, in cui ancora non si è insediata
alcuna forma di vita, e colate antichissime su cui sono presenti
formazioni naturali di Pino laricio, Faggio e Betulla.
Per proteggere questo ambiente naturale unico e lo straordinario
paesaggio circostante, marcato dalla presenza dell'uomo, il Parco
dell'Etna, è stato diviso in quattro zone.
Nella zona "A", 19.000 ettari, quasi tutti di proprietà
pubblica, non ci sono insediamenti umani. E' l'area dei grandi
spazi incontaminati, regno dei grandi rapaci tra cui l'aquila
reale.
La zona "B", 26.000 ettari, è formata in parte da
piccoli appezzamenti agricoli privati ed è contrassegnata da
splendidi esempi di antiche case contadine, frugali ricoveri per
animali, palmenti, austere case padronali, segno di una antica
presenza umana che continua tutt'ora. Oltre alle zone di Parco A e
B, c'è un'area di pre-parco nelle zone "C" e
"D": 14.000 ettari, per consentire anche eventuali
insediamenti turistici sempre nel rispetto della salvaguardia del
paesaggio e della natura.

La Geologia
L'Etna
rappresenta una speciale "finestra astenosferica"
causata dal processo di convergenza litosferica tra l'Africa e
l'Eurasia e la sua evoluzione strutturale e profondamente legata
alla geodinamica del bacino del Mediterraneo. Con i suoi 135 km di
perimetro, si è sviluppata, modificata, distrutta e ricostruita
attraverso una molteplicità di eventi geologici che si sono
succeduti nel corso di molte decine di migliaia di anni. L'inizio
dell'affascinante storia di questo complesso vulcanico è del
Pleistocene medio-inferiore: 570000-600.000 anni fa, quando hanno
avuto luogo le prime manifestazioni eruttive. In quel tempo,
l'area nella quale siamo soliti vedere gli abitati di Acicastello,
Acitrezza, Ficarazzi era occupata da un ampio golfo marino
interessato da un'intensa attività vulcanica sottomarina.

Molto
tempo dopo, attraverso lunghe fessure eruttive lineari, si poteva
assistere alla formazione di estesi campi di lave che oggi
ritroviamo come terrazzi posti a varia quota nell'area geografica
su cui sorgono gli abitati di Valcorrente, S. Maria di Licodia,
Biancavilla e Adrano. Seguì un vulcanismo di tipo centrale che
portò all'edificazione di imponenti edifici vulcanici noti come,
Calanna, Zoccolaro, Trifoglietto, Vavalaci, Cuvigghiuni, Pirciata,
Giannicola, Ellittico, Mongibello.
La Serra del Salifizio e la Serra delle Concazze, delimitano
l'enorme anfiteatro naturale della Valle del Bove, dalla
caratteristica forma "a ferro di cavallo" (superficie
superiore ai 37 kmq). Quest'affascinante e selvaggio ambiente
naturale con le sue alte pareti scoscese, le testate di antichi
banchi lavici, costoni rocciosi, Serre e dicchi magmatici,
canaloni, apparati eruttivi, colate laviche, rappresenta la
testimonianza geologica della poligenesi dell'Etna.

Blocchi
e frammenti di aspetto scoriaceo variamente disarticolati con una
morfologia a creste ed avvallamenti allungati a contrassegnare i
canali di flusso della colata (Lave aa); Superfici arricciate a
simulare festoni o costituite da un fitto intreccio di cordoni
lavici che creano bizzarri disegni (Lave pahoehoe); lastroni
variamente disarticolati ed accatastati, che danno origine a
rilievi tumuliformi o creste; lastroni piani più o meno regolari,
creati dall'immediato raffreddamento di lave fluide sollevate
all'improvviso dall'azione di grandi "bolle" di gas
(lave a dammuso); spesso, su queste sciare, si formano dei sistemi
di deflusso lavico racchiusi entro un involucro basaltico, che,
nel periodo finale dell'attività effusiva, si svuotano dando
luogo a tubi, grotte e gallerie di scorrimento. regolari,
creati dall'immediato raffreddamento di lave fluide sollevate
all'improvviso dall'azione di grandi "bolle" di gas
(lave a dammuso); spesso, su queste sciare, si formano dei sistemi
di deflusso lavico racchiusi entro un involucro basaltico, che,
nel periodo finale dell'attività effusiva, si svuotano dando
luogo a tubi, grotte e gallerie di scorrimento.
La
Fauna
Circa
un secolo e mezzo fa il Galvagni, descrivendo la fauna del'Etna,
raccontava della presenza di animali ormai scomparsi e divenuti
per noi mitici: lupi, cinghiali, daini e caprioli. Ma l'apertura
di nuove strade rotabili, il disboscamento selvaggio e l'esercizio
della caccia hanno portato all'estinzione di questi grandi
mammiferi e continuano a minacciare la vita delle altre specie.
Nonostante ciò sul vulcano vivono ancora l'istrice, la volpe, il
gatto selvatico, la Martora, il coniglio, la lepre e, fra gli
animali più piccoli, la donnola, il riccio, il ghiro, il quercino
e varie specie di topi e pipistrelli.
Moltissimi sono gli uccelli ed in particolare i rapaci che
testimoniano dell'esistenza di ampi spazi incontaminati: tra i
rapaci diurni troviamo lo sparviero, la poiana, il gheppio, il
falco pellegrino e l'aquila reale; tra i notturni il barbagianni,
l'assiolo, le allocco, il gufo comune. Aironi, anatre ed altri
uccelli acquatici si possono osservare nel lago Gurrida, unica
distesa d'acqua dell'area montana etnea. Nelle zone boscose è
possibile intravedere la ghiandaia, il colombo selvatico e la
coturnice che si mischiano ad una miriade di uccelli canori quali
le silvie, le cince, il cuculo e tanti altri, mentre sulle distese
laviche alle quote più alte il culbianco vi sorprenderà con i
suoi voli rapidi ed irregolari. Tra le diverse specie di serpenti,
che con il ramarro e la lucertola popolano il sottobosco, l'unica
pericolosa è la vipera la cui presenza, negli ultimi anni, è
aumentata a causa della distruzione dei suoi predatori. Infine, ma
non per questo meno importante, vi è il fantastico, multiforme
universo degli insetti e degli altri artropodi: farfalle, grilli,
cavallette, cicale, api, gagni ecc. con il loro fondamentale e
insostituibile ruolo negli equilibri ecologici.

La Vegetazione
L'universo
vegetale dell'Etna si presenta caratterizzato da un insieme di
fattori tra i quali ha un ruolo predominante la natura vulcanica
della montagna. La flora del Parco, estremamente varia e ricca,
condiziona il paesaggio offrendo continui e repentini mutamenti;
ciòdipende dalla diversa compattezza e dal continuo
rimaneggiamento del substrato ad opera delle colate laviche che si
succedono nel tempo, nonchèdal variare delle temperature e delle
precipitazioni in relazione all'altitudine ed all'esposizione dei
versanti. Partendo dai piani altitudinali piùbassi, dove un tempo
erano le foreste di leccio, ecco i vigneti, i noccioleti ed ancora
i boschi di querce, pometi e castagni. Intorno ed anche oltre i
2.000 metri troviamo il Faggio che, in Sicilia, raggiunge il suo
limite meridionale e la betulla che è considerata dalla maggior
parte degli autori un'entità endemica.
Oltre la vegetazione boschiva il paesaggio si modifica ed è
caratterizzato da formazioni pulviniformi di spino santo
(astragalo) che offrono riparo ad altre piante della montagna
etnea quali il senecio, la viola e il cerastio. Al di sopra del
limite dell'astragalo, tra i 2.450 ed i 3.000 metri solo
pochissimi elementi riescono a sopravvivere alle condizioni
ambientali dell'alta montagna etnea. Al di sopra di queste quote e
sino alla sommità si stende il deserto vulcanico dove nessuna
forma vegetale riesce a mantenersi in vita.
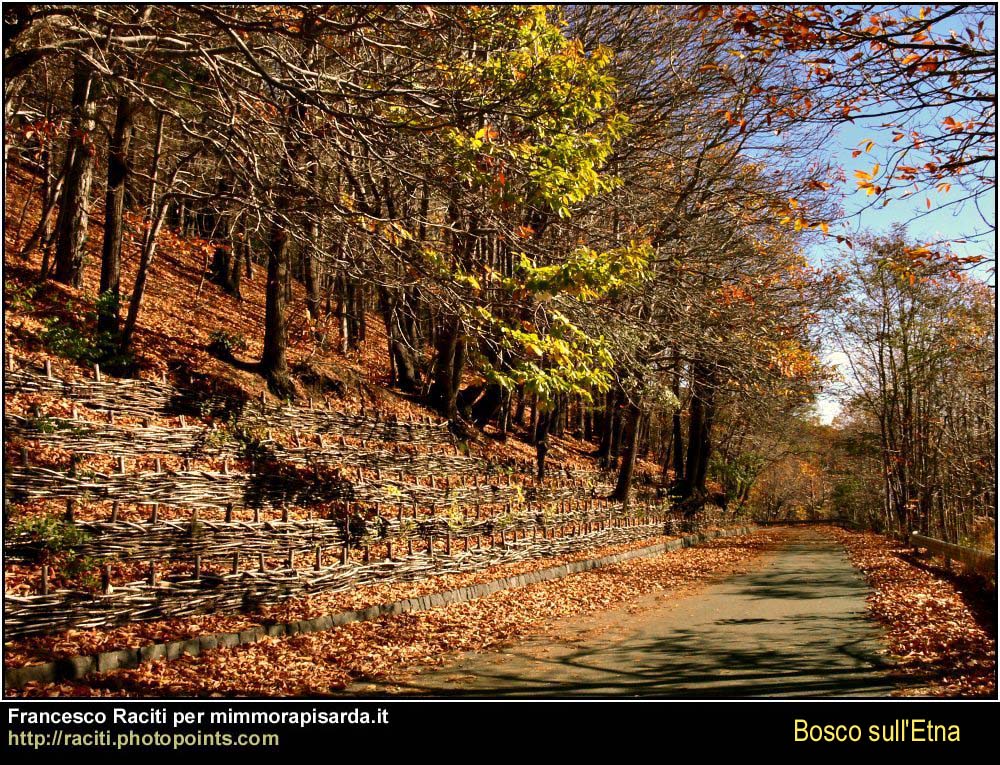
L'agricoltura
Fin
da epoche remote la ricchezza del suolo vulcanico ha permesso alle
popolazioni etnee di vivere di agricoltura e allevamento,
costruendo un ambiente "dell'uomo" armonicamente
inserito in quello naturale. Paesaggi agricoli sorprendenti e
multiformi sono incastonati fra boschi e colate laviche, formando
così un mosaico ambientale di rara bellezza.
 La
presenza millenaria dell'uomo sul vulcano ha lasciato un'impronta
profonda: monumentali opere di terrazzamento, magazzini, palmenti,
cantine costellano le pendici della "Montagna". Pertanto
il mantenimento e il recupero dell'agricoltura svolta in sintonia
con le esigenze di tutela ambientale diventano strumento efficace
per il mantenimento di una parte importante del paesaggio etneo.
In questo contesto, il Parco dell'Etna guarda con particolare
attenzione all'agricoltura biologica, metodo di coltivazione
capace di offrire prodotti sani nel rispetto dell'ambiente e dalla
salute degli agricoltori. La
presenza millenaria dell'uomo sul vulcano ha lasciato un'impronta
profonda: monumentali opere di terrazzamento, magazzini, palmenti,
cantine costellano le pendici della "Montagna". Pertanto
il mantenimento e il recupero dell'agricoltura svolta in sintonia
con le esigenze di tutela ambientale diventano strumento efficace
per il mantenimento di una parte importante del paesaggio etneo.
In questo contesto, il Parco dell'Etna guarda con particolare
attenzione all'agricoltura biologica, metodo di coltivazione
capace di offrire prodotti sani nel rispetto dell'ambiente e dalla
salute degli agricoltori.
Oggi vigneti, oliveti, pistacchieti, noccioleti e frutteti
circondano il vulcano testimoniando una vocazione agricola del
territorio ampiamente diffusa e caratterizzata dalla presenza di
varietà locali particolarmente interessanti. Basti pensare alle
mele "Cola", "Gelato" e
"Cola-Gelato" piccole, gialle e fragranti o alle pere
autunnali come la "Ucciardona" o la "Spinella"
utilizzata nella cucina tradizionale. La ricchezza varietale delle
specie coltivate sull'Etna è un patrimonio di biodiversità da
tutelare e diffondere per mantenere un'eredità importante che
può diventare la nota distintiva dell'agricoltura del Parco.
La Viticoltura
Il
particolare microclima del comprensorio etneo ha caratterizzato la
coltura della vite e la produzione di vino sin dall'antichità. Le
popolazioni etnee debbono alla vite e al vino una parte
determinante della propria civiltà. Le vigne etnee, nel tempo,
hanno subito numerose e profonde trasformazioni e sono divenute un
elemento caratterizzante del paesaggio antropico. La viticoltura
etnea, essendo di collina e di montagna, si sviluppa su terreni
sistemati a "terrazze" di piccola e media larghezza.
Generalmente, all'interno dei vigneti, si trovano manufatti rurali
che possono comprendere "palmenti" (parte del fabbricato
destinato alla lavorazione delle uve) e cantine.
Un DPR del 1968 ha concesso ai vini dell'Etna la DOC
"Etna" (Bianco Superiore, Bianco, Rosso e Rosato),
interessando i territori di ventuno comuni etnei. Di questi, ben
diciassette rientrano nel comprensorio del Parco.

L'Ente Parco, mirando all'integrazione tra protezione ambientale e
promozione delle attività economiche, tutela e promuove la
vitivinicoltura etnea quale "inestimabile patrimonio
ereditato" da custodire, valorizzare e far conoscere e quale
settore economico di primaria importanza. Obiettivo raggiungibile
attraverso la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale
etneo, l'incentivazione al miglioramento e alla stabilizzazione
dei parametri qualitativi delle produzioni e la promozione
dell'immagine del prodotto legato al suo territorio. Di pari passo
con molteplici iniziative tecnico-amministrative, rivolte al
settore e con l'adesione in qualità di socio ad Organismi quali
il CERVIM (Centro di Ricerche, Studi e Valorizzazione per la
Viticoltura Montana), l'Associazione Nazionale "Città del
Vino" e la "Strada del Vino dell'Etna", l'Ente
Parco promuove svariate manifestazioni di notevole interesse
regionale, nazionale e internazionale.
http://www.parks.it/parco.etna/par.php
http://www.parcoetna.it/
|

La
Valle del Bove è un’immensa depressione di origine vulcanotettonica
posta sul fianco orientale dell’Etna derivata dallo sprofondamento di
antichi complessi eruttivi. E’ una delle emergenze naturalistiche più
importanti del Parco. Ha una forma a ferro di cavallo con un fondo
pressoché piatto che degrada verso Est. E’ delimitata a Nord, Ovest e
Sud da tre ripide pareti costituite da un’alternanza di colate laviche
e prodotti piroclastici eruttati a partire da 50.000 anni fa. La sua
superficie è di circa 24 Kmq con una lunghezza di 6 Km circa lungo la
direzione Nord – Sud. Nella parete occidentale si trova la Serra
Giannicola Grande: un’area di eccezionale interesse vulcanologico per
la presenza dei “dicchi”. Sono lunghi muraglioni di roccia che
costituiscono uno scenario di straordinaria bellezza.
Il paesaggio della
valle è selvatico, per la presenza di numerose colate laviche storiche,
tra cui la colata del 1991- 1993, con una morfologia aspra e irregolare.
Il silenzio è il grande dominatore della valle. Ad interromperlo solo
il rumore del vento, delle esplosioni vulcaniche, della caduta di massi
e il canto degli uccelli.

Non si può dire di aver visto veramente l'Etna se non ci si affaccia
sulla Valle del Bove. Questa fantastica caldera di collasso , la cui
origine sembra essere stata causata dallo sprofondamento di uno dei
crateri più vecchi dell'Etna, si può ammirare da molteplici punti di
osservazione, ma uno dei panorami più belli sicuramente si gode dalla
Schiena dell'Asino.
L'itinerario
parte dalla strada provinciale 92. Lasciata l'auto dal bivio tra le
strade provinciali che salgono da Pedara e Zafferana, a circa un
chilometro dal rifugio Sapienza, si supera la sbarra della forestale e
il cartello che indica l'inzio del sentiero. Il percorso inizia con una
forte pendenza che degrada dopo circa 600 metri. Dopo di che si
lasceranno i pini larici e si dovrà continuare a camminare attraverso
un paesaggio lunare colorato da pulvini di saponaria, romice e
astragalo.
Superato l'ultimo pianoro sarà infine possibile ammirar, in tutta la
sua maestosità, la Valle del Bove. Ilpunto panoramico si presta bene
anche per l'osservazione di eventuali eruzioni.

Piano
del Lago, inebriante terrazzino dall'orlo della Valle
|
Escursioni della Valle del Bove
PIANO
DELL'ACQUA - MONTE CALANNA
Caratteristiche:
Difficoltà:
escursione di media difficoltà, Quota
di partenza: 830 m/slm, Dislivello:
180 m
Lunghezza
del percorso: circa 1100 m, Tempo
di percorrenza: h. 1,30 circa, Punti
di osservazione: 5
 Il
sentiero è localizzato nel versante orientale dellEtna ed è
raggiungibile dallabitato di Zafferana Etnea, seguendo le indicazioni che
conducono al fronte della colata lavica 1991/93. Il
sentiero è localizzato nel versante orientale dellEtna ed è
raggiungibile dallabitato di Zafferana Etnea, seguendo le indicazioni che
conducono al fronte della colata lavica 1991/93.
Percorsa
interamente la stradella in basolato lavico (circa 800metri) si arriva ad
un piccolo pianoro a circa 830 msl da cui ha inizio un sentiero che si
sviluppa per oltre un chilometro e per circa 200 metri di dislivello.
Laspetto
prevalente è costituito dagli imponenti ammassi lavici delleruzione
laterale che consentono allescursionista di vivere un paesaggio
primordiale.
Ai
margini del sentiero si notano ancora i segni del precedente paesaggio
vegetale costellato da in basso da tipici frutteti (pometi, ciliegeti,
etc.) sostituiti in quota da piccoli isolotti ("dagale") a
prevalenza di Ginestre. Rare le essenze arboree presenti per lo più con
sparuti esemplari di Roverella, Leccio, Frassino e talora da piccole
cenosi di Pioppo tremulo.
Leruzione
1991/93, durante 473 giorni di attività, ha emesso oltre 300 milioni di
metri cubi di lave e ricoperto oltre sette kmq di superficie. Uno sciame
sismico e una intensa esplosivo effusiva diede origine ad una delle più
imponenti eruzioni laterali degli ultimi 300 anni, ricordata anche per gli
interventi di protezione civile.
Lungo
il sentiero sono posti dei pilieri in pietra lavica con sovrimpressi i
numeri da 1 a 5 che segnalano Punti di Osservazione con particolari
caratteristiche.
P.O.
1
Colata
1991-93 - particolari della solidificazione di superficie delle lave lungo
le fessure eruttive (a lastro ni, a catasta). Si osservano le diverse fasi
della colonizzazione delle colate: si passa dalle rocce rese grigiastre
dalla presenza dello Stereocaulon vesuvionum, un tenace Lichene
incrostante, agli anfratti rocciosi con Felci e piccole Graminacee; ai
terreni rocciosi in cui domina la Ginestra dellEtna (Genista aetnensis),
lElicriso (Helicrysum italicum), la Valeriana rossa (Centranthus ruber),
la Scrofularia canina (Scrophularia canina) che con la loro presenza
conferiscono a questi ambienti una straordinaria varietà di colori e
profumi. ni, a catasta). Si osservano le diverse fasi
della colonizzazione delle colate: si passa dalle rocce rese grigiastre
dalla presenza dello Stereocaulon vesuvionum, un tenace Lichene
incrostante, agli anfratti rocciosi con Felci e piccole Graminacee; ai
terreni rocciosi in cui domina la Ginestra dellEtna (Genista aetnensis),
lElicriso (Helicrysum italicum), la Valeriana rossa (Centranthus ruber),
la Scrofularia canina (Scrophularia canina) che con la loro presenza
conferiscono a questi ambienti una straordinaria varietà di colori e
profumi.
P.O.
2
Si
incomincia ad intravedere Monte Calanna nell'omonima ex valle tra le lave
del 1991-93. A valle si osserva l'abitato di Zafferana Etnea. L'aspetto
vegetazionale dei costoni che delineano l'ex Val Calanna, è
caratterizzato da una lussureggiante copertura boschiva mista, con
prevalenza di Faggio (Fagus silvatica).
P.O.
3
Si
osservano Monte Calanna, il Salto della Giumenta, la colata del 1991-93,
la Serra delle Concazze e del Salifizio - nelle cui pareti rocciose è
scritta buona parte della complessa storia di questo straordinario Vulcano
poligenico - Rocca Musarra (1632 m/slm dalla caratteristica forma a
"dente") e Rocca Capra (resti di antichi collassi calderici che
hanno interessato le unità del Trifoglietto); vista dei Crateri sommitali.

P.O.
4
Il
paesaggio è dominato da un bellissimo campo di ginestre, oltre il quale
si osserva Piano-Bello e in lontananza, Monte Fontane. Dalla parte opposta
Monte Zoccolaro. In primo piano le morfologie superficiali dell'eruzione
del 1950-51. La Serra del Salifizio e la Serra delle Concazze delimitano
quell'enorme anfiteatro naturale dalla caratteristica forma a "ferro
di cavallo": la Valle del Bove (perimetro 18 km - superficie 37 kmq)
che rappresenta uno dei più affascinanti e selvaggi ambienti naturali del
Parco dell'Etna.
Il
recinto calderico è costituito a Nord e a Sud da alte pareti scoscese,
con altezze comprese tra i 400 e i 1000 m. Queste pareti subverticali
includono le testate di antichi banchi lavici che con pendenze varie si
immergono in direzione opposta alla Valle e costoni rocciosi noti come
Serre. Alle Serre si alternano i Canaloni, incisioni vallive dove si
accumulano i detriti provenienti dallo smantellamento dei banchi lavici e
che danno luogo, a valle, ad estesi conoidi di deiezione.
P.O.
5
 Portella
Calanna - Localizzazione delle dighe di contenimento durante l'eruzione
1991-93. Il 2 maggio 1992, per proteggere l'abitato di Zafferana Etnea, la
Protezione civile intraprese la costruzione di un importante rilevato in
terra lungo 234 m ed alto 21 m. La tettonica regionale ha fortemente
dislocato quest'area, ormai completamente ricoperta dai prodotti
dell'eruzione 1991-93. La Val Calanna si è formata per coalescenza di
caldere di collasso di edifici vulcanici ascrivibili ai Centri Eruttivi
Alcalini Antichi. Il Salto della Giumenta che divide la Valle Calanna
dalla Valle del Bove rappresenta il più evidente di questi elementi
morfologico-strutturali. Portella
Calanna - Localizzazione delle dighe di contenimento durante l'eruzione
1991-93. Il 2 maggio 1992, per proteggere l'abitato di Zafferana Etnea, la
Protezione civile intraprese la costruzione di un importante rilevato in
terra lungo 234 m ed alto 21 m. La tettonica regionale ha fortemente
dislocato quest'area, ormai completamente ricoperta dai prodotti
dell'eruzione 1991-93. La Val Calanna si è formata per coalescenza di
caldere di collasso di edifici vulcanici ascrivibili ai Centri Eruttivi
Alcalini Antichi. Il Salto della Giumenta che divide la Valle Calanna
dalla Valle del Bove rappresenta il più evidente di questi elementi
morfologico-strutturali.
Da
qui i più volenterosi attraverso le sciare delleruzione 1852/53, potranno
arrivare alla base di Monte Calanna, costituito da livelli lavici e
potenti banchi di scorie attraversati da numerosi dicchi fortemente
alterati.
Consigli
e attrezzatura:
Curare
labbigliamento in funzione del clima e del particolare morfologia del
terreno: il vestiario dovrebbe essere comodo, tanto da consentire libertà
di movimento, ma robusto per evitare graffi. Le scarpe potranno essere
più o meno pesanti purché fornite di una buona suola per affrontare il
terreno lavico.
Non
uscire dal sentiero segnalato. Potreste recare disturbo alla vegetazione
ed agli animali.
Il
sentiero attraversa unarea protetta. Non buttare carta ed oggetti, non
estirpare o danneggiare piante, non raccogliere fiori, non accendere
fuochi. Fate in modo che chi visiterà il sentiero dopo di voi non si
accorga del vostro passaggio.
Consigli
e attrezzatura:
Vista
la presenza di varie specie volatili vi invitiamo a percorrere il sentiero
in silenzio, per evitare di disturbare la fauna presente al momento e di
osservare la stessa dai capanni. E' indispensabile l'uso di un binocolo e
di teleobiettivi per una migliore osservazione delle varie specie.
Non
uscire dal sentiero segnalato. Il sentiero attraversa unarea protetta. Non
buttare carta ed oggetti, non estirpare o danneggiare piante,hich non
raccogliere fiori, non accendere fuochi. Fate in modo che chi visiterà il
sentiero dopo di voi non si accorga del vostro passaggio.

|
 |
SE
VUOI RESTARE IN ZONA
SUL
VERSANTE SUD, METTI LA FRECCIA A SINISTRA. |

|
numeri
utili
AZIENDA FORESTE DEMANIALI Via Etnea 353 - Catania www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Azforeste/
Tel. 095.7282211 329.0036136 (numero di servizio)
CAI CATANIA Via Messina 593/A Catania www.caicatania.it
Tel. 095.7153515
CAI LINGUAGLOSSA Piazza Municipio - Linguaglossa (CT)
info@cailinguaglossa.com
tel. 3495354987
www.cailinguaglossa.com
RIFUGIO RAGABO strada Mareneve - Linguaglossa (CT)
www.ragabo.it Tel. 095.647841 -
339.6150989
BRUNEK strada Mareneve - Linguaglossa (CT) www.rifugio-brunek.it
Tel. 095.643015 349.8895578
RIFUGIO ARIEL Contrada Serra La Nave Ragalna (CT) www.rifugioariel.it
Tel. 393.8478621
RIFUGIO
CITELLI Contrada Citelli - Sant’Alfio (CT) www.rifugiocitelli.net
Tel. 095.930000 - 348.9546409
RIFUGIO SAPIENZA Piazzale Rifugio Sapienza Etna Sud Nicolosi (CT) www.rifugiosapienza.com
Tel. 095915321

 Linguaglossa
(m 550 s.l.m., 5534 ab., 58,38 kmq) si trova alle pendici nord orientali
dell’Etna, nella radura sottostante il meraviglioso Bosco Ragabo.
Il nucleo storico si è sviluppato a ridosso della reggia
trazzera, in passato importante via verso l’interno dell’isola.
Da qui transitavano il legname e la resina provenienti dalla
Pineta e diretta agli imbarchi jonici. Il toponimo
Linguagrossa compare in un documento del 1145, quando Ruggero d’Altavilla
stabilisce i confini per l’archimandrita di Messina, e la fondazione dei
primi borghi è di certo medievale. Resti di epoca
anteriore, rinvenuti nei colli vicini, dimostrano la frequentazione di
questa regione fin dall’antichità. Linguaglossa
(m 550 s.l.m., 5534 ab., 58,38 kmq) si trova alle pendici nord orientali
dell’Etna, nella radura sottostante il meraviglioso Bosco Ragabo.
Il nucleo storico si è sviluppato a ridosso della reggia
trazzera, in passato importante via verso l’interno dell’isola.
Da qui transitavano il legname e la resina provenienti dalla
Pineta e diretta agli imbarchi jonici. Il toponimo
Linguagrossa compare in un documento del 1145, quando Ruggero d’Altavilla
stabilisce i confini per l’archimandrita di Messina, e la fondazione dei
primi borghi è di certo medievale. Resti di epoca
anteriore, rinvenuti nei colli vicini, dimostrano la frequentazione di
questa regione fin dall’antichità.
Dopo i Vespri (1282), gli aragonesi assegnarono queste terre a
Ruggero di Lauria (1245 – 1304), ammiraglio della flotta
siculo- aragonese, per le sue imprese militari contro gli angioini.
Linguaglossa da tempo forniva legname e pece per l’Arsenale di
Messina. Per un periodo fu feudo dei Filangieri,
per poi essere data da re Martino in lunga concessione alla famiglia
Crisafi (1392 – 1568), i quali rivestivano già pubblici
incarichi a Messina. Passò poi come baronia ai Cottone
(1568), ai Patti (1579), ed infine ai Bonanno
e Gioieni (i Gioieni da secoli possedevano le terre di Castiglione) con
Don Orazio (1606), ottenendo il titolo di principato nel 1626
(periodo in cui furono venduti in Sicilia nuovi titoli con relativi
diritti giurisdizionali). Nel 1634, in piena Guerra dei
Trent’anni, Filippo IV di Spagna, in seguito ad un considerevole esborso
di denaro, dichiarò Linguaglossa città diletta e libera.
Attorno al toponimo LINGUAGROSSA (riportato sul prospetto del
Palazzo Municipale) sono fiorite diverse ipotesi. Qui ricordiamo quella
che identifica le prime genti che vi abitarono come “chiddi da lingua
rossa”; un’altra riconduce ad una lingua di lava che si spinse fin qui,
sulla quale si edificò il borgo antico; senza dimenticare il promontorio
e la striscia di terreno alluvionale coltivato lungo il torrente
percorsi da un’antica trazzera.
Il borgo medievale più antico è quello intorno alla
chiesa di S.Egidio. il paese si distingue per un centro storico
ben conservato, con numerosi vicoli profumati di
gelsomino e vetusti portali (anche preesistenti il
terremoto del 1693), qualche edificio barocco e l’alternanza di
pietra lavica dell’Etna (basamenti, finestroni, mascheroni) e
di arenaria e tufo provenienti dalle
vicine alture. Ma ciò che caratterizza il centro sono i bei
palazzetti tardo-ottocenteschi e Liberty che
prospettano sulla via principale e sulle piazze. Così il Palazzo
comunale, opera di Pietro Grassi (1907), con eleganti bifore
mitrate.
Linguaglossa è anche e soprattutto
la montagna: l'Etna.
Linguaglossa è infatti una stazione
turistica estiva ed invernale di livello internazionale.
La pineta di Linguaglossa e Piano Provenzana sono punto d’incontro per
gli appassionati dello sci alpino, sci di fondo e lo sci d’alpinismo. In
estate da Piano Provenzana si possono raggiungere le zone sommitali
del Vulcano, con i mezzi fuoristrada della Società S.T.A.R., nonché per
itinerari naturali nati lungo percorsi di rara bellezza. Linguaglossa si
compiace dell'abbraccio che il vulcano ha voluto riservarle cingendolo
col verde di una vegetazione mozzafiato. E' la natura l'impareggiabile
ricchezza del paese di Linguaglossa, con l'Etna che fuma in alto
e lo scintillio dello Ionio in basso.
http://www.prolocolinguaglossa.it/comune.htm

La
Pineta Ragabo a Mareneve.
I due
paesi sono maggiormente conosciuti per le attrattive
naturalistiche, dal momento che buona parte del
territorio e' inclusa nel Parco dell'Etna. Salendo
da Linguaglossa per la Provinciale Mareneve si
giunge a
2.1 -
Piano Provenzana, a circa 1900 m. di quota:
momentaneamente non raggiungibile a causa
dell'eruzione dell'ottobre 2002. Costituisce la base
di partenza per le escursioni alle bocche del
vulcano (con i mezzi autorizzati della S.T.A.R.
oppure a piedi). Qui troviamo diversi alberghi,
ristoranti, bar, rivendite di souvenir, ma
soprattutto 5 ski-lift ed una bella pista per lo sci
da fondo. Riscendendo a Linguaglossa dalla Mareneve
incontriamo

2.2 -
Piano Pernicana: e' un pianoro incluso nella Pineta
Ragabo (dall'arabo "rahab" = bosco). Si tratta di
un'ampia pineta, un tempo molto sfruttata per
l'estrazione della resina. Infatti sui tronchi dei
pini piu' grossi si possono ancora vedere le
incisioni a spina di pesce praticate per raccogliere
la resina. Piano Pernicana comprende un'area
attrezzata con punti di cottura ed aree ristoro. In
fondo troviamo l'altarino della Madonnina della
Pineta, presso il quale ogni Ferragosto si celebra
la Santa Messa. Poco sopra c'e' un ristorante che
dispone anche di alcune camere, come il vicino
Rifugio Brunek. Qui durante l'estate si trova un
maneggio che organizza gite a cavallo nei bellissimi
dintorni. Dietro il rifugio inizia un sentiero non
percorribile con mezzi a motore, il
2.3 -
Percorso altomontano: si tratta di una pista
sterrata che attraversa a mezza costa (fra 1.500 e
1.800 m. s.l.m.) un fianco del vulcano. Esso conduce
al versante sud dell'Etna tracciando un anello
incompleto: si tratta di una pista lunga circa 35
km, di media difficolta' e di incomparabile
bellezza. Il sentiero, da affrontare con l'aiuto di
una guida, attraversa una varieta' di ambienti
naturali (sciare, boschi, dagale, etc...) che
offrono un quadro della flora e della fauna etnea.
Piu' a valle di Piano Pernicana si puo' ammirare lo
2.4 -
"Zappinazzo": in dialetto il pino viene chiamato
"zappino", ed infatti lo "Zappinazzo" e' un grosso
esemplare di Pinus nigra o laricio, uno dei piu'
vecchi (oltre 300 anni). Si puo' imboccare una delle
piste sterrate che scendono da Piano Pernicana,
oppure risalire lo stesso sentiero da Piano
Donnavita, il pianoro situato appena al di sotto di
Piano Pernicana.
http://www.agriturismoetna.it/itinerari_linguaglossa_piedimonte.htm

Rifugio Ragabo
Da non
dimenticare, la vicinanza cittadina con il superbo
bosco di Linguaglossa ed alcune interessanti grotte,
come la Grotta delle Femmine, la Grotta delle
Palombe e la Grotta dei Lamponi.
La Pro
Loco di Linguaglossa, lungo la via principale del
paese, funge da principale punto di riferimento per
le escursioni sull'Etna. Materiale e pannelli
esplicativi all'interno della sede aiutano a
conoscere il parco ed il vulcano, a programmare le
gite. Lungo la strada Mareneve, fiancheggiata da una
bella pineta di pini lanci, si giunge fino a Piano
Provenzana dove si può lasciare la vettura per
effettuare l'escursione ai crateri sommitali.
Etna - Ascesa
al versante nord -
In un bellissimo percorso, il pulmino fuoristrada
raggiunge i 3000 m ca di altitudine. Su questo
versante è stato installato il nuovo osservatorio
che ha sostituito quello distrutto dalla lava
durante l'eruzione del 1971 (durata 69 giorni) che
ha interessato sia il versante sud (ove oltre
all'osservatorio viene "cancellata" la vecchia
funivia), che il versante orientale ove la colata
lavica arriva a minacciare alcuni centri abitati
(Fornazzo, Milo) per fermarsi a circa 7 km dal mare.
Dalle vicinanze dell'osservatorio, a 2750 m ca, si
gode di una magnifica vista.

Si
prosegue poi fino a quota 3000. Qui si abbandona il
fuoristrada per procedere a piedi e vedere da vicino
quelle terribili sbuffanti bocche che a seconda del
loro umore decidono di risparmiare le terre attorno
o di mondane di una sciara, o di fuoco vivo. Il
percorso varia a seconda dei capricci del vulcano.
Lungo il ritorno, viene effettuata una sosta a 2400
m d'altitudine, per vedere i crateri protagonisti
dell'eruzione del 1809.
La
strada orientale - Una volta ritornati a Piano
Provenzana si può proseguire lungo la strada
panoramica Mareneve che costeggia la zona sommitale
dal lato est. Sulle basse pendici del versante
orientale dell'Etna, si trovano numerosi paesini
agricoli che sfruttano la fertilità del suolo
vulcanico per coltivare vite ed agrumi.
In
località Fornazzo, appena prima di immettersi sulla
strada che collega Linguaglossa con Zafferana Etnea,
si giunge fino all'incredibile colata lavica che,
nel 1979, ha "rispettato" la piccola Cappella del
Sacro Cuore (sulla sinistra) sebbene addossandosi ad
uno dei muri e riuscendo a penetrare un poco
all'interno. Oggi è meta dei numerosi fedeli che
vedono in questo un evento miracoloso e vi portano
numerosi ex-voto. Da Fornazzo una breve deviazione
sulla sinistra permette di raggiungere Sant'Alfio.

Linguaglossa - Pineta
Ragabo
Il
torrente Sciambro è
uno dei pochi corsi d'acqua osservabili in quota
sull'Etna. Dovrebbe trattarsi del torrente
localmente noto come "Quaranta ore", a sottolineare
il breve lasso di tempo in cui è percorso dall'acqua
subito dopo le giornate di pioggia. E' possibile
osservarlo solo inverno e a volte in primavera.
Sembra che le eruzioni del 2002 abbiano modificato
la morfologia del terreno, diminuendo la quantità
d'acqua raccolta dal torrente durante lo
scioglimento delle nevi. Per essere sicuri di
trovarci l'acqua occorre dunque aspettare un giorno
di pioggia e andare sul posto il giorno dopo. E'
possibile raggiungerlo da Zafferana Etna,
proseguendo verso Milo. Seguite le indicazioni per
il rifugio Citelli, ma giunti all'ultimo bivio
girate a destra, verso piano Provenzana. Dopo un
paio di km, sulla sinistra si notano le indicazioni
per il torrente.

Torrente Sciambro
Lo
Sciambro passa praticamente sotto la strada. Noi lo
abbiamo trovato in secca, la foto che lo mostra
pieno d'acqua ci è stata inviata da Francesco, uno
dei nostri lettori. Una volta sul posto, potete
andare verso uno dei due punti panoramici segnalati
nelle vicinanze. Noi siamo andati verso il punto
"Secondo Monte". Si tratta di una breve passeggiata
che, dopo un paio di curve, porta ad una scalinata e
da qui in cima ad un antico cratere, da cui si
osserva un panorama stupendo: Monte
frumento delle Concazze con la colata del 2002 con
la foresta pietrificata
Probabilmente non si tratta di un'attrazione che
meriti un viaggio ad hoc, ma se vi trovaste dalle
parti del rifugio Citelli per uno dei tanti
itinerari che è possibile percorrere da lì (Monti
Sartorius, Grotta di Serracozzo, Monte Frumento),
potere tranquillamente allungare il vostro
itinerario quel tanto che basta per osservare il
torrente o, quanto meno, lo splendido panorama
mostrato nella foto sottostante.
http://www.etnatracking.com/it/torrente-sciambro/descrizione

Monte
Frumento delle Concazze
dall'autostrada Catania-Messina uscire a Fiumefreddo
e proseguire in direzione Linguaglossa. Dal centro
del paese proseguire sulla strada mareneve seguiendo
le indicazioni per Etna Nord - Piano Provenzana. (Da
Catania 40 Km - da Messina 60 Km). In aereo:
l'aereoporto Fontanarossa di Catania è lo scalo più
vicino al vulcano. Possibilità di noleggio auto
all'interno dell'aereoporto.
Noleggio
auto: in aereoporto sono numerose le agenzie di
noleggio auto.
Autobus:
dalla stazione di Catania è possibile prendere il
bus per Nicolosi o Linguaglossa.

|
 Piedimonte
dista 35 km da Catania e 49 da Messina.Il territorio
del Comune di Piedimonte Etneo si estende sul
versante Nord-Est dell'Etna per circa 2646 ettari,
di cui 794 ricadono nel territorio del Parco
dell'Etna, tra le quote 130 e 2874 m. Il suo confine
si sviluppa lungo il vallone Zambataro fino a Ponte
Boria, passa da contrada Morabito, Vallone S.Venera,
percorrendolo fino a Presa, da qui seguendo il
limite settentrionale delle lave di Scorciavacca
giunge fino a serra Buffa, Monte Frumento delle
Concazze e Pizzi Deneri, a questo punto scendendo
verso Monte Zappinazzo, Case Bevacqua, Rocca Campana
e Terremorte si ricollega con il Vallone Zambataro.
Il paesaggio è caratterizzato dalla coesistenza di
due territori nettamente differenti: uno tipicamente
vulcanico, con colate laviche datate o recenti,
l’altro sedimentario solcato da incisioni
torrentizie. Piedimonte
dista 35 km da Catania e 49 da Messina.Il territorio
del Comune di Piedimonte Etneo si estende sul
versante Nord-Est dell'Etna per circa 2646 ettari,
di cui 794 ricadono nel territorio del Parco
dell'Etna, tra le quote 130 e 2874 m. Il suo confine
si sviluppa lungo il vallone Zambataro fino a Ponte
Boria, passa da contrada Morabito, Vallone S.Venera,
percorrendolo fino a Presa, da qui seguendo il
limite settentrionale delle lave di Scorciavacca
giunge fino a serra Buffa, Monte Frumento delle
Concazze e Pizzi Deneri, a questo punto scendendo
verso Monte Zappinazzo, Case Bevacqua, Rocca Campana
e Terremorte si ricollega con il Vallone Zambataro.
Il paesaggio è caratterizzato dalla coesistenza di
due territori nettamente differenti: uno tipicamente
vulcanico, con colate laviche datate o recenti,
l’altro sedimentario solcato da incisioni
torrentizie.
Flora
Pur essendo esteso parecchio in altitudine,quasi
raggiungendo con Pizzi Deneri,a quota 2800, la parte
sommitale del vulcano, lo sviluppo delle aree
naturali è limitato rispetto alle zone antropizzate.
Infatti tutta l’area collinare, dai 300 ai 1000 m.
circa si presenta coltivata. Nella fascia più
bassa,a partire con il confine con Fiumefreddo,
ritroviamo una sempreverde il Terebinto o
“Scornabeccu”, che insieme al rovo, alla ferula,
alla felce aquilina, al ricino caratterizza questi
luoghi. Ad 800 – 1000 m di altitudine, troviamo sia
boschi di Castagno e Roverella che terreni destinati
al pascolo e alberati là dove prima c’erano
seminativi e vigneti abbandonati. Proseguendo verso
quota 1700 ecco comparire esemplari di Pino Laricio
e di Betulla dell’Etna. Sul fronte lavico troviamo
la vegetazione tipicamente pioniera: Saponaria,
Astragalo, Ginestra.
 Le
aree coltivate nel territorio di Piedimonte Etneo,
prevalenti, come abbiamo visto, su quelle a
vegetazione naturale, si estendono dal suo estremo
confine orientale fino ai 1150 m di monte Stornello,
e seguono una progressione ben precisa. Nella fascia
più bassa, al confine con Fiumefreddo, si insediano
le colture di agrumi (che non superano i 500
s.l.m.): arance, mandarini, clementine e limoni,
coltivati su terreni totalmente terrazzati. A queste
quote è anche discretamente sviluppata la
coltivazione dell'ulivo. Salendo in altitudine, a
partire dai 450 metri, troviamo i vigneti:
Piedimonte fa parte della fascia di produzione dei
vini D.O.C. dell'Etna, e, infatti, la qualità
denominata Nerello Mascalese dà un ottimo vino Etna
Rosso D.O.C. Questo tipo di vite viene coltivata
soprattutto ad alberello, che è il metodo più
tradizionale, in misura minore è possibile
riscontrare vigneti coltivati a “tendone” e
soprattutto a “spalliera”. Altri vitigni coltivati
sono il Carricante e il Nerello Cappuccio,
quest’ultimo ha caratteristiche complementari a
quelle del Nerello Mascalese e non a caso, per
tradizione,i due vitigni vengono utilizzati in
taglio per produrre i vini rossi tipici dell’Etna.
In particolare il Nerello Cappuccio permette di
ottenere vini con una colorazione più intensa e con
una struttura più solida e longeva, che bene si
sposano con l’eleganza e la linearità dei vini
prodotti con il Nerello Mascalese. Il Carricante,
che produce vini bianchi (fra cui L’Etna Bianco
D.O.C.) è il secondo vitigno chiave della
viticoltura etnea, anche se la sua coltivazione si è
quasi sempre limitata al versante orientale del
vulcano e a zone più elevate ove il Nerello
Mascalese fatica in genere a raggiungere una
perfetta maturazione. In contemporanea ai vigneti
troviamo i frutteti che offrono diverse qualità di
mele (Delicius, Golden Delicius, Cola e Gelato
Cola), pere (fra cui la varietà pera coscia), pesche
e ciliegie. Dai 1000 metri in su incontriamo
noccioleti e castagneti. Le
aree coltivate nel territorio di Piedimonte Etneo,
prevalenti, come abbiamo visto, su quelle a
vegetazione naturale, si estendono dal suo estremo
confine orientale fino ai 1150 m di monte Stornello,
e seguono una progressione ben precisa. Nella fascia
più bassa, al confine con Fiumefreddo, si insediano
le colture di agrumi (che non superano i 500
s.l.m.): arance, mandarini, clementine e limoni,
coltivati su terreni totalmente terrazzati. A queste
quote è anche discretamente sviluppata la
coltivazione dell'ulivo. Salendo in altitudine, a
partire dai 450 metri, troviamo i vigneti:
Piedimonte fa parte della fascia di produzione dei
vini D.O.C. dell'Etna, e, infatti, la qualità
denominata Nerello Mascalese dà un ottimo vino Etna
Rosso D.O.C. Questo tipo di vite viene coltivata
soprattutto ad alberello, che è il metodo più
tradizionale, in misura minore è possibile
riscontrare vigneti coltivati a “tendone” e
soprattutto a “spalliera”. Altri vitigni coltivati
sono il Carricante e il Nerello Cappuccio,
quest’ultimo ha caratteristiche complementari a
quelle del Nerello Mascalese e non a caso, per
tradizione,i due vitigni vengono utilizzati in
taglio per produrre i vini rossi tipici dell’Etna.
In particolare il Nerello Cappuccio permette di
ottenere vini con una colorazione più intensa e con
una struttura più solida e longeva, che bene si
sposano con l’eleganza e la linearità dei vini
prodotti con il Nerello Mascalese. Il Carricante,
che produce vini bianchi (fra cui L’Etna Bianco
D.O.C.) è il secondo vitigno chiave della
viticoltura etnea, anche se la sua coltivazione si è
quasi sempre limitata al versante orientale del
vulcano e a zone più elevate ove il Nerello
Mascalese fatica in genere a raggiungere una
perfetta maturazione. In contemporanea ai vigneti
troviamo i frutteti che offrono diverse qualità di
mele (Delicius, Golden Delicius, Cola e Gelato
Cola), pere (fra cui la varietà pera coscia), pesche
e ciliegie. Dai 1000 metri in su incontriamo
noccioleti e castagneti.
La fauna
La diffusione dell’agricoltura nel territorio
piedimontese determina la presenza di specie animali
poco specializzate che possono frequentare sia le
coltivazioni e i centri abitati, sia le aree
cespugliate e i boschi delle quote medio alte. Nei
pressi dei centri abitati, dove è diffusa
un’agricoltura tradizionale, con piccoli
appezzamenti coltivati a frutteti, vigneti e orti,
troviamo specie molto comuni quali: il rospo, il
geco, la lucertola, il pettirosso, il passero, il
fringuello, il cardellino,il merlo, il topo
(domestico e selvatico), la donnola, il riccio e
varie specie di chirotteri. A queste, nelle zone
coltivate a maggior estensione, che comprendono
anche i noccioleti e vigneti delle quote più alte,
si aggiungono il coniglio selvatico, , la gazza, la
cornacchia grigia, l’assiolo e il barbagianni. Gli
ambienti boschivi ospitano, oltre al ghiro e al
quercino soprattutto una ricca fauna aviaria:
colombaccio, cuculo, picchio rosso, cinciallegra,,
ghiandaia, fanello, zigolo nero. A partire dai 1200
m di altitudine, dove i boschi si alternano zone
aperte, troviamo la lepre, il calandro e la
monachella. Un cenno a parte merita la volpe, che
essendo particolarmente adattabile, si trova in
tutti gli ambienti citati, da quelli più
antropizzati fin nelle zone altomontane al limite
della vegetazione.

Storia Piedimonte
Etneo nel suo nascere, agli albori del XVII secolo,
fu battezzata con il nome di "Belvedere" grazie agli
incantevoli panorami che si ammirano dalla colina
ove sorge, sita ai piedi del vulcano sul versante
orientale dell'Etna. All'epoca il territorio di
Piedimonte Etneo faceva parte dei possedimenti dei
Gravina Cruillas, baroni di Francofonte e principi
di Palagonia, e fu appunto Ignazio Gravina Cruillas
(1611-1685) che nel 1650 "principiò" sul feudo
Bardella della baronia di Calatabiano "una nuova
habitatione" chiamandola "Piemonte". Successivamente
il nipote Ignazio Sebastiano Gravina Amato
(1657-1694), nonostante l'opposizione della vicina
Linguaglossa, ottenne dal Tribunal del Real
Patrimonio la licenza "populandi". L'atto di vendita
della licentia populandi fu stipulato il 30 agosto
1687, seguito il 22 settembre dal decreto viceregio
che sanciva la nascita del nuovo paese.
Nonostante il nome richiesto alla Regia Curia fosse
"Piemonte", continuò ancora a chiamarsi Belvedere,
nome caro ai suoi abitanti. In seguito prevalse il
nome Piedimonte, cui fu aggiunto Etneo nel 1862, per
distinguerlo da altri paesi con identico nome.
Il
fondatore non era andato oltre l'edificazione di una
piccola chiesa, intitolata a Sant'Ignazio di Loyola,
di una dozzina di "casuncole terrane", di qualche
forno, di un piccolo alloggio per suo servizio. Il
nipote, ottenuta licenza, lasciata Palermo,si
trasferì nella baronia di Calatabiano, ove si fece
costruire due comode dimore: una all'Aquicella
(detta ora Castello di San Marco) e l'altra a
Piemonte. Stabilitosi in questi luoghi nel 1689 vi
realizzò altre costruzioni.
 Fu
Ferdinando Francesco (1675 - 1736), quarto signore
di Piedimonte, il fautore della notevole espansione
settecentesca del paese e l'impronta urbanistica che
tuttora lo caratterizza grazie all'apertura di
strade dalla larghezza inconsueta. Vennero
realizzate importanti costruzioni, fra cui
ricordiamo l'acquedotto, la Porta San Fratello, il
Carcere, la chiesa di San Michele Arcangelo e il
Convento dei Cappuccini. In questo periodo si
registra un rilevante aumento della popolazione.
Molti furono gli immigrati venuti dai paesi vicini,
alcune famiglie vennero addirittura dalla Calabria,
altre da Palermo a seguito del Principe. Fu
Ferdinando Francesco (1675 - 1736), quarto signore
di Piedimonte, il fautore della notevole espansione
settecentesca del paese e l'impronta urbanistica che
tuttora lo caratterizza grazie all'apertura di
strade dalla larghezza inconsueta. Vennero
realizzate importanti costruzioni, fra cui
ricordiamo l'acquedotto, la Porta San Fratello, il
Carcere, la chiesa di San Michele Arcangelo e il
Convento dei Cappuccini. In questo periodo si
registra un rilevante aumento della popolazione.
Molti furono gli immigrati venuti dai paesi vicini,
alcune famiglie vennero addirittura dalla Calabria,
altre da Palermo a seguito del Principe.
Piedimonte continuò a crescere nel corso del
Settecento, con l'apertura di nuove strade, la
costruzione di palazzi lungo il corso principale e
della Chiesa Madre con l'ampia piazza adiacente. Nel
1812 venne elevato a Comune e il primo sindaco fu il
signor Domenico Voci, che era stato più volte
amministratore civico.
Economia e turismo L'economia
si basa prevalentemente sull'artigianato e
l'agricoltura. La produzione agricola tradizionale
si basa essenzialmente sull'agrumicoltura, la
viticoltura (a buon titolo, infatti Piedimonte è
inserita nel circuito delle città del vino) e
l'olivicoltura con produzione di ottimo olio. Negli
ultimi decenni, poi, si è molto sviluppata la
coltura in serre soprattutto di piante ornamentali,
e ultimamente anche di ortaggi. Purtroppo, l'elevato
numero dei cascinali ridotti a rudere e dei terreni
lasciati all'abbandono e alle sterpaglie è indice
del continuo abbandono delle campagne, un tempo
coltivate e verdeggianti, da parte della
popolazione.
Sviluppato è il turismo: per la sua posizione
geografica Piedimonte è luogo di transito per chi
vuole raggiungere le parti alte della zona est del
vulcano, mantenendo contemporaneamente un facile e
veloce accesso alla costa ionica.
Le
attrattive turistiche sono anche legate alle
tradizioni popolari del paese. La festa del patrono,
Sant'Ignazio da Loyola, che si svolge il 31 luglio,
offre anche l'opportunità di partecipare a varie
sagre locali, nonché al Trofeo di Sant'Ignazio,
importante gara podistica che richiama atleti di
fama internazionale. Tra le altre manifestazioni da
ricordare l'Estate Piedimontese, durante la quale si
svolgono mostre, concerti, rappresentazioni teatrali
e tornei sportivi; e la Festa della Vendemmia che
ogni anno, alla fine di settembre, rievoca le
antiche tradizioni, gli antichi usi relativi,
appunto, a quella che un tempo era la ricchezza
delle contrade del paese.
l'ultima foto è di http://www.raffaeledavinci.it/paginehtml/piedimonte_etneo.htm |
 Il
Castello di Lauria Non
abbiamo notizie certe sulla sua origine, ma le due
finestre bifore della parte ovest ci lasciano
intuire che il nucleo principale sia stato edificato
molto probabilmente durante il periodo
normanno-svevo. Il
Castello di Lauria Non
abbiamo notizie certe sulla sua origine, ma le due
finestre bifore della parte ovest ci lasciano
intuire che il nucleo principale sia stato edificato
molto probabilmente durante il periodo
normanno-svevo.
Tale sito nel corso della storia dell’abitato ha
avuto di sicuro una funzione molto rilevante tanto
da dare il nome al paese. E’ certo che Castiglione
nel XII secolo viene chiamato Quastallum da Edrisi,
Castillo in un diploma di Ruggero II, Castillio in
un diploma di Papa Eugenio III.
L’attuale nome, invece, significa Castello grande.
Al latino medievale castellum, infatti è stato
aggiunto il suffisso accrescitivo –ione, facendolo
diventare Castellione, che gli aragonesi prima e gli
spagnoli poi pronunziavano Casteglione. Il termine
ben presto comunque interpretato come Castello del
Leone per offrire al paese un marchio di regalità,
dando luogo anche allo stemma: un castello e due
leoni accovacciati.

Il castello nel Medioevo, collegato alla roccaforte
del Castelluccio e ad un avamposto identificabile
con la chiesa di San Pietro era messo in
comunicazione con questi da passaggi sotterranei,
che giungevano, si dice, fino al Cannizzo. Essi
costituivano un vero e proprio complesso
architettonico e difensivo, ed un vecchio stemma
cinquecentesco della città, con tre torri, mette in
evidenza la loro importanza. I vari quartieri del
castello assumevano funzioni diverse. Vi era la
parte più nobile riservata al castellano; vi erano
le scuderie, i fienili, le stalle, le abitazioni per
i servi e per gli addetti alla manutenzione; vi
erano le carceri, all’interno delle quali, nelle
scomode celle dette dammusi, lunghe non più di due
metri ed alte appena un metro, venivano rinchiusi
spesso i più facinorosi avversari politici e più
incalliti delinquenti; vi erano le cisterne per
conservare l’acqua piovana o per nascondervi,
durante gli assedi, vettovaglie e suppellettili
preziosi; vi erano le rotonde bombe di pietra,
pronte per essere scagliate contro i nemici; vi era
nella parte più alata un ampio locale, detta
Solecchia, che comunemente si ritiene fosse la zecca
dove si coniavano le monete, ma poteva essere il
luogo dove il feudatario si riparava dal sole, dopo
aver completato quasi per intero il suo vastissimo
feudo.
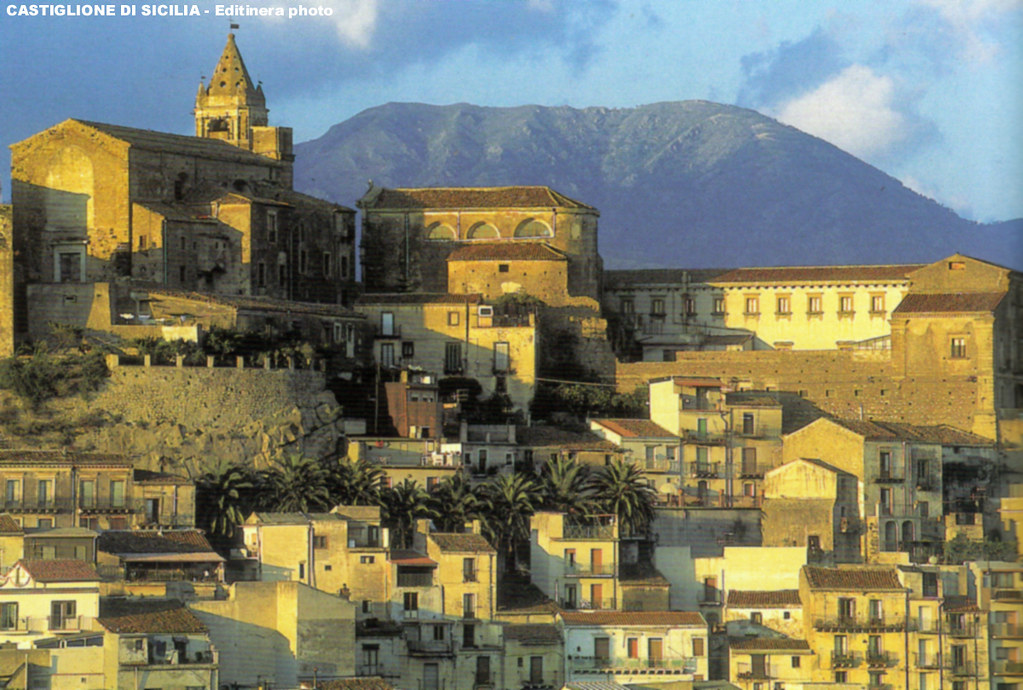
LA
CUBA.
Raro
esempio di architettura bizantina in Sicilia, la
chiesetta si trova nelle campagne di Castiglione di
Sicilia. Progetti e iniziative culturali riaccendono
l’attenzione sul sito di
Maria Enza Giannetto - In viaggio - supplemento al
quotidiano La Sicilia
Quando
ero bambina, per me e i miei cuginetti era un
rifugio segreto. Trascorrevamo lì ore intere, a
inventare giochi, leggende, storie misteriose e
affascinanti su questo edificio di cui conoscevamo
solo il nome: “A Cuba”. Allora, circa 25 anni fa,
era ricovero per pastori e contadini che si
riparavano dalle piogge improvvise.
Al suo interno si poteva trovare davvero di tutto:
utensili abbandonati, ossa di animali, pezzi di
stoffe. Per noi ragazzi era qualcosa di magico.
Crescendo ho imparato che il suo nome completo di
questa costruzione abbandonata, in contrada
Giardinelli, nelle campagne di Castiglione di
Sicilia, in provincia di Catania, era Cuba di Santa
Domenica, conosciuta anche con i nomi di Chiesa
bizantina in contrada Santa Domenica, Chiesa
bizantina Santa Domenica o la Cuba di Castiglione. E
ovviamente, mi sono anche resa conto di quanto
quella magia fosse frutto dell’abbandono e del
degrado in cui versava questo edificio
dall’incommensurabile valore storico culturale,
nonché monumento nazionale dal 1909.

Forse unico esemplare, ancora in buono stato, in
Sicilia, del periodo bizantino, la Cuba fu costruita
tra il VII-IX secolo (la datazione più probabile è
ormai tra la seconda metà del VIII secolo alla prima
metà del IX). L’edificio ecclesiastico ha una
struttura a croce latina con pianta quadrata, cupola
e tre absidi. L’abside posteriore ha una bifora
rivolta verso oriente affinché, secondo tradizione,
durante la veglia pasquale la luce della luna piena
entrando nell’edificio desse inizio alla Pasqua. Le
altre due absidi contenevano ciascuna una piccola
cappella. Costruita con pietra, blocchi lavici,
malta e materiali in cotto, la Cuba internamente era
ricca di affreschi di fattura bizantina, oggi
perduti. Negli anni, la situazione, grazie una nuova
attenzione per il patrimonio storico culturale
siciliano, è migliorata, tanto che intorno al 2000
sono stati avviati lavori di restauro e di “pulizia”
della chiesetta che hanno dotato il tempietto di due
belle porte in ferro lavorato, di finestre che
tengono lontani animali, vandali e purtroppo anche i
visitatori che non abbiano prenotato per tempo la
visita tramite l’ufficio turistico del Comune
(è possibilie prenotare allo 0942980348 (centralino
0942980211), oppure scrivendo una e-mail a turismo@comune.castiglionedisicilia.ct.it
Nelle
giornate primaverili, una gita alla Cuba, con
annesso pic-nic alle piccole gole a circa 200 metri
dalla Chiesa, è davvero impagabile. Certo, mancano
i servizi: qualche panca in legno, un totem con le
informazioni posto fuori e non dentro l’edificio, un
progetto di illuminazione che lo rendesse visibile
anche di notte, maggiore controllo, non
guasterebbero.
Intanto l’amministrazione comunale parla di due
progetti: una pista ciclabile adiacente al sito e
una zona parcheggio che servirebbe l’intera area.
Piccoli focolai di interesse per questo sito fanno
pensare a una nuova “alba” per la Cuba bizantina.
Complice la passione di alcuni giovani che da questo
posto così misterioso sono rimasti stregati, tanto
da dedicarci tesi di laurea, project work e progetti
culturali. E infatti, lo scorso dicembre la Cuba è
stata riconosciuta Meraviglia italiana, grazie
all’interesse di un giovane architetto catanese che
a seguito di uno studio condotto sull’edificio per
la sua tesi di laurea ha presentato la candidatura
al progetto sostenuto dal Forum nazionale giovani.
Come “Meraviglia Italiana” la Cuba è entrata a far
parte di un itinerario d'eccellenza che di sicuro le
varrà una grande pubblicità a livello nazionale. C’è
un’altra iniziativa che potrebbe contribuire a far
conoscere e quindi mantenere sempre accesi i fari
dell’interesse sul tempietto. Si tratta di Innesto,
un progetto ideato dall’associazione no profit C-T
cultural transfer a cura di Norma Guglielmino,
insieme con le socie Marialuisa D’Arrigo e Olga
Colajanni. Si tratta di un esperimento di relazione
e interazione tra bene culturale, arte
contemporanea, territorio e società. «L’idea -
spiegano le socie - è quella di far dialogare l’arte
contemporanea con il patrimonio storico-culturale
siciliano. Abbiamo già presentato un’anteprima, il
13 novembre 2011, ma alla fine di aprile ci sarà un
evento proprio nella chiesetta, con tre giovani
artisti che con la Cuba
si sono già messi a confronto». L’interesse delle
tre socie per questo sito parte dal 2008 quando,
durante un master sulla gestione e valorizzazione
del patrimonio mondiale, culturale e naturale, hanno
scelto la Cuba come soggetto del loro project work.
«Si trattava – spiegano - di simulare di una
candidatura del sito per la World heritage list ed
effettivamente, ci sono talmente tante
caratteristiche che ne permetterebbero la
candidatura reale....».
La bellezza c’è. L’interesse nel mantenerla, pure.
Chissà che con un impegno maggiore non si possa
davvero pensare a questa candidatura reale?

foto di Antonio Treccarichi
Castiglione di Sicilia
Calici di stelle, la guida ai migliori
vini Storia e leggende si intrecciano per descrivere questo
suggestivo centro medievale le cui origini
affondano nel passato remoto. Più che le parole e i racconti
a descrivere Castiglione ci sono i suoi monumenti, il suo
centro storico, quelle testimonianze che lo hanno fatto
entrare a pieno titolo nei Borghi più Belli d’Italia. Ma è
proprio in quel patrimonio di arte, architettura, cultura,
nel cui territorio alcune emergenze architettoniche
impreziosiscono ancor di più questa zona tra l’Alcantara e
l’Etna, come la Cuba bizantina (chiesa di Santa Domenica),
già monumento nazionale, e che ha consentito al Comune di
parte dell’Aceb, l’Associazione delle Città Eredi di
Bisanzio.
Castiglione già da tempo rappresenta
una delle più dinamiche realtà turistiche del versante Nord
Etna, con i suoi oltre 700 posti letto costituiti da: 6
aziende agrituristiche, 4 turismi rurali, 5 bad & breakfast,
3 affittacamere, 3 alberghi, 2 case vacanza, 1 ostello. A
questi si aggiungono 7 ristoranti, 3 enoteche, 1 campo da
golf, 3 società di escursioni e servizi turistici. Ma è la
produzione di vini Doc dell’Etna che uno dei settori
trainanti del turismo, così che l’Amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Salvo Barbagallo, punta molto alla
valorizzazione dei prodotti tipici locali, con una maggiore
valorizzazione di quelle che sono state tradizioni
attraverso eventi mirati.

“Calici di Stelle”, la notte del 10
agosto, è ormai l’evento top per quanto riguarda la
presentazione e la degustazione di vini siciliani, grazie
all’adesione di aziende vitivinicole che provengono da tutta
la Sicilia, ma anche per quanto riguarda la sagra
enogastronomica, durante le 3 giornate che precedono Calici
di Stelle, divenuta ormai una preziosa rassegna di sapori e
gusti del territorio castiglionese, le cui eccellenze
agroalimentari, ricordiamo, sono vino, olio, formaggi,
nocciole e frutta secca in genere, dolciumi.
Castiglione ha un’offerta turistica
variegata, potendo contare su alcune eccellenze
naturalistiche, come l’Etna e le Gole Alcantara.
Ma è il Castello di Lauria, i vicoli
tutt’intorno e il borgo medievale che sono la grande
attrazione turistica, in una cornice architettonica e
storica dove è possibile visitare pure la Basilica della
Madonna Maria Santissima della Catena, la chiesa di
Sant’Antonio con i suoi intarsi marmorei e quella dei Santi
Pietro e Paolo e la meridiana solare. Ritorna in voga
l’antica arte e tradizione dei ricami, dove il punto inglese
nel passato ha costituito una fiorente attività artigianale
contando anche centinaia di ricamatrici, tanto che
l’Amministrazione comunale ha avviato delle iniziative per
far riscoprire e valorizzare quest’arte.
MICHELE LA ROSA
DOMENICA 3 AGOSTO 2014 LA SICILIA

Il
territorio castiglionense è percorso, da est ad
ovest lungo lo sviluppo etneo, dalla SS120 che
rappresenta l'asse principale della viabilità,
collegando il comune alla A18 Messina-Catania, ed
alla statale 114, ambedue sulla costa. E' inoltre
attraversato da una maglia ortogonale di strade
provinciali che collegano il centro alle frazioni a
monte ed alla vicina Francavilla. E' previsto, ed in
parte esistente, un asse di collegamento lungo il
fiume che collegherà al centro urbano. Suggeriamo,
infine, un arrivo a Castiglione di Sicilia alquanto
romantico: con la ferrovia circumetnea, che partendo
da Catania prosegue per Randazzo e la Valle
dell'Alcantara, attraversando paesaggi di
incontestabile bellezza. Con la stessa FCE si può
raggiungere Castiglione da Riposto, porto turistico
dell'Etna. La stessa società di trasporti durante
l'estate organizza delle escursioni guidate per i
turisti, partenza con la littorina da Catania Borgo
e il tragitto in parte su ferrovia e in parte con
gli autobus.

nei pressi di Castiglione
|





