|


LA PASQUA IN SICILIA
Questa
ricorrenza religiosa e', ovviamente, tra le piu' importanti dell'anno
liturgico ed in Sicilia ha dato origine a molte feste cittadine che
uniscono magnificamente i momenti salienti della Passione, Morte e
Resurrezione di Gesu' Cristo alla ritualita' popolare le cui origini
affondano in tempi antichissimi, alle forme espressive a volte teatrali
e drammatiche che spesso si presentano in maniera articolata e complessa
e simboli di rinnovamento piu' totale.
Quello ch e colpisce principalmente delle feste pasquali siciliane e'
l'attiva partecipazione popolare che si manifesta non solo nei classici
cortei e pellegrinaggi, ma anche nell'alternanza dei sentimenti tristi
del lutto per la morte del Redentore e quelli allegri e festosi per la
Sua Resurrezuione. e colpisce principalmente delle feste pasquali siciliane e'
l'attiva partecipazione popolare che si manifesta non solo nei classici
cortei e pellegrinaggi, ma anche nell'alternanza dei sentimenti tristi
del lutto per la morte del Redentore e quelli allegri e festosi per la
Sua Resurrezuione.
Mentre per gli ebrei tale ricorrenza celebrava il ricordo della
liberazione dalla schiavitu', con la venuta di Cristo, dunque per i
cristiani, si ha un nuovo significato, la liberazione dal male e dal
peccato.
La Pasqua ha i suoi momenti liturgici stabiliti lungo i 40 giorni della
Quaresima ed in modo particolare nella settimana santa che va dalla
domenica delle Palme, antecedente quella di Pasqua, quando si benedicono
i ramoscelli d'ulivo, a quella di Pasqua, che generalmente ha come
date estreme il 22 marzo ed il 25 aprile, e che comunque segue il
plenilunio dell'equinozio primaverile.
ALCUNI DOLCI CONSIGLI

La
domenica delle palme è molto particolare a Scicli, in provincia
di Ragusa, perchè si festeggia S. Maria della Pietà. Il simulacro che
la simboleggia ha una storia così particolare che trascende la
leggenda: pare che agli inizi dell'anno Mille la statua è stata
ritrovata nella piccola chiesa di S. Maria della Cava; la statua era
venerata sin dai primi anni di diffusione del Cristianesimo, ma fu
dimenticata quando intorno il 700 arrivarono i Saraceni nell'isola ed i
Cristiani, per sottrarla dalle mani mussulmane, la nascosero; dopo il
suo ritrovamento e la costruzione della Chiesa S. Maria la Nova, ad essa
furono affiancate le statue delle pie donne e Cristo morto.
Attualmente il gruppo statuario è portato in processione fino alla
Chiesa del Carmine e per le vie cittadine ed esso è posto all'interno
di una vara ed il Cristo è raffigurato quando oramai è disceso dalla
croce, con le braccia e le gambe quasi staccate dal resto del corpo. In
questa ricorrenza alla Madonna sono offerte delle composizioni di foglie
di palma, denaro ed ex-voto.
Anche il resto della settimana santa è molto particolare in queta
cittadina.
Il venerdì santo si ha una particolare processione: la statua di S.
Maria Addolorata è prelevata dalla chiesa di S. Giovanni Evangelista
per giungere in processione alla chiesa di S. Maria La Nova, dove il
simulacro del Cristo morto è prelevato; la processione continua per
tutto il giorno; la domenica di Pasqua si ha la celebrazione dell'
"Uomo Vivo", costituita da 2 processioni; la prima si svolge
la mattina, quando il SS. Sacramento è portato per le vie della città,
per poi far ritorno nella chiesa di S. Maria La Nova per essere
sostituito con il simulacro di Gesù risorto, il soggetto della seconda
processione che poi verrà riportato nella chiesa del Carmine dove
resterà per qualche ora, visto che la processione riprenderà nel
pomeriggio per concludersi la sera quando il simulacro è riportato
nella Chiesa di S. Maria La Nova. Da ricordare che a Scicli il Signore
ha vari appellativi, uno fra tanti è "U gioia".

La
Domenica delle Palme e' un giorno particolare per Buseto Palizzolo,
una cittadina che raccoglie poco piu' di 3.000 anime e che e' situata in
provincia di Trapani. Si sta parlando della "Processione della Via
Crucis" , una manifestazione dal notevole interesse religioso e
folcloristico che prevede il coinvolgimento di 16 gruppi viventi che
effettuano un percorso notturno per rievocare gli eventi della morte e
risurrezione di Gesu' Cristo.
Il
giovedì santo a Marsala (Tp) si ha un'imponente processione
sacra dedicata alla Passione e morte del Cristo effettuata da 9 gruppi
di figuranti, ognuno dei quali rappresenta eventi legati alla Passione
del Cristo, partendo dalla ultima cena e fino all'ascesa al Calvario,
gruppi hanno un loro posto nel corteo e che sono preceduti da un uomo
incappucciato che porta la croce, da un giudeo che suona la tromba ed un
altro giudeo che suona il tamburo; il corteo prevede la partecipazione
delle statue del Cristo morto e dell'Addolorata posti alla fine della
processione e portati dalle consorelle e dai confratelli della Chiesa di
S. Anna e di altri due gruppi, posti davanti al tutto e costituiti da
ragazze che portano palme e rametti di ulivo e di bambini e bambine che
portano dei preziosi copricapi di propietà della Chiesa e che sono
impreziositi dai monili d'oro della famiglia d'appartenenza della
famiglia del bambino. In genere la processione dei misteri si colclude
la sera con la rappresentazione teatrale dei momenti più significativi
della Passione.
La teatralità dell'evento, i costumi adoperati dai figuranti (ad
esempio il secondo gruppo è costituito da ragazze vestite di bianco per
simboleggiare la purezza), non devono far dimenticare che parte della
fede isolana è formata dal carattere popolare che avvicina i valori
cristiani ai sentimenti della popolazione che così diventa più
partecipe dell'evento.

La
processione dei Misteri di Trapani si attua con delle statue e
l'evento prevede un lavoro particolare delle varie maestranze coinvolte
già durante i venerdi di Quaresima, quando si attua "a scinnuta
dei misteri", cioè quando il gruppo statuario che rappresenta il
"misteri" di turno viene posto in evidenza rispetto agli
altri. In tutto si hanno sei misteri che sono addobbati per l'occasione,
a partire dalla Caduta al Cedron, alla flagellazione, fino ad arrivare
all'Addolorata. Ogni misteri è affidato ad una particolare
confraternita di artigiani e lavoratori. Durante questi venerdì di
Quaresima i ragazzi trasportano a spalla dei fercoli con delle immagini
sacre e poi andranno in giro per la città a raccogliere le offerte dei
fedeli.
Già
dai primi giorni della settimana santa si hanno delle processioni: il
martedì santo si ha la processione della Madonna dei massari,
organizzata dai discendenti dei portatori delle masserizie, che in
passato erano pagati dai contadini più agiati per trasportare i misteri
e che poi furono esclusi dalla processione ufficiale del venerdì; il
mercoledì santo è il turno dei fruttivendoli che organizzano la
processione in onore della Madonna della Pietà per le vie cittadine
fino alla rituale visita alla Madonna dei massari.
Il venerdì santo si ha la processione più imponente di questi misteri
con la partecipazione dei 18 gruppi lignei appartenenti alle maestranze
più l'urna del Cristo morto e dell'Addolorata. Tale processione parte
nel primo pomeriggio del venerdi, con l'accompaganento musicale, per
terminare la mattina del sabato.
 
La
processione dei misteri di Caltanissetta fonda le sue origini sin
dalla fine del 1700 ad opera della Congregazione di S. Filippo Neri,
corteo che prevedeva il trasporto di 5 barette, la base di altrettante
statue di terracotta, rappresentanti alcuni dei misteri relativi alla
morte del Cristo.
Dopo qualche tempo tali rappresentazioni furono sostituiti da 14 statue,
in base al numero delle stazioni della Via Crucis. Nel corso degli anni
tale processione ha avuto dei cambiamenti e delle fasi di maggiore o
minor fortuna, fino ad arrivare a quasi alla fine del 1800, quando si
raggiunse il numero di 16 statue la cui costruzione fu affidata a degli
artigiani napoletani. Tale processione è
attuata il giovedì santo.
Le manifestazioni della settimana santa di Caltanissetta prevedono anche
la processione dei variceddi, 14 gruppi in terracotta, del mercoledì
santo, e quella della deposizione del Cristo il sabato.
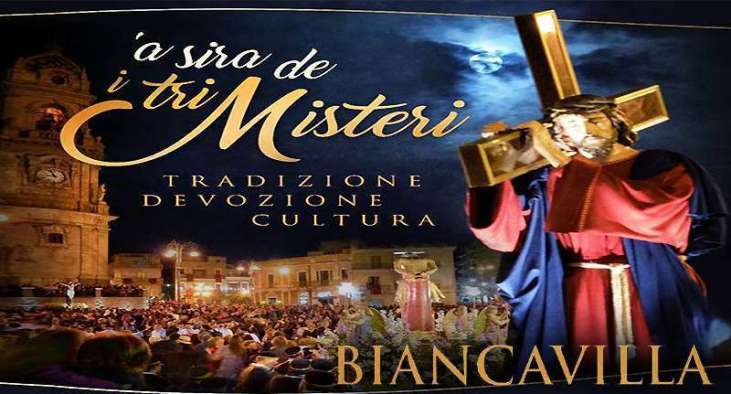
Durante
la settimana santa, e precisamente dal mercoledi al venerdi santo, a S.
Fratello, nelle Nebrodi messinesi, si ha un altro esempio di questa
particolare unione tra sacro e profano. Qui si ha anche l'unione del
dolore per la perdita del Cristo e della fastosità tipica del
carnevale.
Una miriade di contadini e pastori si travestono da "giudei"
con dei particolari costumi costituiti da giubbe rosse e gialle
impreziosite con motivi floreali e ricami e da un cappuccio rosso che
ricopre la testa. Tali costumi ricordano in parte quelli dei soldati
romani che flagellarono Gesù e sono di propietà delle famiglie del
posto e sono tramandate da padre in figlio.
Tali
"giudei" ripercorrono le vie della città con squilli di
trombe, catene minacciose e campanacci in modo allegro con il chiaro
intento di distogliere l'attenzione popolare dal dolore per la morte di
Gesù Cristo.
Il contrasto ha il suo punto cruciale il venerdì santo, quando il
corteo che segue il Crocifisso è disturbato ed interrotto nel suo
cammino dall'arrivo festoso dei giudei.
In passato la festa era più irriverente e pericolosa, tanto da proibire
la vendita di alcolici.

La
settimana santa è caratteristica anche a Barcellona, in
provincia di Messina, dove il giovedì santo 12 uomini, che
rappresentano gli apostoli, attuano la canonica lavanda dei piedi e poi
il peregrinare per le chiese ed i tabernacoli della città. Il venerdì
santo si ha la processione di circa 20 statue fastose realizzate con
l'uso di vari materiali come la cartapesta ed il legno, numero destinato
a crescere quando si aggiungono quelle provenienti da Pozzo di Gotto.
Ancora oggi, un vago ricordo di quello che avveniva in passato, si ha la
riunione dei "vissillanti", visto che resiste l'abitudine di
far seguire le vare adoperate nella processione, tranne quella del
Cristo morto, da un manipolo di devoti che cantano.

La
Pasqua è molto sentita anche a Caltagirone, in provincia di
Catania, dove si venera Gesù Crocifisso. Si ha la venerazione della
Madonna Addolorata una domenica di passione in cui i fedeli si
raccolgono nella chiesa dei cappuccini per venerare il gruppo ligneo del
1700 che rappresenta il Cristo e la Madre, giorno in cui rientrano, dopo
15 giorni, le bancarelle dove si vendono i simboli della passione in
terracotta ed i dolci.
Nei primi giorni della settimana santa, poi, si organizza la Via Crucis
molto caratteristica che sfrutta la maestosa scalinata della città,
adiacente la piazza del municipio; tale via crucis ripercorre gli ultimi
eventi della vita terrena di Gesù, dall'incontro con Pilato alla sua
morte in croce. Uno dei momenti più forti per la fede di questa città
è il venerdì santo, quando il Cataletto del Cristo morto, cioè una
scultura lignea riposta in un'urna costruita in legno e vetro e rifinita
con oro, e la statua della Madonna Addolorata sono portati in
processione. Le due statue sono trasportate a spalla dai fedeli. La
domenica di Pasqua si ha una processione più imponente: ci sono tre
statue, quella di S. Pietro proveniente dall'omonima chiesa, costituita
di cartone pressato e vuota all'interno per far spazio al portatore,
quella del Cristo risorto che proviene dalla Chiesa della Sacra Famiglia
e che va incontro a quella della Madre. Quando si ha l'incontro tra
Madre e Figlio, in prossimità della scalinata di S. Maria del Monte, la
statua della Madonna è liberata dal manto nero del lutto e scopre
quello bianco e celeste, segno di gioia.

Tutta
la settimana santa nella parte antica di Ragusa, Ibla, si hanno
varie manifestazioni. C'è innanzitutto lo spostamento delle statue
dalle chiese dove sono conservate alla chiesa madre di S. Giorgio ad
opera di varie confraternite. La domenica delle palme i primi a muoversi
sono i confrati della chiesa di S. Maria dell'Itria che hanno il compito
di portare la statua della Addolorata mentre i confrati della chiesa
dedicata a S. Maria Maddalena e San Teodoro fanno altrettanto con la
statua dedicata alla Maddalena ed i confrati del SS. Rosario portano il
simulacro di Cristo alla colonna. Il lunedì tocca ai confrati di S.
Giacomo Apostolo con il simulacro di Gesù nell'orto ed ai confrati
della chiesa di S. Maria dello Spasimo che trasportano il simulacro
della Pietà; il martedì tocca ai confrati di S. Filippo Neri che
trasportano il simulacro della Veronica. Tutto questo per l'esposizione
del SS. Sacramento per le "40 ore" . Il giovedi santo si ha la
visita dei fedeli alle varie parrocchie per effettuare i
"sepolcri", cioè si rende onore ai vari altari preparati in
alcune chiese di Ibla con fiori, ornamenti funebri, vasi con cereali che
riproducono l'originario sepolcro del Cristo; in altre chiese, come
quella dedicata al Crocifisso, si rispetta l'antica usanza di lasciare
la chiesa al buio per venerare il Cristo in altro modo. Si arriva così
al venerdi santo quando si ha la processione dei simulacri del Cristo e
della Madonna, evento che parte dalla Chiesa madre S. Giorgio e
ripercorre alcune vie di Ibla.

I
riti greci legati alla settimana santa hanno conservato il loro fascino
all'interno della Piana degli albanesi, nel palermitano, dove si
ritrovano cinque delle otto comunità albanesi presenti nell'isola. Qui
resiste un clima di convivenza civile tra due diverse etnie, anche se la
minaccia economico-sociale del sistema capitalista è sempre evidente. I
riti pasquali di questa comunità iniziano con il canto
"lazeri", intonato dai giovani la settimana precedente quella
di Pasqua per commemorare la resurrezione di Lazzaro; per l'occasione i
giovani sono accompagnati dal sacerdote, il "papas". La
domenica delle palme si rievoca l'entrata di Cristo a Gerusalemme
attraverso la processione del vescovo che cavalca un asino e che ha le
mani occupate con un crocifisso ed una piccola palma. Il momento più
atteso dai fedeli è la lavanda dei piedi attuata il giovedì santo,
quando il sacerdote che impersona San Pietro accetta di farsi lavare
interamente dal vescovo. Il momento migliore per ascoltare i canti
tipici è il venerdì santo, quando si intonano i passi evangelici che
narrano la passione e morte del Cristo, eseguiti durante la mattinata;
il pomeriggio si ha invece il corteo dell'immagine del Cristo, preceduta
dal Crocefisso deposto in un'urna ricca di fiori ed incenso ed
accompagnata dai fedeli e dai canti funebri eseguiti dal sacerdote.
Il giorno del sabato santo è caratterizzato dai battesimi per
immersione, dalla liturgia di S. Basilio, dal salmo della resurrezione,
cantato, e dai sacerduti che indossano la veste bianca che sostituisce
il lutto.
Il giorno di Pasqua, nella Cattedrale di San Demetrio, si ha la
preparazione della "mensa", che riunisce tutti i fedeli.

Anche
a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, la settimana santa
è molto particolare. Il lunedi santo i confratelli della congregazione
di San Vito indossano un saio bianco ed un mantello blu, mentre quelli
della congregazione di S. Filippo indossano un saio bianco ed un
mantello viola; così vestiti, essi precedono il simulacro della Croce
di Cristo che è portata in processione. Gli stessi preparativi si hanno
per la processione del martedì santo che riguarda le congregazioni di
S. Giovanni e del SS. Salvatore e quella del mercoledi santo che
riguarda quella del SS. Sacramento.
Il giovedì santo è il giorno dei "sepolcri", che in questa
città prevedono non solo le tradizionali e già citate visite nelle
chiese della città, ma anche che tali visite siano sette, in onore dei
sacramenti, e che nelle chiese, oltre le tradizionali preghiere, i
fedeli debbano consumare del cibo nel sagrato dell'ultima chiesa
visitata. Si arriva al venerdì santo, che conclude questa quadro con la
processione dei simulacri del Cristo morto, che è deposto in un'urna, e
della Madonna Addolorata, evento che coinvolge tutta la popolazione.

A
Pietraperzia, in provincia di Enna, il venerdi santo si ha dalle
prime ore del giorno una processione di fedeli in preghiera che cantano
la passione del Cristo fino ad arrivare alla Chiesa del Carmine per
deporre il simulacro del Cristo nella Cappella che l'ha ospitato durante
l'anno. Nella piazza di fronte la Chiesa è montato un fercolo, un palo
di cipresso di otto metri al quale si fissano delle fasce di lino di 30
metri, simbolo della devozione; alla sera il Cristo è agganciato alla
croce del fercolo e, quando un fedele batte il terzo colpo ai chiodi
della croce, l'asta del Crocifisso è issata grazie alle fasce ed ha
inizio la processione con in testa il fercolo, mosso da almeno 500
fedeli, e che termina con la Madonna Addolorata, portata da gruppi
femminili. La processione ha due momenti particolari, le girate, che
sono effettuate in contrada Santa Croce e davanti la Chiesa Madre e che
servono per far girare su se stesso il fercolo.

La
settimana santa è coinvolgente anche ad Enna, visto che prevede
una sentita e concreta partecipazione delle dieci confraternite presenti
nella città. I festeggiamenti iniziano la domenica delle Palme con la
distribuzione e la benedizione dei rametti d'ulivo e delle palme. La
partecipazione delle confraternite è visibile già nella processione
del mercoledì santo, quando i simulacri del Cristo e dell'Addolorata
sono portati a spalla; le statue sono abbellite dai doni offerti dai
fedeli. Il giovedì santo i membri
delle
confraternite sono vestiti in modo particolare: hanno un saio ed un
cappuccio con i colori propri della propria confraternita; alcuni di
loro trasportano dei ceri e delle torce ed hanno il compito di
accopagnare le due vare in processione fino a notte fonda; i confrati
hanno anche il compito di portare i propri stendardi e dei vassoi con
dei simboli del martirio del Cristo, vassoi che poi saranno depositati
ai piedi dell'altare del duomo cittadino. Il venerdì santo i confrati
si ritrovano nel Duomo dove sono stati riposti i due simulacri, pronti
per ripartire per una nuova processione che durerà fino a notte fonda,
per poi rientrare nel Duomo. La domenica di Pasqua si ha l'incontro tra
la Madonna ed il figlio risorto, evento che attua la scomparsa del
dolore e l'arrivo della festa.

Il
venerdì santo ad Ispica, in provincia di Ragusa, è molto
particolare. La processione del "Cristo alla colonna" ha
origini molto antiche delle quali si coservano gli aspetti più sani e
si sono persi gli atteggiamenti più medievali come la costituzione di
un gruppo di fedeli che rappresentano i "flagellanti", degli
uomini a torso nudo e col capo cosparso di spine che si percuotevano le
spalle con vario materiale (corde, vetro, ferro, chiodi...).
Oggi la processione è organizzata dalla confraternita della Chiesa di
Santa Maria Maggiore che si occupa di prendere il simulacro del Cristo
alla Colonna e di attuare la processione che inizia dopo la mezzanotte
del giovedì santo fino alle prime luci dell'alba del venerdì, per poi
iniziare alle tre del pomeriggio. Prima della processione la statua è
sommersa dai baci dei fedeli ed è deposta in una vara. Questa cittadina
non è immune dalle diatribe tra i Santi presenti anche in altre città
isolane. Qui i cittadini si dividono tra "cavari",
appartenenti alla Chiesa di S. Maria Maggiore, e "nunziatari",
appartenenti alla Chiesa della SS. Annunziata. Entrambe le confraternite
volevano avere una parte
attiva nei festeggiamenti legati alla settimana santa e, per togliere
ogni problema, si è giunti ad una sorta di compromesso: una delegazione
dei nunziatari rendono omaggio alla Madonnina posta nella chiesa madre e
poi alla statua del Cristo preservata nella chiesa S. Maria Maggiore;
così inizia la processione organizzata dai cavari della chiesa di Santa
Maria Maggiore, mentre il venerdì santo è il turno dei nunziatari con
il Cristo alla Croce, previo prelevamento di una delegazione della
confraternita legata a Santa Maria Maggiore, l'inchino in onore della
statua della Madonna della Chiesa madre e a quella dei cavari.
Tutta
la settimana santa prevede vari eventi nel paesino Gangi, immerso
nelle Madonie (Pa). Tutto inizia, ovviamente, la domenica delle palme,
quando i vari esponenti delle confraternite, con i loro mantelli
ricamati, attraversano le vie della città portando in spalla delle
palme benedette. La preparazione di tale processione è molto
particolareggiata e prevede un certo cerimoniale.
Sono coinvolte le confraternite cittadine, una decina. A turno, seguendo
un preciso ordine ciclico, ognuna di loro ha il compito di provvedere
alla raccolta delle palme e dei datteri, ed il conseguente peso
economico dovuto alla raccolta. Le palme sono suddivise in gruppi di
dieci, tante quante sono le confraternite, e suddivise tra esse tramite
sorteggio. Dopo la suddivisione, le confraternite si predispongono per
la processione. Intanto, altri esponenti delle confraternite hanno il
compito di partecipare alla processione portando le insegne della
confraternita d'appartenenza. Un esponente per confraternita ha il
compito di portare in corteo il cero con il simbolo che rappresenta la
confraternita stessa, cero sostenuto da un bastone. Il corteo attraversa
la città e le confraternite hanno un posto assegnato in base allo
ordine cronologico della loro fondazione. Il corteo segue varie tappe
prestabilite, prima fra tutte di fronte la Chiesa madre dedicata a S.
Nicola di Bari, dove le palme sono benedette. Il corteo procede
ovviamente coinvolgendo i fedeli ma anche dei tamburi che accompagnano
tutto il percorso fino al rientro nella chiesa madre. Il giovedi santo
le confraternite si riuniscono nelle loro chiese attorno ad una tavola
ricca di pani a forma di agnello e preparati con la farina di semola. Il
venerdì santo si ha la processione di varie statue, che sono
trasportate a spalla, e cioè quelle di Gesù nell'orto del Getsemani,
di S. Maria della pietà, di Gesù e dell'Addolorata; le statue sono
accompagnate dai confrati che trasportano i ceri.
Il
momento più folkloristico è la domenica di Pasqua.
La conflittualità tra i devoti di diversi santi, tipica della Sicilia,
ha trovato una soluzione pittoresca e poco violenta nella gara molto
colorata presente sempre a Gangi, dove i devoti del Signore e
della Madonna si sfidano con la creazione di addobbi da riporre nella
via principale della città, a breve distanza tra loro e vicino il Duomo
cittadino. Tali addobbi assumono la forma di archi e sono creati con
materiale vario, come il pane e dei vegetali.
Il
venerdì santo a Monterosso Almo (Rg) si ha la rappresentazione
di alcune scene della passione di Gesù Cristo. Si ha anche la
processione del "cataletto", un'urna coperta da un velo bianco
e pieno di fiori dove è riposto il Cristo disceso dalla Croce, che in
un secondo momento è riportato in Chiesa dove si ha l'incontro con la
statua della Madonna, mentre i fedeli cantano il miserere.
A
Ribera, in provincia di Agrigento, la domenica di Pasqua si ha un
gran fermento: si devono preparare le tre statue coinvolte nell'incontro
che siboleggia la gioia della resurrezione, cioè le statue del Cristo
risorto, della Madonna e dell'Arcangelo Michele. La statua del Cristo,
addobbata con nastri colorati, fiori e fave verdi, e quella
dell'arcangelo, che ha il compito di annunziare la resurrezione alla
Madonna, sono preparati dagli uomini del paese, mentre quello della
Madonna, che indossa un manto celeste sotto quello nero del lutto, è
preparata dalle donne. L'incontro è organizzato sin nei minimi
particolari: già durante la settimana santa i giovani incaricati del
trasporto della statua si esercitano per assumere il giusto ritmo da
sostenere durante la processione. L'incontro tra Madre e Figlio avviene
a mezzogiorno, dopo che l'Arcangelo ha corso tra le due statue per
portare la notizia. Nel momento dell'incontro la Madonna si libera del
manto del lutto, mentre l'arcangelo s'allontana.

La
settimana santa ad Alimena, un paese in provincia di Palermo,
prevede una serie di processioni che vanno dalla domenica delle palme
fino al giovedì santo. Tali processioni molto ordinate prevedono la
partecipazione di narratori appartenenti a delle confraternite che
ricordano la passione del Cristo, mentre altri confrati hanno il compito
di trasportare dei ceri, tranne quello che porta una croce lignea; essi
sono seguiti da altri confrati che intonano le "lamentanze".
Il giovedì ed il venerdì santo si ripetono la fiaccolata e
l'adorazione della Croce. La fiaccolata si svolge la sera ed è
costituita dalla processione di un'urna in cui è riposto il Cristo e
della statua dell'Addolorata, accompagnati da dei bambini che portano
delle torce e dei membri delle confraternite che traspoetano dei grossi
ceri; la processione si ferma al Calvario per una breve sosta, per poi
arrivare alla Chiesa del Carmelo dove i bambini spengono le torce. Il
venerdì santo si allestiscono i sepolcri nei vari altari delle chiese,
costituiti da vasi contenenti fiori e piatti con semi germogliati; gli
appartenenti alle varie confraternite hanno il compito di visitare tre
chiese e sono accompagnati dalla banda musicale. A mezzogiorno si ripete
l'adorazione della Croce. Il momento più toccante è la processione,
così organizzata: la statua del Cristo è issata in una Croce ai piedi
della quale ci sono le statue della Madonna e di Maria Maddalena; quando
la processione giunge al Calvario, la statua del Cristo è staccata
dalla Croce e riposta nell'urna; il corteo ritorna su suio passi fino a
riporre le due statue e l'urna al loro posto.
A
Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, la processione del
venerdì santo prevede tre momenti distinti: l'incontro tra Gesù Cristo
e S. Giovanni Battista, Veronica che aciuga il volto del Cristo ed il
congiungimento dei simulacri del Cristo e della Madonna Addolorata. A
sera esce il simulacro destinato ad accogliere il corpo del Cristo ed il
maestro incappucciato che deve guidare la processione verso il Calvario
è nominato un'ora prima dell'inizio della processione e la sua identità
è conosciuta solo dal capo delle forze dell'ordine.
A
Vittoria (Rg) la settimana santa prevede per il giovedì santo
con la processione del "Cristo alla colonna", processione
dalle antiche origini, un tempo affidata alla congregazione omonima oggi
scomparsa e che prevede il giro del fercolo dorato del Cristo per le vie
della città. Il venerdì si ha la rappresentazione della "Scesa
della croce": nel tempio Calvario addobbato con delle maioliche
colorate rappresentanti scene della passione e morte di Cristo, gli
attori con l'abito d'epoca e recitanti in dialetto depongono il corpo
del Cristo sceso dalla croce in un'urna che viene portata in processione
per le vie cittadine fino a dove un tempo sorgeva la chiesa ed il
monastero di S. Teresa, per poi tornare nella chiesa madre dove il
Cristo è deposto nel letto funebre; una seconda processione riguarda il
Cristo morto insieme al simulacro di S. Maria Addolorata ed è
organizzata dalla congregazione del SS. Crocifisso; tale evento si
conclude con la crocifissione del simulacro del Cristo ed alla sua
destra è posto il simulacro della Madonna dentro il suo fercolo.
Il
sabato santo, nelle campagne di Terrasini (Pa), si ha un rito
particolare: si recide un albero selvaggio, generalmente un pompelmo,
alla radice, in modo che possa essere addobato collegialmente dal
comitato della festa degli scapoli, attraverso l'aggiunta di rami
posticci e di addobbi particolari. Il peso dell'albero così preparato
oscilla tra i 50 e i 55 chilogrammi. Tale evento ha radici remote e
simboleggia il risveglio della vegetazione. La benedizione degli alberi
rappresenta il ritorno della primavera, di primaria importanza
nell'economia agricola della Sicilia.
A
Comiso, in provincia di Ragusa, si hanno vari festeggiamenti per
la settimana santa. Il mercoledì santo si ha la processione che parte
dalla Chiesa madre e che compie tre giri: il primo è dedicato ai
sacerdoti e si svolge vicino la chiesa di S. Biagio, il secondo è
dedicato alla confraternita di Maria Ss. Addolorata ed il terzo è
dedicato alla congregazione del SS. Sacramento e si svolge vicino la
Chiesa dell'Annunziata. Il venerdì santo si ha una seconda processione:
il simulacro del Cristo Morto e quella di Maria Addolorata sono portati
per le vie della città.
Il sabato, domenica e lunedi di Pasqua le campane della Chiesa
dell'Annunziata sempre a Comiso, suonano a festa. Ricorre la festa di
Maria Annunziata, che però perde il titolo di festa patronale perchè
rientra nelle feste pasquali.
Prima che la giornata di sabato sia conclusa, la statua della Madonna è
prelevata dalla sua nicchia all'interno della Chiesa perchè il giorno
di Pasqua ci sarà la processione di questa statua insieme a quella del
Cristo risorto. Tale processione è denominata anche "la
pace": raggiunto uno spiazzale adeguatamente grande, le due stanze
sono poste l'una di fronte alla altra, a distanza di circa 50 metri, per
poi ricongiungersi in un incontro accompagnato dal battere delle mani
dei fedeli, dal movimento di fazzoletti bianchi per aria e
dall'esecuzione dell'inno reale da parte della banda musicale; questo
incontro è ripetuto più volte e raggiunge il suo culmine quando il
rito è ripetuto nella piazza fonte Diana, quando l'evento è anche
accompagnato dallo strepitio delle campane della chiesa. L'ultima
rappresentazione della "pace" si ha quando le statue rientrano
in Chiesa.
A
S. Biagio Platani (Ag) i devoti della Madonna e del Signore
trovano un motivo di gara la domenica di Pasqua, quando hanno il compito
di preparare gli addobbi che vanno ad abbellire il corso principale
cittadino e che consistono in mosaici, strutture archittettoniche,
fontane ... il tutto per riprodurre eventi biblici in onore della
Resurrezione del Cristo. Gli addobbi, preparati con materiale vario come
i cereali e vegetali di vario tipo e con molta cura dai due gruppi di
devoti facenti capo a due confraternite diverse, quella del SS.
Sacramento e del SS. Rosario, sono realizzati in gran segreto e servono
per abbellire la via principale, scenario dell'incontro tra il Cristo
risorto e la Madre.
Il
mezzogiorno del venerdì santo ad Acate (Rg) si ha l'incontro
della statua della Madonna in lutto per la perdita del figlio e del
Cristo che porta la croce sulle spalle. La statua della Madonna è
portata in spalla ed accompagata da delle ragazze, mentre quella del
Cristo è preceduta da delle bambine in abito bianco, alcune delle quali
portano il lenzuolo della Veronica, dove si asciugò Gesù Cristo; il
momento più particolare della processione si ha quando Cristo rende
omaggio alla Madre muovendo un braccio, a sua volta mosso attraverso dei
fili.

Il
venerdì santo di Canicattini Bagni (Sr) è caratterizzato da
molti anni da una processione che ha perso alcuni dettagli organizzativi
nel corso del tempo, ma non ha di sicuro perso il suo fascino ed il
coinvolgimento dei numerosi fedeli. Si porta in processione, attuata
attraverso l'ausilio di macchinari, la statua dell'Ecce Homo, in
cartapesta e posta su di un fercolo di stile gotico, immagine preceduta
da uno stendardo nero che anticamente era portato in processione dal
contadino che aveva offerto la più grossa quantità di grano al Signore
e che oggi è trasportata da una persona regolarmente retribuita. Anche
le offerte di prodotti agricoli attuate nel passato sono state
sostituite da quelle in denaro.
A
Modica (Rg), il giorno più caratterristico dei festeggiamenti
pasquali cade proprio il giorno di Pasqua, quando il simulacro della
Madonna ancora in lutto è portato in processione per la via pricnipale
della città, il corso Umberto; quando si scorge da lontano la statua
del Cristo risorto, la processione prevede l'incontro delle due statue,
la liberazione dal manto nero della Madonna ed il volo di colombe.
L'evento è noto con l'espressione di "Madonna Vasa-Vasa"
perchè, nel momento dell'incontro, le due statue si avvicinano per un
bacio. Tale bacio si ha nella piazza S. Domenico, vicino il Palazzo di
città. Tale festa risale al '600 ed ha origini spagnole.
La
settimana santa del capoluogo isolano prevede varie
manifestazioni come le rappresentazioni sacre dell'ultima Cena
all'interno delle varie chiese cittadine, manifestazioni che raccolgono
centinaia di giovani che lavorano per vari mesi per la loro riuscita. Ma
un giorno veramente particolare è il Venerdì Santo che prevede quattro
processioni, curate nei minimi particolari.
La prima è quella dei "cocchieri" che in passato, quando la
nobiltà palermitana era fiorente, era molto più fastosa perchè c'era
l'utilizzo di livree molto eleganti con i colori di riferimento delle
casate d'appartenenza. Oggi tale confraternita si è allargata a tutti i
ceti sociali, vista la già citata decadenza della nobiltà. I cocchieri
portano in processione la vara del Cristo morto ela statua della
Madonna; essi partono dalla Chiesa della Madonna dell'Itria nel primo
pomeriggio e le due vare sono portate a turno da 32 persone, scortate da
figuranti che indossano armature tordo-medievali.
La seconda processione è organizzata dalla confraternita dei
panettieri, intestata a S. Maria Addolorata. In questo caso i due
simulacri citati precedentemente sono scortati non solo dai fedeli, ma
anche dei figuranti che indossano delle armature romane complete di
tutto e costruite artigianalmente basandosi sull'esempio di maestri
pupari. La processione parte dalla sede della confraternita e segue i
confini del culto della Madonna. Il corteo si conclude a notte fonda con
un rito religioso, dopo aver coinvolto i sei figuranti con le armature
romane, le fanciulle devote alla Madonna, un "centurione
romano", l'urna del Cristo morto seguita da alcuni confrati e la
Statua della Madonna.
La terza processione riguarda la vergine SS. Addolorata della Soledad,
una processione che porta per le vie della città la scultura lignea del
Cristo morto e della Vergine della Soledad. In passato tale processione
coinvolgeva anche i corpi militari.
La quarta ed ultima processione del venerdì santo palermitano coinvolge
gli artigiani palermitani, devoti della Madonna del Lume, che portano il
simulacro della loro protettrice dalla loro sede fino al Teatro Massimo
e lungo le vie cittadine.





LA
"DIAVOLATA" DI ADRANO (CT)
Anche
ad Adrano, in provincia di Catania, la Domenica di Pasqua, si effettua
"La diavolata", una rappresentazione sacra d'origine
medievale.
Essa
si effettua nei pressi della piazza cittadina principale sfruttando come
scenario ideale il Castello-Museo cittadino.
In
questa zona e' costruito un palco che ospitera' cinque diavoli vestiti
di rosso che escono da una botola accompagnati da fiammate e fumo,
Lucifero, la Morte - indossa un abito raffigurante uno scheletro - ed un
angelo - e' rappresentato da un bambino -.
L'evento
e' costituito da una serie di discussioni sul bene e sul male e si
conclude quando l'Angelo costringe i diavoli a pronunciare la frase
"Viva".
Costumanze
analoghe sono diffuse in tutta Europa; basti pensare che addirittura in
Polonia esiste una diavolata simile a quella di Prizzi. A Kolednicy la
morte, armata di falce è seguita da due esseri infernali chiamati orsi,
tuttavia simili nella foggia del vestire e nelle mansioni ai diavuli
dell’abballu sicilianu. Ad Elzach (Selva Nera) compaiono le maschere
infernali degli Schuddingen, mentre in Austria (zona del Salisburghese)
nelle celebrazioni del solstizio invernale si ha una contesa tra i puri
e gli impuri. Anche nelle nazioni extraeuropee di cultura latina
esistono simili rituali.
La
chiesa veniva a proiettarsi nell’America Latina attraverso la Spagna e
mescolava alle antiche tradizioni locali usi e costumi cristiani,
modificati in funzione delle arcaiche credenze politeistiche. Da qui le
numerose fiestas de los diablos (diablade), feste del male celebrate nel
periodo di Pasqua. Ad Oruro (Bolivia) si svolge la più suggestiva ed
impressionante di queste fiestas dove comunque sono sempre protagonisti
i diavoli.
La
domenica di Pasqua della cittadina di Prizzi (Pa) prevede
l'abbellimento della via principale e l'incontro delle statue del Cristo
risorto e di Maria Addolorata, scortata da due angeli che portano in
mano una lancia. Ai piedi delle due statue si trovano due figuranti che,
con tute rosse ed una maschera in viso, impersonano i diavoli che devono
baciare i piedi delle due statue prima del loro incontro. Essi hanno una
catena in mano e sono accompagnati da un altro figurante in tuta gialla
e con una balaustra in mano e che rappresenta la morte. I tre hanno il
compito di disturbare e di ritardare l'incontro tra Madre e Figlio
muovendo le loro armi e ballando ai loro piedi, finchè, dopo 3
tentativi d'incontro, la Madre riconosce il Figlio e si libera
del manto
nero del lutto per rivelare il vestito della gioia, in colori più
tenui; In questo momento intervengono i due angeli per colpire i diavoli
con le loro lance. Ma i due si devono subito separare per poi arrivare
ad un successivo incontro, preceduto da un momento più profano che
prevede la presenza musicale, altri movimenti dei tre figuranti già
citati che disturbano i fedeli per raccogliere le offerte cheandranno a
coprire le spese dell'affitto dei costumi.
Il terzo incontro prevede un ulteriore intervento dei due angeli che
colpiscono i due diavoli, il simbolo del male, mentre la morte non è
toccata perchè è gia stata sconfitta dal Cristo. Anche in questo caso
la Madonna si libera del manto nero. Si hanno poi altri due incontri tra
le due statue.
La
lotta tra bene e male ha un'ulteriore rappresentazione, sempre a Prizzi,
ma stavolta dal sapore piu' profano rispetto alla precedente.
Alcuni cittadini si travestono da "diavoli" grazie all'ausilio
di grandi maschere torve e costumi rossi ed attraversano la citta' con
l'intento di prendere dei prigionieri da condurre all'inferno. Tale
luogo altro non e' che una comune osteria dove i "dannati"
sono obbligati a bere vino e ad offrirlo ai presenti.
Solo a tarda sera, quando oramai le botti saranno svuotate, interverra'
la Vergine, accompagnata da uno stuolo di angeli, a liberare i
malcapitati, nonostante un ulteriore intervento dei maligni che
cercheranno ancora di corrompere i malcapitati offrendo dei dolci.
Tutta
la settimana santa a Delia (Ag) prevede varie manifestazioni che
ricalcano quelle sacre che avvenivano nel 1700. Il giovedì santo si ha
la processione per le vie cittadine delle statue del Cristo e della
Vergini, fino alla loro separazione perchè Cristo deve affrontare da
solo i vari momenti della sua passione; nel pomeriggio si commemorano
l'ultima cena, il tradimento di Giuda e l'arresto del Cristo. Il venerdì
santo nel primo pomeriggio nella piazza vicino la chiesa madre dedicata
alla Madonna di Loreto si ha la rappresentazione del processo e della
condanna del Cristo, attuata da alcuni attori. In un secondo momento si
attua la rappresentazione della crocifissione del Cristo, nella parte più
alta del paese e con l'accompagnamento di canti attuati da parte dei
fedeli.La crocifissione è attuata dai sacerdoti. Dopo la Sua morte, il
corpo del Cristo è posto in un'urna che è portata in processione,
seguita dalla statua dell'Addolorata, di S. Giovanni, dalla banda
musicale e dai fedeli.
I
LAMINTATURI
Un tempo, molto più che oggi, l’attesa della Pasqua aveva un
carattere di penitenza ed in tempo di Quaresima i devoti digiunavano per
 partecipare
alle sofferenze patite dal Cristo. A mezzanotte del martedì grasso, il
tocco a morto delle campane annunciava l’inizio dei rituali
penitenziali ed i fedeli portavano in processione il Crocifisso
percotendosi ed intonando dei canti lugubri e lamentosi, detti, appunto,
“lamenti”, “lamentazioni” o “mortori”. Questi sono forme
poetico-musicali popolari che accentuano il pathos narrativo della
drammatizzazione e sono eseguiti dai cosiddetti “lamintaturi”,
composti da cinque o sei voci: il solista, che esegue le strofe, ed il
coro, che interviene a rafforzare la nota finale della strofa eseguita
dal solista. partecipare
alle sofferenze patite dal Cristo. A mezzanotte del martedì grasso, il
tocco a morto delle campane annunciava l’inizio dei rituali
penitenziali ed i fedeli portavano in processione il Crocifisso
percotendosi ed intonando dei canti lugubri e lamentosi, detti, appunto,
“lamenti”, “lamentazioni” o “mortori”. Questi sono forme
poetico-musicali popolari che accentuano il pathos narrativo della
drammatizzazione e sono eseguiti dai cosiddetti “lamintaturi”,
composti da cinque o sei voci: il solista, che esegue le strofe, ed il
coro, che interviene a rafforzare la nota finale della strofa eseguita
dal solista.
Oggi i lamenti sono eseguiti solo durante le processioni della Settimana
Santa e, quasi esclusivamente, dalle persone più anziane. Molto spesso
i testi dei lamenti sono incomprensibili alla gente che li ascolta, ma
quel che conta è la suggestione che essi riescono a creare, le emozioni
che riescono a suscitare. Essi sono il grido di dolore della Madre per
la perdita del figlio, l’urlo dell’umanità per non aver compreso la
Parola di Gesù.
Durante
la settimana santa a S. Cataldo, in provincia di Caltanissetta,
si svolge una particolare rappresentazione, un processo a Gesu' Cristo
che si attua per tre giorni di seguito presso la Chiesa del Rosario.
L'evento coinvolge numerosi figuranti che rappresentano cavalieri,
centurioni e legionari, nonche' Gesu' Cristo e Pilato.
Sono coinvolte anche delle "vare", dei gruppi statuari
realizzati in cartapesta risalenti al 1800 e rappresentanti episodi
della passione di Gesu'.
La domenica di Pasqua tutto lo scenario ed il clima cambiano, tutto
diventa piu' allegro e festoso ed al posto del processo e' effettuata
una particolare sfilata alla quale partecipano i "Salaparuta",
delle statue di cartapesta risalenti al 1800, come nel caso precedente,
e figuranti che rappresentano gli undici apostoli.
La
domenica di Pasqua ad Adrano, in provincia di Catania, si
effettua "La diavolata", una rappresentazione sacra d'origine
medievale.
Essa si effettua nei pressi della piazza cittadina principale sfruttando
come scenario ideale il Castello-Museo cittadino.
In questa zona e' costruito un palco che ospitera' cinque diavoli
vestiti di rosso che escono da una botola accompagnati da fiammate e
fumo, Lucifero, la Morte - indossa un abito raffigurante uno scheletro -
ed un angelo - e' rappresentato da un bambino -. L'evento e' costituito
da una serie di discussioni sul bene e sul male e si conclude quando
l'Angelo costringe i diavoli a pronunciare la frase "Viva
Maria".
|

Volto la testa verso
il prato dove sono nato, voglio vederla, forse è lei con il
muso infilato fra le sbarre che mi chiama, che mi chiama,
poi entriamo in una stanza e qui ci sbattono a terra. Che
posto strano. Ci sono dei ganci che pendono dal soffitto e
ci sono delle macchie scure sui muri. Mi avvicino, ne annuso
una, è un odore pungente che mi ricorda il sangue, ma non
può essere sangue, sono macchie troppo grandi, poi quello
strano essere che chiamano uomo afferra uno dei miei amici
agnellini per le zampe, lo lega al gancio, fa lo stesso
anche con l’altro, poi è il mio turno. Mi divincolo, ho
paura, voglio la mamma, ma quelle braccia sono troppo forti
e lo vedo, l’uomo, lo vedo mentre belo e piango a testa in
giù, lo vedo che prende un oggetto da un tavolino, si
avvicina a me, mi prende per la testa, me la solleva e
l’ultimissima cosa che ricordo, prima che tutto diventi
scuro, è che quando sono nato ed ho cercato di mettermi in
piedi sulle zampe il muso di mamma era lì, a sostenermi, ed
io ho pensato che ci sarebbe stato tutta la vita.
P.S.: 22 sono in media i giorni che vivono gli agnelli
destinati ad essere ammazzati per Pasqua
di Alessandro Vegano Vettorato |
Ho ancora gli occhi
impastati di sogni quando gli esseri strani a due zampe
entrano nella stalla e mi svegliano. Non lo fanno molto
delicatamente, mi rovesciano a testa in giù e mi tirano su
per le zampe. Mi fanno male, cerco di farglielo capire
belando, ma quello che mi ha preso mi scuote, dice delle
cose in un linguaggio strano, sembra arrabbiato. Cerco mamma
con lo sguardo, la trovo, lei è sveglia e sta belando forte.
Mi dice che mi vuole bene. Mi dice che sarò sempre il suo
bambino. Mi dice che non mi dimenticherà. Mamma piange. Mi
portano via. Il mondo a testa in giù è anche divertente da
vedere, ma non voglio che mamma sia triste. Le mani che mi
tengono le zampe stringono, fanno male. Vedo che stanno
portando via anche altri due agnellini.
Dove ci portano?
Siamo fuori. Siamo fuori dal prato. Abbiamo superato le
sbarre. Forse questo significa diventare grandi. Avere il
vello folto. Ma la mamma mi manca.
|

Il
martedì di Pasqua a Palagonia, in provincia di Catania, si
festeggia S. Febronia. La tradizione religiosa ci tramanda che tale
ragazza visse, nei primi anni del IV secolo, in un monastero ai confini
della Siria. finchè l'imperatore Diocleziano inviò lì i suoi ministri
per arginare la diffusione del Cristianesimo e la ragazza fu
martirizzata. A tali eventi sono stati aggiunti dei particolari: pare
che un frate, di ritorno da Roma alla sua città natale Militello con
delle reliquie - comprese quelle di S. Febronia - perse la strada e si
riparò vicino palagonia; durante la notte sognò la Santa che gli
raccomandò di portare le sue reliquie a Palagonia; il giorno seguente
il frate riprese il suo viaggio, noncurante del sogno, ma fu interrotto
nuovamente da un temporale e si riparò nelle grotte dette "li
costi"; qui decise di obbedire alla Santa. La sera del lunedì di
Pasqua la Chiesa madre della città è gremita di fedeli che guardano
verso l'altare maggiore dove è posto un tronco d'albero diviso in due
dove è posta una statua della Santa iin atteggiamento di preghiera,
mentre degli angeli scendono dall'alto per deporre una corona nella
testa della statua. Il giorno della festa la statua della Santa è
portata in processione fino alle grotte Li Costi, per poi ritornare
nella chiesa madre per recitare un ottavario, per poi ripartire in
processione. un tronco d'albero diviso in due
dove è posta una statua della Santa iin atteggiamento di preghiera,
mentre degli angeli scendono dall'alto per deporre una corona nella
testa della statua. Il giorno della festa la statua della Santa è
portata in processione fino alle grotte Li Costi, per poi ritornare
nella chiesa madre per recitare un ottavario, per poi ripartire in
processione.
Il
secondo giovedì dopo Pasqua si festeggia S. Francesco da Paola a Palermo.
E' noto che il patronato della città spetta a S. Rosalia, ma qui come
in altre città isolane sono festeggiati altri Santi, e precisamente S.
Francesco da Paola. La storia di questo Santo ci fa sapere che Egli
nacque il 1416, nacque e morì di venerdì ed ebbe un colloquio di 13
ore con la Madonna ed il dono da Dio di elargire 13 grazie giornaliere
ai suoi devoti.
Per i primi 13 venerdì dell'anno si attuano i cosiddetti
"viaggi" a Lui dedicati, cioè dei pellegrinaggi effettuati
dai suoi fedeli, in particolar modo le donne incinte, nella sua Chiesa
recitando il santo rosario.
Alla fine di questi 13 venerdì si arriva quasi sempre alla settimana
santa, quando tutti gli altri festeggiamenti sono generalmente sospesi e
ci si concentra sulla Passione e morte del Cristo.
Si deve attendere il secondo giovedì dopo Pasqua per ricominciare i
festeggiamenti con la preparazione dell'imponente statua in argento del
Santo che l'indomani riceverà le offerte dei fedeli e gli ex-voto. La
domenica successiva si ha la processione della Statua in un bagno di
folla e per le vie cittadine; durante la processione il Superiore della
confraternita dei muratori, che ha come Santo protettore proprio S.
Francesco, un uomo eletto precedentemente, ha il privilegio di far
fermare la statua vicino le abitazioni di familiari, amici e persone di
riguardo.

Mmiàti
l'occhi chi vìttiru Pasqua, si diceva un tempo: beati coloro che sono
arrivati vivi - e felicemente - alla nuova Pasqua. Festa sentita,
desiderata, gioiosa, nonostante l'intermezzo del Venerdì Santo con le
relative processioni, i "misteri", le sacre rappresentazioni.
 Verrà
infatti il Sabato Santo - annunciato dalle campane a festa - che
perentoriamente ci invitano alla pace, alla serenità, alla contentezza
(non per nulla dice il proverbio: èssiri cuntèntu comu na Pasqua).
Certo non è cosi per tutti: qualche sfortunato avrà in questo periodo
i suoi contrattempi e il detto vèniri la Pasqua di joviri a unu, ossia
il sopraggiungere la Pasqua di giovedì, ne sta ad indicare la
scombinata condizione. Se qualcun altro avrà addirittura subìto delle
disgrazie, si dirà fici na mala Pasqua (proprio come accadde al povero
compare Turiddu di buona memoria). Verrà
infatti il Sabato Santo - annunciato dalle campane a festa - che
perentoriamente ci invitano alla pace, alla serenità, alla contentezza
(non per nulla dice il proverbio: èssiri cuntèntu comu na Pasqua).
Certo non è cosi per tutti: qualche sfortunato avrà in questo periodo
i suoi contrattempi e il detto vèniri la Pasqua di joviri a unu, ossia
il sopraggiungere la Pasqua di giovedì, ne sta ad indicare la
scombinata condizione. Se qualcun altro avrà addirittura subìto delle
disgrazie, si dirà fici na mala Pasqua (proprio come accadde al povero
compare Turiddu di buona memoria).
 Ma
una cosa è certa: le campane del Sabato Santo invitano tutti quanti
alla tavola, per degustare una eccezionale quanto tipica gastronomia. Al
contrario di altre festività, le cui tradizioni si vanno man mano
perdendo, alcune abitudini legate alla Pasqua sono rimaste immutate nel
tempo: tra queste l'uso di cucinare l'agnello, di offrire e mangiare
uova e la preparazione di una grande varietà di dolciumi. Insomma un
gran lavorìo di cucina che giustamente ha fatto sorgere il detto avìri
cchiù chiffàri di lu furnu di Pasqua. Ma
una cosa è certa: le campane del Sabato Santo invitano tutti quanti
alla tavola, per degustare una eccezionale quanto tipica gastronomia. Al
contrario di altre festività, le cui tradizioni si vanno man mano
perdendo, alcune abitudini legate alla Pasqua sono rimaste immutate nel
tempo: tra queste l'uso di cucinare l'agnello, di offrire e mangiare
uova e la preparazione di una grande varietà di dolciumi. Insomma un
gran lavorìo di cucina che giustamente ha fatto sorgere il detto avìri
cchiù chiffàri di lu furnu di Pasqua.
L'agnello
e le uova compaiono anche nelle pasticcerie. Le vetrine si riempiono di
picureddi, pecorelle di pasta reale, la cui posa è divenuta ormai un
classico: sdraiate su un fianco sopra un prato verde disseminato di
confettini multicolori, con una banderuola rossa, simile a quella che
nell'iconografia sacra è in mano a San Giovanni, infilzata sul dorso.
Le
uova, di cioccolata e prodotte industrialmente, custodiscono la
"sorpresa" facendo bella mostra di sé infiocchettate e
rivestite di coloratissima carta. Ma in quasi tutta l'Isola, nelle
famiglie che osservano ancora le tradizioni, si dispongono a tavola uova
sode colorate e si preparano i pupi cu' l'ova, panierini di pasta da
pane che contengono, immersi o affioranti, delle uova, spesso colorate.
Le forme di questi dolci casalinghi sono tantissime e spesso curiose
come i nomi con i quali vengono indicati: aceddi cu' l'ova, panarina,
cuddùra, cudduredda e così via.
Notevole,
per varietà e quantità, è pure la produzione di biscotteria da forno
come i viscòtta di casa, tradizionali nella foggia e genuini nel
riispetto di semplici e antiche ricette.
 Ma
su tutti di dolciumi, su tutta la pasticceria, assurge a mito la
cassata, ormai famosa in tutto il mondo. Costituiva, almeno quando
veniva preparata solo per Pasqua, il punto di arrivo per una degna
celebrazione della festività. Cassate grandi, piccole, cassatèddi di
ogni forma e dimensioni, tutte ben gonfie di ricotta addolcita, decorate
e impinguate con frutta candita e marmellata di albicocca, ricoperte da
glasse colorate. Quasi un obbligo consumare per Pasqua le cassate (cu
nn'appi nn'appi cassatèddi 'i Pasqua), a meno di non essere
estremamente poveri: mischìnu cu nun manciàu cassàti 'a matìna 'i
Pasqua. Ma
su tutti di dolciumi, su tutta la pasticceria, assurge a mito la
cassata, ormai famosa in tutto il mondo. Costituiva, almeno quando
veniva preparata solo per Pasqua, il punto di arrivo per una degna
celebrazione della festività. Cassate grandi, piccole, cassatèddi di
ogni forma e dimensioni, tutte ben gonfie di ricotta addolcita, decorate
e impinguate con frutta candita e marmellata di albicocca, ricoperte da
glasse colorate. Quasi un obbligo consumare per Pasqua le cassate (cu
nn'appi nn'appi cassatèddi 'i Pasqua), a meno di non essere
estremamente poveri: mischìnu cu nun manciàu cassàti 'a matìna 'i
Pasqua.
La
cassata è il dolce che in tutto il mondo immediatamente si identifica
con la pasticceria siciliana. La sua origine è un dolce arabo, il
quas'at, una specie di zuccotto di tuma fresca dolcificata con zucchero.
Non
incontrando il gusto dei siciliani, questi sostituirono dapprima la tuma
con la ricotta dolcificata, foderandola in un secondo tempo con pan di
Spagna. Bisognerà aspettare la metà del 1700 perché la cassata assuma
la sua forma definitiva e simile a quella attuale, con le decorazioni
barocche realizzate con canditi colorati, ad opera, così sembra, delle
suore del Monastero di Valverde in Palermo.
Dell'antica
tradizione della cassata in Sicilia, fa fede un documento del Sinodo di
Mazzara del 1575 (capitolo XXI, pag.IV) dove si legge che la cassata è
uno dei dolci "immancabili nelle festività". La preparazione
casalinga è teoricamente semplice, ma la bravura consiste nel saperne
armonizzare gli ingredienti.
Giuseppe
Coria
Articolo
tratto da "La Sicilia Ricercata" Bruno
Leopardi
http://www.press.sicilia.it/pasqua_in_sicilia7.cfm

La
colomba della Pasticceria Savia di Catania. Pan di spagna, crema e
marmellata alle mandorle.

Il Quaresimale, altro dolce tipico di
Pasqua... Mandorle, uova, zucchero, scorza arancia, miele, cannella e
vaniglia.
L'uovo
rappresenta la Pasqua nel mondo intero: c'è quello dipinto, intagliato,
di cioccolato, di terracotta e di carta pesta. Ma mentre le uova di
cartone o di cioccolato sono di origine recente, quelle vere, colorate o
dorate hanno un'origine radicata nel lontano passato.
Le
uova, infatti, forse per la loro forma e sostanza molto particolare,
hanno sempre rivestito un ruolo unico, quello del simbolo della vita in
sé, ma anche del mistero, quasi della sacralità. Già al tempo del
paganesimo in alcune credenze, il Cielo e la Terra erano ritenuti due
metà dello stesso uovo, e le uova erano il simbolo del ritorno della
vita.
Gli uccelli infatti si preparavano il nido e lo utilizzavano per le
uova: a quel punto tutti sapevano che l'inverno ed il freddo erano ormai
passati.
I
Greci, i Cines i ed i Persiani se li scambiavano come dono per le feste
Primaverili, così come nell'antico Egitto le uova decorate erano
scambiate all'equinozio di primavera, data di inizio del "nuovo
anno", quando ancora l'anno si basava sulle le stagioni. i ed i Persiani se li scambiavano come dono per le feste
Primaverili, così come nell'antico Egitto le uova decorate erano
scambiate all'equinozio di primavera, data di inizio del "nuovo
anno", quando ancora l'anno si basava sulle le stagioni.
L'uovo era visto come simbolo di fertilità e quasi magia, a causa
dell'allora inspiegabile nascita di un essere vivente da un oggetto
così particolare.
Le uova venivano pertanto considerate oggetti dai poteri speciali, ed
erano interrate sotto le fondamenta degli edifici per tenere lontano il
male, portate in grembo dalle donne in stato interessante per scoprire
il sesso del nascituro e le spose vi passavano sopra prima di entrare
nella loro nuova casa.
Le
uova, associate alla primavera per secoli, con l'avvento del
Cristianesimo divennero simbolo della rinascita non della natura ma
dell'uomo stesso, della resurrezione del Cristo: come un pulcino esce
dell'uovo, oggetto a prima vista inerte, Cristo uscì vivo dalla sua
tomba.
Nella
simbologia, le uova colorate con colori brillanti rappresentano i colori
della primavera e la luce del sole. Quelle colorate di rosso scuro sono
invece simbolo del sangue del Cristo.
L'usanza di donare uova decorate con elementi preziosi va molto indietro
nel tempo e già nei libri contabili di Edoardo I di Inghilterra risulta
segnata una spesa per 450 uova rivestite d'oro e decorate da donare come
regalo di Pasqua.
Ma le uova più famose furono indubbiamente quelle di un maestro orafo,
Peter Carl Fabergé, che nel 1883 ricevette dallo zar Alessandro, la
commissione per la creazione di un dono speciale per la zarina Maria.
Il primo Fabergé fu un uovo di platino smaltato bianco che si apriva
per rivelare un uovo d'oro che a sua volta contenva un piccolo pulcino
d'oro ed una miniatura della corona imperiale.
Gli zar ne furono così entusiasti che ordinarono a Fabergé di
preparare tutta una serie di uova da donare tutti gli anni.


Aceddu
cu l'ova. Ingredienti
1 kg di farina 450 gr di zucchero 250 gr margarina 5 uova 2 buste di
lievito 2 buste di vanillina uova
q.b. per guarnire i biscotti codette ( o ciriminnacchi ) q.b.
Preparazione
Unite farina, lievito,
vanillina, zucchero, uova e margarina, impastate tutto insieme e
lasciate riposare per qualche minuto.
Mettete a bollire le uova che serviranno per guarnire i biscotti.
Stendete la pasta e date ai biscotti la forma a cuore o la forma che
preferite. Adagiate sul biscotto le uova precedentemente bollite (
potete mettere uno o più uova a seconda della dimensione che avete dato
al biscotto ).
Spennellate il biscotto con l' albume, precedentemente montato a neve, e
guarnire con le codette.
Mettete in forno a temperatura moderata 180° e fate cuocere finché il
biscotto non sia dorato.

Un ci ha prumettiri voti ê santi e
manco cuddureddi ê picciriddi...
La 'cudduredda' è una sorta di
panbiscotto siciliano che si otteneva dall'impasto residuo del prodotto
da forno tipico pasquale (un po' più noto) che prende appunto il nome di
'Cuddura'. Quest'ultima assume diverse forme, ma è sempre variopinto
(grazie soprattutto alla diavolina variopinta per dolci, detta 'ciriminnacchi'
in siciliano) e a tema pasquale, con l'aspetto di uccelli, campane,
canestri o altre fantasie che ispiravano le nonne e ispirano ancora oggi
i cuochi/artisti di Sicilia. La tradizione della cuddura è arcaica, come
testimonia il nome stesso, derivante dal greco 'Kollura', pagnotta. In
Grecia, ancora adesso è usanza pasquale benedire e condividere un grosso
pandolce su cui campeggia un uovo, cotto nella stessa infornata del
pane.
Esistono anche altre interessanti
varianti, tanto nel nome quanto nella ricetta. I 'pani cû l'ova', fanno
riferimento alla traduzione letterale del dolce greco; i 'pupi cû l'ova',
per la forma a bamboline (donne o cavalieri); 'aceddi cû l'ova', per
l'aspetto simile ad un uccello (il riferimento è alla colomba
pasquale)...
Esistono comunque diverse altre
pietanze simili in quasi tutto il Mezzogiorno e persino in Sardegna,
dove sono le 'Coccoi'. Ogni regione ha la sua variante di impasto, ma
generalmente tutti questi prodotti tendono ad assomigliarsi: una pasta
che varia dal pandolce morbido ma secco e dalla mollica fitta al
biscotto vero e proprio.
E il significato del proverbio in
oggetto?
Be', mai promettere nulla con
leggerezza, poiché si sa che non sempre si ha la certezza di poter
mantenere la parola data, come non è certo che avanzi impasto per fare i
cuddureddi (gustabili prima della Pasqua vera e propria ed in ogni caso
destinati ai soli piccini) né tantomeno si riesce a mantenere un voto
promesso a qualsiasi santo.
Perché l'essere umano, è fin troppo
facile alle tentazioni.
Iorga Prato

Si
sa, per chi va in Sicilia, è impossibile non assaggiare anche per
sbaglio una fetta di questo originalissimo e coloratissimo, nonché
ottimo dolce tipico della tradizione gastronomica locale.
Di
cosa stiamo parlando?! Ma della Cassata naturalmente!
Un documento ufficiale del sinodo dei Vescovi Siciliani, tenutosi a
Mazara del Vallo nel 1575, afferma infatti, che la Cassata è un dolce
irrinunciabile durante il periodo Pasquale ed a testimonianza di questo
c’è anche un antico proverbio Siciliano che recita: “Tintu è cu
nun mancia a cassata a matina ri pasqua”, letteralmente, “meschino
chi non mangia la Cassata la mattina di Pasqua”.
La
Cassata siciliana è un dolce molto calorico a causa della
ipercaloricità degli ingredienti e della densità del dolce.
Il
segreto della cassata sta nel dosare in modo sapiente gli ingredienti in
modo tale da ottenere un dolce non stucchevole e con un gusto
bilanciato.
La
Cassata siciliana è una tradizionale torta siciliana a base di ricotta
zuccherata, pan di Spagna, pasta reale, frutta candita e glassa di
zucchero. Come per
ogni ricetta tipica di una regione, anche della Cassata esistono
innumerevoli varianti locali diverse soprattutto per le svariate
decorazioni che possono variare da una semplice decorazione fatta di
glassa e un po’ di scorza d’arancia candita fino a opulente
decorazioni realizzate con perline e frutta candita.
Naturalmente,
sempre secondo le varianti locali, ci possono essere numerosi
ingredienti aggiuntivi come pistacchio, cioccolato, pinoli, cannella,
maraschino ed acqua di zagara. Una
delle varianti più famose è quella dei “Minnuzzi di Sant’Aita”,
dolci tipici della bellissima Catania dove vengono preparati in
occasionedella festa patronale.
Questi
dolci, fatti con pan di spagna imbevuto di liquore, farcito con crema, e
ricoperti di glassa bianca con sopra una ciliegia candita, rappresentano
una mammella e simboleggiano una chiara allegoria delle mammelle che
furono asportate alla Santa prima del martirio finale.
Per
quanto riguarda le origini della Cassata, questo dolce il cui nome
deriva dall’ arabo “qas’at“, “bacinella”, risale alla
dominazione saracena in Sicilia dal IX al XI secolo.
Gli
Arabi, infatti, avevano introdotto nella gastronomia Siciliana la canna
da zucchero, il limone, il cedro, l’arancia amara, il mandarino e
lamandorla che, insieme alla tipica ricotta che si produceva in Sicilia
fin dall’antichità, sono gli ingredienti base per la preparazione
della Cassata.
C’è
da dire che però, all’inizio, la Cassata non era altro che un
involucro di pasta frolla con un ripieno di ricotta ed una copertura di
zucchero mentre, con l’avvento della dominazione Normanna, fu “inventata”
la cosiddetta “pasta reale” un impasto di farina di mandorle e
zucchero, che, colorato di verde con estratti di erbe, sostituì la
pasta frolla come involucro decretando così, il passaggio dalla cassata
al forno a quella a freddo.
Furono gli Spagnoli ad inserire poi il cioccolato ed il pan di Spagna in
Sicilia, ed in seguito, durante il Barocco furono introdotti anche
icanditi, altro elemento essenziale della Cassata.Custodi del segreto
della cassata erano soprattutto le suore dei monasteri ed i cuochi dei
nobili casati. Alcuni monasteri, come quello di Valverde, erano famosi
per la qualità e la delicatezza della loro cassata che veniva preparata
prevalentemente durante il periodo Pasquale.



|






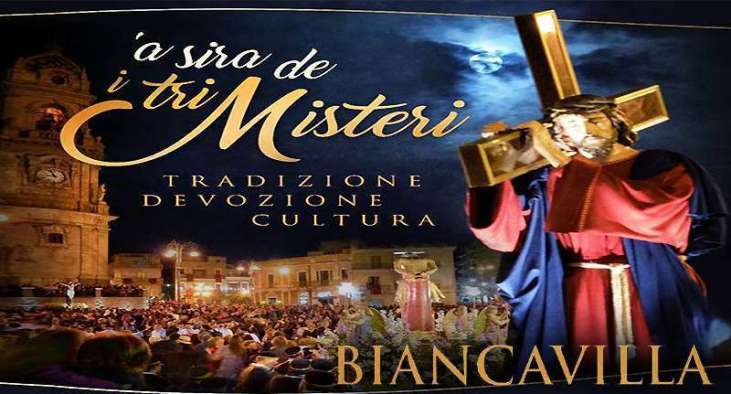
















 partecipare
alle sofferenze patite dal Cristo. A mezzanotte del martedì grasso, il
tocco a morto delle campane annunciava l’inizio dei rituali
penitenziali ed i fedeli portavano in processione il Crocifisso
percotendosi ed intonando dei canti lugubri e lamentosi, detti, appunto,
“lamenti”, “lamentazioni” o “mortori”. Questi sono forme
poetico-musicali popolari che accentuano il pathos narrativo della
drammatizzazione e sono eseguiti dai cosiddetti “lamintaturi”,
composti da cinque o sei voci: il solista, che esegue le strofe, ed il
coro, che interviene a rafforzare la nota finale della strofa eseguita
dal solista.
partecipare
alle sofferenze patite dal Cristo. A mezzanotte del martedì grasso, il
tocco a morto delle campane annunciava l’inizio dei rituali
penitenziali ed i fedeli portavano in processione il Crocifisso
percotendosi ed intonando dei canti lugubri e lamentosi, detti, appunto,
“lamenti”, “lamentazioni” o “mortori”. Questi sono forme
poetico-musicali popolari che accentuano il pathos narrativo della
drammatizzazione e sono eseguiti dai cosiddetti “lamintaturi”,
composti da cinque o sei voci: il solista, che esegue le strofe, ed il
coro, che interviene a rafforzare la nota finale della strofa eseguita
dal solista.



 Verrà
infatti il Sabato Santo - annunciato dalle campane a festa - che
perentoriamente ci invitano alla pace, alla serenità, alla contentezza
(non per nulla dice il proverbio: èssiri cuntèntu comu na Pasqua).
Certo non è cosi per tutti: qualche sfortunato avrà in questo periodo
i suoi contrattempi e il detto vèniri la Pasqua di joviri a unu, ossia
il sopraggiungere la Pasqua di giovedì, ne sta ad indicare la
scombinata condizione. Se qualcun altro avrà addirittura subìto delle
disgrazie, si dirà fici na mala Pasqua (proprio come accadde al povero
compare Turiddu di buona memoria).
Verrà
infatti il Sabato Santo - annunciato dalle campane a festa - che
perentoriamente ci invitano alla pace, alla serenità, alla contentezza
(non per nulla dice il proverbio: èssiri cuntèntu comu na Pasqua).
Certo non è cosi per tutti: qualche sfortunato avrà in questo periodo
i suoi contrattempi e il detto vèniri la Pasqua di joviri a unu, ossia
il sopraggiungere la Pasqua di giovedì, ne sta ad indicare la
scombinata condizione. Se qualcun altro avrà addirittura subìto delle
disgrazie, si dirà fici na mala Pasqua (proprio come accadde al povero
compare Turiddu di buona memoria).
 Ma
una cosa è certa: le campane del Sabato Santo invitano tutti quanti
alla tavola, per degustare una eccezionale quanto tipica gastronomia. Al
contrario di altre festività, le cui tradizioni si vanno man mano
perdendo, alcune abitudini legate alla Pasqua sono rimaste immutate nel
tempo: tra queste l'uso di cucinare l'agnello, di offrire e mangiare
uova e la preparazione di una grande varietà di dolciumi. Insomma un
gran lavorìo di cucina che giustamente ha fatto sorgere il detto avìri
cchiù chiffàri di lu furnu di Pasqua.
Ma
una cosa è certa: le campane del Sabato Santo invitano tutti quanti
alla tavola, per degustare una eccezionale quanto tipica gastronomia. Al
contrario di altre festività, le cui tradizioni si vanno man mano
perdendo, alcune abitudini legate alla Pasqua sono rimaste immutate nel
tempo: tra queste l'uso di cucinare l'agnello, di offrire e mangiare
uova e la preparazione di una grande varietà di dolciumi. Insomma un
gran lavorìo di cucina che giustamente ha fatto sorgere il detto avìri
cchiù chiffàri di lu furnu di Pasqua.
 Ma
su tutti di dolciumi, su tutta la pasticceria, assurge a mito la
cassata, ormai famosa in tutto il mondo. Costituiva, almeno quando
veniva preparata solo per Pasqua, il punto di arrivo per una degna
celebrazione della festività. Cassate grandi, piccole, cassatèddi di
ogni forma e dimensioni, tutte ben gonfie di ricotta addolcita, decorate
e impinguate con frutta candita e marmellata di albicocca, ricoperte da
glasse colorate. Quasi un obbligo consumare per Pasqua le cassate (cu
nn'appi nn'appi cassatèddi 'i Pasqua), a meno di non essere
estremamente poveri: mischìnu cu nun manciàu cassàti 'a matìna 'i
Pasqua.
Ma
su tutti di dolciumi, su tutta la pasticceria, assurge a mito la
cassata, ormai famosa in tutto il mondo. Costituiva, almeno quando
veniva preparata solo per Pasqua, il punto di arrivo per una degna
celebrazione della festività. Cassate grandi, piccole, cassatèddi di
ogni forma e dimensioni, tutte ben gonfie di ricotta addolcita, decorate
e impinguate con frutta candita e marmellata di albicocca, ricoperte da
glasse colorate. Quasi un obbligo consumare per Pasqua le cassate (cu
nn'appi nn'appi cassatèddi 'i Pasqua), a meno di non essere
estremamente poveri: mischìnu cu nun manciàu cassàti 'a matìna 'i
Pasqua.


 i ed i Persiani se li scambiavano come dono per le feste
Primaverili, così come nell'antico Egitto le uova decorate erano
scambiate all'equinozio di primavera, data di inizio del "nuovo
anno", quando ancora l'anno si basava sulle le stagioni.
i ed i Persiani se li scambiavano come dono per le feste
Primaverili, così come nell'antico Egitto le uova decorate erano
scambiate all'equinozio di primavera, data di inizio del "nuovo
anno", quando ancora l'anno si basava sulle le stagioni.





 LA
PASQUETTA DI LITTERIO
LA
PASQUETTA DI LITTERIO
