|


|

L a
storia della gastronomia siciliana e' come una favola che ha inizio con
il classico "c'era una volta".
Iniziamo a
raccontare: C'era una volta una civilta' classica: i Greci.
I
Greci
provenienti dalle Cicladi nel 735 a.C. sbarcarono sul litorale ionico, in
prossimita' dell'odierna Naxos, ed i Corinzi di Archia nel 734 a.C. furono a
Siracusa. Diverse, come sappiamo, furono le novita' che apportarono questi
colonizzatori e, per restare in tema, da un punto di vista alimentare, L'arte
del fare il vino nasce proprio da loro, I'ulivo, il farro ed altri prodotti,
gia' esistenti nell'isola, vennero utilizzati in modo diverso, ebbero, per cosi'
dire, una nuova impronta greca che porto' ad ottimi risultati.
Prendiamo per esempio il farro.
Il Farro, prima dei Greci, veniva utilizzato in Sicilia, per fare il pane, poi,
venne utilizzato in tutt'altro modo.
Con la farina di Farro, oltre a un ottimo pane, si ottennero delle tagliatelle
molto saporite e, niente poco di meno che, la pasta frolla.
Con il farro macinato grosso essi si fecero delle ottime zuppe ed, infine, con
il seme intero, unito a fave, lenticchie, ceci, ed interiora, la famosa Fabata
Puls.
Questo non ci deve fare credere che quando i Greci sbarcarono la Sicilia era
abitata da selvaggi.
Sulle coste ioniche abitavano i
Siculi
ed in quelle tirreniche prosperavano i Sicani e gli
Elimi.
Queste
antiche popolazioni avevano eretto potenti e progredite citta', dove,
almeno da tre millenni si era sviluppata una cucina autoctona.
L'incontro di queste due civilta' mediterranee ha arricchito tutte le
arti, compresa quella culinaria ed ha fatto nascere il gusto per la buona
cucina che trovo', piu' tardi, grande accoglienza nella Grecia dove, a
poco a poco, gli elaborati manicaretti si sostituirono ai voluminosi
arrosti dei tempi omerici ed alla Maza, la schiacciata con farina d'orzo.
Accanto alla nuova cucina sorse la letteratura gastronomica.
Primo in assoluto fu Epicuro Siracusano, segui' Miteco ed Archestrato di
Gela, siamo tra gli inizi del V e del IV secolo a.C. Archestrato di Gela,
nel IV secolo a.C., nei suoi "frammenti della gastronomia",
asserisce di avere visitato ogni terra ed ogni mare ma che in Sicilia ha
trovato il buon gusto.
L'opera parla soprattutto del pesce: la stagione piu' propizia per pescare
le varie specie e il modo di cucinarle.
Il "leitmotiv" e' quello di una cucina naturale, schietta e
genuina senza sofisticherie e che si avvale unicamente di olio, sale ed,
all'occorrenza, di aceto e di erbe aromatiche.
Accanto a questi antichi ricettari, troviamo gli antenati dei moderni
libri "curatevi con le erbe".
Nacque cosi' la dietetica di cui Acrome e Eutidemo furono i precursori.
Ma, per ora, bando alle diete e torniamo ai buoni cibi del periodo
classico.
In Sicilia le mense dei ricchi buongustai erano sontuose e le vivande,
variate e saporite, erano accompagnate da squisiti vini siciliani, ma
anche da birra e da idromele.
Il fatto che il banchetto fosse sentito come occasione principe per
discussioni sui piu' vari argomenti, sta alla base della ricchissima
letteratura detta "Del Convito e del Simposio".
A tale filone si lascia ricondurre anche la bizzarra opera di Ateneo,
erudito greco di Egitto (200 d.C.), i Deipnosofisti, (banchetto dei
sofisti), che di dettagli gastronomici e' una miniera incomparabile.
In questo libro, infatti, vi e' un vero e proprio vademecum sulla cucina:
dalla lepre, al tonno, dai piselli alle anguille, dall'aragosta al pesce
spada, insomma c'e' di tutto.
Ma
torniamo ai nostri amici greci ed alle loro abitudini alimentari.
I pasti dei Greci, in eta' storica, erano tre al giorno: uno leggero al
mattino, I'Ariston, ed altri due piu' consistenti, il Defeion a meta' del
giorno, ed il Dorpon, a fine giornata.
Ogni banchetto iniziava con il rito dell'offerta di ringraziamento agli
dei: il padrone di casa, dopo essersi purificato le mani con acqua,
gettava sul braciere pugni d'orzo, sangue e ciuffi di pelo di un vitello
sacrificato e vi versava del vino.
Terminata questa funzione propiziatoria, i servi ponevano, vicino ad ogni
commensale, un recipiente con il pane ed una coppa per bere il vino
liquoroso allungato con acqua e poi iniziavano a servire le vivande.
Nelle riunioni conviviali non sempre vi era un padrone di casa, perche'
spesso queste erano organizzate da alcuni amici che si riunivano per
mangiare portando ciascuno, in un canestro, cibi gia' cotti ed il vino.

Questi simpatici simposi erano, appunto, denominati "I Pranzi del
Panierino", ed e' questo piccolo recipiente di vimini, la "Spyris",
che a volte, vediamo appeso ad un chiodo in alcune raffigurazioni di cene.
I
menus dei greci erano variati, composti da minestre, da pesce, da carne,
da uova; da legumi, da formaggio fresco e stagionato ed, dulcis in fundo,
dai dolci a base di miele, di noci, di latte e di farina e dalle Focacce
Attiche a forma piramidale.
I dolci venivano serviti assieme a ricchi vassoi di frutta al termine di
ogni pasto o durante il simposio che era la parte piu' importante e gaia
del banchetto, quando il vino scorreva a fiumi ed i convitati, allegri per
le libagioni, cantavano gli Skolia, brevi e briosi versi affini ai
ditirambi.
Socrate criticava gli opsofagi (ingordi) e diede delle regole di galateo
sul modo di comportarsi a tavola, definendo la cucina un'arte.
Le
citta' della Magna Grecia piu' reputate per sontuosita', a volte anche
eccessiva, delle mense furono: Siracusa, Crotone e Sibari ed e' proprio
dai cittadini di questa ultima citta' che e' nato il vocabolo Sibarita,
usato ancora oggi per indicare una persona amante della vita piacevole e
del buon cibo.
Ed adesso parliamo di un'altra importante civilta': gli
Arabi.
Nell'827 i Musulmani d'Africa sbarcano a Marsala, chiamati da un ricco
comandante siciliano, Eutimo o Eufemio, ribellatosi alla corte di
Costantino imperatore.
Anche loro, come i Greci, apportano molte novita' nell'arte, in generale,
e nella cucina, in particolare.
Ci fanno conoscere la canna da zucchero, il riso, il gelsomino, il cotone,
I'anice, il sesamo e le droghe: cannella e zafferano.
Sono abilissimi pasticceri e, tra i dolci, segnaliamo: la Cubbaita (Qubbayt),
ossia, un dolcissimo torrone di miele con semi di sesamo e maridorle; i
Nucatuli, dalla parola araba "Nagal" (frutta secca, confettura,
dolce secco); la Cupita o meglio Copata: torrone molto duro confezionato
in grossi pani, a base di nocciole, albume d'uovo, zucchero miele ed
amido.

Sempre agli arabi dobbiamo la Cassata ed il sorbetto.
Aman ti delle essenze, crearono dolci profumati alla frutta, alla cannella
e, perfino agli odori dei fiori.
Con il gelsomino, per esempio, crearono un niveo gelato, che si confeziona
ancora oggi a Trapani con lo stesso nome arabo: "Scursunera".
Inventarono i geli di melone, di mosto, di cannella, di gelsomino;
crearono storte ed alambicchi per la distillazione della grappa che, in
ossequio al Corano, la usavano solo per disinfettare le ferite, e, quindi,
anche l'alcool.
Ma a questi "invasori" si devono altri gustosi piatti come le
panelle, i ceci essiccati ed i fiori di zucca seccati e salati nonche' il
pane con la milza di cui, ancora oggi, i palermitani sono ghiotti.
Questa e' anche l'era degli Harem.Ci sono molte leggende al riguardo, tra cui quella dell'invenzione del
cannolo.
Si narra che furono proprio le donne di Caltanissetta, ospiti dell'Harem
Kalt El Nissa, ossia, Castello delle donne, ad inventare il famoso dolce
siciliano.
Gli arabi vengono sconfitti dai
Normanni
di Ruggero II di Altavilla nella
battaglia di Cerami nel 1063.Popolazione scandinava di indole marinara e guerriera, oltre alla
costruzione di enormi cattedrali, portano: spiedi rotanti, aringhe
affumicate, merluzzi secchi (Piscistoccu e Baccala') .
Nel 1130 Ruggero II diviene re fino alla morte (1154).La sua fama sara'
superata da Federico II di Svevia.
Questo grande sovrano, oltre all'Universita', alle tasse, ed a varie
innovazioni, compose un trattato sulla caccia con il falco, cacciatore
egli stesso e conoscitore della buona tavola, ebbe al suo servizio,
numerosi cuochi e sembra databile in questo periodo la nascita delle
specialita' di rosticceria.
Ed ecco il turno dei Francesi con Carlo d'Angio' (Angioini 1268).
I Siciliani si ribellano al loro sistema feudale con il Vespro del 30
marzo 1282.
Palermo per non soccombere ai francesi chiama Pietro III d'Aragona ed ecco
gli Spagnoli.
Con la pace di Caltabellotta, 1302, i francesi se ne vanno. In questo periodo si consolida la cucina dei nobili: si afferma il
Falsumagru, che, prima, si chiamava Rollo', dal francese Roulle', che si
imbottisce, nel popolo, con frittate e verdure, mentre, tra i nobili con
carni pregiate.
Nel 1440 Ferdinando di Castiglia diviene re di Aragona e di Castiglia.
L'eta' spagnola arriva fino al 1713.
Grazie a questo popolo conosciamo l'evoluzione della cassata araba dal momento che i nuovi dominatori ne importano un ingrediente base: il Pan di
Spagna; ed ancora, sempre grazie ai nostri amici iberici conosciamo la
zucca all'agro dolce e le varie "mpanate".
Sempre durante questo periodo si ha l'apporto del pomodoro, cacao e mais
dall'America, insieme al peperoncino, alla patata, ai fagioli, al
tacchino, ai peperoni, mentre la melanzana arrivera' dalle Indie.
 Adesso
possiamo renderci conto come una pietanza si completa nel corso dei
secoli, attraverso l'apporto di nuovi elementi.
La Caponata, per esempio, e' l'espressione piu' tipica della legge
gastronomica in base alla quale i piatti partono da una base semplice, a
seconda della disponibilita' degli ingredienti, e si arricchiscono di
sapori supplementari anche grazie alla fantasia di chi cucina.
La Caponata allora, sebbene composta da verdure, e' un piatto marinaresco,
nato nella Caupona, il termine con il quale la bassa latinita' designava
la taverna, dalla quale la pietanza ha derivato il suo nome.
La caupona dei porti preparava le vivande per i marinai che facevano vela
dalle coste dell' isola.
Il dizionario del Palazzi alla voce caponata dice:"cibo marinaresco,
galletta inzuppata nell'acqua salata, condita con olio e aceto".
Quindi non somigliava affatto a quella che conosciamo oggi, e cio' si
spiega benissimo con il fatto che la gamma degli elementi di cui
disponevano gli antichi era piu' povera di quella di oggi, perche' non
ancora conosciuti.
La melanzana, per esempio, arriva dall'India nel 1600, il sedano, sebbene
conosciutissimo fin dall'antichita', (con esso si intrecciavano serti per
i cittadini piu' meritevoli) non veniva utilizzato per la cucina, e cosi'
altri ingredienti.
Ma adesso e' necessario fare un passo indietro ed andare agli Arabi che ci
fecero conoscere il riso.
Il risotto alla milanese, infatti, potrebbe avere avuto i suoi natali in
Sicilia.
C'e' una leggenda in base alla quale il risotto allo zafferano sia stato
creato per caso nel 1574 da uno dei garzoni di maestro Valerio da
Profondavalle, artefice delle vetrate del Duomo di Milano, in occasione
delle nozze della figlia.
Ma
Cristoforo di Messisburgo, maestro di casa del Cardinale Ippolito D'Este,
nel descrivere un banchetto, servito il 16 gennaio 1543 alla corte
Estense, precisa che il secondo servizio di cucina comprendeva, con i
timballi di piccione, di conigli e lepri, in salsa pevorada, anche sei
piatti di riso alla siciliana con tuorli d'uovo crudi, formaggio
grattuggiato, pepe, zafferano e l' immancabile zucchero di tutte le
ricette medievali.
Nel 1500, quindi i ferraresi mangiavano quello che oggi e' il risotto alla
milanese in edizione corroborante.
E, per finire in dolcezza, completiamo il discorso sui cannoli e sulla
cassata siciliana.
Per quanto riguarda i primi c'e' da riferire una citazione di Cicerone:
"Tubus farinarius, dulcissimo, edulio ex lacte factus", ossia,
"cannolo farinaceo fatto di latte per un dolcissimo cibo".
Sembra che l'odierno cannolo siciliano abbia avuto, come dicevamo, origini
arabe, anche se ha subito, nei secoli, diversi rifacimenti, il suo
antenato, infatti, sembra essere stato un dolce a forma di banana ripieno
di mandorle e zucchero.
Per quanto riguarda la cassata, la sua elaborazione definitiva si ebbe nel
periodo barocco con l'utilizzazione del Pan di Spagna, epoca in cui gli
antichi fasti della gastronomia ed anche della pasticceria siciliana,
furono rinverditi dalle consuetudini di vita spagnola e dai nuovi
ingredienti importati alla America.
Per concludere possiamo dire che oggi non si mangia e non si beve piu' per
sopravvivere, ma si cerca di farlo nel modo migliore, perche' una
necessita' fisiologica si trasformi in piacere.
Brillant Savarin, nel suo libro:"La fisiologia del gusto"
scrive:
"Il Creatore, obbligando l'uomo a mangiare per vivere, lo invita con
l'appetito e lo ricompensa con il piacere".
|
I
ROMANI
I Mamertini, mercenari campani, furono al servizio di Agatocle di Siracusa fino
al 289 a.C. quando, alla sua morte conquistarono Messina. I Mamertini chiesero
aiuto a Roma contro nel 264 a.C. Ebbe cosi inizio la prima guerra punica. La
conquista romana non fu indolore: nel 261 la splendida Agrigento, dopo un
sanguinoso assedio, fu espugnata ed i suoi abitanti trucidati o venduti come
schiavi. Anche la potente Siracusa nel 214 a.C. venne assediata dai Romani, dopo
due anni di duro assedio per il tradimento di alcuni nobili fu conquistata e il
popolo ridotto in schiavitù o trucidato. Fu ucciso anche Archimede che con le
sue geniali macchine di guerra aveva tenuto sotto scacco gli invasori. Polibio
scrisse: I Romani non capirono che in alcune circostanze il genio di un uomo
(Archimede) vale di più di molte braccia
La stessa sorte toccò agli abitanti delle città che resistevano all'invasione,
non c'era alternativa: la sottomissione o la morte. L'insaziabile voglia
imperiale romana è particolarmente stigmatizzata nell'Agricola di Publio
Cornelio Tacito (56 d.C.-117 d.C): “Il depredare, il massacrare e il rapinare
con falsi nomi li chiamano imperium, e dove fanno il deserto lo chiamano pax.”
I
funzionari romani solitamente depredavano a man bassa e tra questi tristemente
famoso è rimasto Verre (I sec. a.C.) che, a suo dire, doveva rubare per tre: per
lui, per gli avvocati che dovevano difenderlo e per i magistrati che l'avrebbero
assolto. Ai veterani romani come premio vennero assegnati vasti possedimenti,
dando cosi origine a quella piaga siciliana dei latifondi, che dovevano
scomparire solo negli anni Cinquanta del secolo scorso, sotto la pressione dei
movimenti contadini.
I
Romani si stabilirono in una Sicilia dalle antiche tradizioni culinarie e in
quasi otto secoli di dominazione hanno lasciato anche qualche traccia. Quando
arrivarono in Sicilia rimasero affascinati dalla grandiosità delle città, dalla
qualità della vita sociale dell'aristocrazia siciliana e dalla raffinata
gastronomia.
Cicerone visitando Siracusa rimase abbagliato della bellezza del tempio di Atena
e scrisse: «Porte più splendide e più squisitamente d'oro e d'argento, non sono
mai esistite in alcun tempio».
Per secoli i Romani avevano avuto una vita semplice ed una cucina frugale e per
loro, mangiare era una necessità corporale e non una gioia del palato. Il
commediografo Plauto ricorda alcuni alimenti della Roma frugale: «Una montagna
di cibo, insalata assiepata con altre ed insaporita con coriandolo, finocchio,
aglio e prezzemolo, inoltre acetanella, cavolo, porro e bietola. Si unisce il
tutto a senape pestata, una cosa orribilmente venefica. Tutto questo è più
adatto ai buoi che agli uomini”. Il nome di molti patrizi romani, in ricordo
della vita sobria, deriva dai legumi: Lentuli (lenticchie), Ciceroni (ceci),
Pisani (piselli), Fabi (fave).
In poco tempo, come tutti i parvenus, superarono i popoli conquistati, dandosi
all'eleganza, allo sfarzo e all'ingordigia. Velleio Patercolo nelle Storie
Romane (30 d.C.) scrive: “Il primo Scipione aveva aperto la strada alla potenza
dei Romani, il secondo l'apri alla lussuria: cosi, una volta rimossa la paura di
Cartagine e sottomessa la rivale non degna dell'impero, non gradualmente ma con
corsa precipitosa ci si allontanò dalla virtù e si passò al vizio; l'antico
costume di vita fu abbandonato e ne fu uno la città passò dalla veglia al sonno,
dalle armi ai pia-ceri, dal lavoro all'ozio».
Roma raggiunse nel II secolo d.C. intorno a due milioni di abitanti. Una simile
popolazione poneva enormi problemi per l'approvvigionamento di cibo e di acqua.
Divenuta potenza globale, importava grandi quantità di derrate alimentari dalle
sue province divenendo l'insaziabile "ventre del mondo".
Molti aristocratici romani si stabilirono in Sicilia costruendo lussuose ed
architettonicamente imponenti residen ze decorate con dipinti, marmi e splendidi
mosaici che ancora ammiriamo nella Villa del Casale a Piazza Armerina (EN),
nella Villa del Tellaro a Noto (SR), nella Villa di Patti Marina (MEL nella
Villa di Real Monte (AG) o nella demus rinvenuta durante il restauro del
Monastero dei Benedettini a Catania
A
differenza dei Siciliani che come Greci bevevano vino solo nei simposi, gli
aristocratici romani mangiavano e bevevano tanto. Le pietanze nelle loro tavole
erano ricercate, esotiche e spezie rare arricchivano il banchetto. Talora
titillavano la gola con una penna di pavone, per vomitare e riempirsi di nuovo.
Seneca, nostalgico delle antiche virtù romane, diceva “Vomitano per mangiare,
mangiano per vomitare, non disdegnano nemmeno per digerire”.
Lo sfarzo, l'eleganza, l'abbondanza dei banchetti romani che spesso si
concludevano in orgia ripetono i modelli iconografici che i Romani avevano
ammirato nelle favolose città siciliane e in quelle della Magna Grecia.
Non é azzardato pensare che l'espressione coniata da Orazio per la Grecia valga
per la nostra isola: “Sicilia capta ferum victorem cepit et artes intulit agrest
Latio”.
Sono state le magnifiche città siceliote caratterizzate anche da un habitat
culturale e vivace a svelare ai Romani la Grecia che conquisteranno solo nel 146
2.C
Non sempre i banchetti evolvevano in volgari orge, i padroni di casa colti e
raffinati davano banchetti dove dominava la distinzione e l'eleganza. Un ricco
menú romano è riportato da Quinto Orazio Flacco (65 a.C.-8 d.C.); “Come
antipasto, cinghiale lucano: era stato cacciato al levarsi dello scirocco cosi
diceva il padrone di casa; a far da contorno ravanelli piccanti, lattuga,
radici, cose da stuzzicare lo stomaco svogliato, raperonzoli, salsa di pesce
porpo e feccia del vino di Coo. Sparecchiata questa portata, un valletto in
veste succinta deterse con uno straccio di porpora il piano d'acero della
mensa... mangiavamo uccelli, frutti di mare, pesci che nascondevano un gusto
diverso da quello consueto come quando mi furono serviti filetti di rombo e di
pesce passero di un sapore per me inusitato... viene allora servita, lunga
distesa nel piatto, una murena, guarnita di gamberetti in umido. E subito
l'anfitrione è stata presa gravida, perché una volta deposte le uova, la sua
carne sarebbe peggiorata” (Satire, libro II, 18)
E
difficile stabilire quanto i Siciliani appresero da Roma e quanto i Romani dalla
Sicilia. Dai Siciliani appresero l'utilizzo dei frutti dell'ulivo e della vite
in cucina. I cuochi siciliani, fra tutti Trimalchio da Siracusa, erano ricercati
nella Roma imperiale. I cuochi servivano l'aristocrazia e l'alta borghesia. La
plebe, quando poteva mangiava puls di farro, un fossile vivente che ha dato il
nome alla farina e oggi ritornato di moda, legumi, verdure. pane nero e qualche
volta carne conservata sotto sale.
Dalle puls che i Romani preparavano con farina di farro discendono le varie
polente. La siciliana arriminata o frascatula, che ha sfamato la povera gente,
diventata ora un raffinato contorno molti piatti di carne. Il curioso nome di
patacò viene dato alla polenta di farina di chiecchiru (cicerchia). A Licodia
Eubea ancora oggi si tiene l'affollata sagra della patacò dove tra balli e
musica si mangia patacò calda, fritta, semplice o con verdure ed aromi. A Troina
la cicerchia si chiama rumaneddu e la polenta si chiama piciocia. In alcuni
paesi dei Nebrodi diventa simulata, farinata nel nisseno, panniccia a Enna. È
strano come in Sicilia uno stesso piatto possa avere nomi così diversi e strani
da non capirne il significato e l'origine.
La passione per le murene in brodo, per le alghe, per i frutti di mare, per le
ostriche e le seppioline ripiene è anche romana. Molte alghe marine sono
consumate ancora. Nel catanese e nel siracusano vengono consumate regolarmente
la curaddina (alga corallina) e u mauru (alga del genere fucus) che si possono
trovare nelle bancarelle della pescheria di Catania, condite con sale e limone.
Di origine romana è la cottura sulla brace del fegato avvolto nella calia (o
mento del maiale).
I
sottaaceti vengono preparati dalle massaie siciliane immergendo le verdure in
tre parti di aceto ed una di salamoia; le stesse modalità sono riportate da
Columella nel “De re rustica”.
Il lievito, u criscenti che faceva crescere il pane lievitandolo, fino a pochi
decenni fa in Sicilia veniva preparato e conservato con lo stesso procedimento
che è riportato da Plinio nella “Naturalis Historia”. Sembra che la lievitazione
sia opera degli Ebrei, anche se nelle festività consumavano pane azimo.
Nell'Esodo (12, 39) si legge: “Essi fecero cuocere sotto forma di focacce azime
la pasta che avevano portato dall'Egitto e non avevano potuto indugiare, né
avevano fatto provviste. Gli Egizi producevano un pane bianco lievitato, l'hori,
che veniva consumato dai nobili. Per millenni nel Mediterraneo il pane lievitato
rimarrà appannaggio delle classi dominanti. Il popolo mangiava focacce azime
fatte con un miscuglio di farina di grano, spelta, crusca, legumi, cereali e
verdure che sono rimasti in Sicilia tra le poche possibilità alimentari fino
alla prima metà del secolo scorso.
L'aristocrazia ed il clero siciliani gustavano fave e ceci solo in occasio-ni di
eventi luttuosi. Fave e ceci erano legumi rituali dedicati ai defunti e facevano
parte del piatto dei banchetti funebri. I Romani avevano ereditato queste usanze
dai Greci di Sicilia. Nelle Antesterie si cucinavano fave e ceci che poste sugli
altari venivano offerte al defunti. La Chiesa romana non potendo abolire questi
riti pagani li adattò.
A
Bronte i baccelli di fave, espressione di lutto e mestizia, addobbano i
crocifissi che, preceduti dal suono legnoso della troccula (greco trocès,
crepitacolo), il venerdi di passione sfilano per le vie del paese. Le fave
divennero cibo di precetto nelle veglie per la commemorazione dei defunti. In
Sicilia si mangiavano i “favi a
Cunigghiu” che ad Acireale si chiamavano “favi n'quasuni” e a Bronte “favi
n'grill”. Fave rammollate in acqua e condite con olio, origano, aglio e
peperoncino
I
nostri sformati affondano le radici. nelle torte salate di formaggio e di
verdure che una costante nei banchetti romani.
La 'mpanata con tutte le sue varianti siciliane (scacciata, scaccia, fuazza,
pastizzo, u pistuni missinisi, la comisana mitilugghia, il siracusano scacciuni,
l'in figghiulata di Rosolini) trova le radici nella pasta di pane farcita con
formaggio e cotta al forno. La farcia nella 'mpanata dipende spesso dalla
disponibilità degli ingredienti e dalla fantasia della massaia. “U chinu da 'mpanata”
che Pirandello usa come metafora nel Berretto a sonagli, è sempre una sorpresa.
Le 'mpanate siciliane, dove i sapori e i profumi sono nascosti in una dorata
crosta di pane, sprigionano tutta la loro fragranza quando si affonda il
coltello.
I
Romani preparavano le polpette. Apicio ne propone una ricetta: “Amalgamare la
carne tritata con mollica di pane inbevuta nel vino, pepe, garum, pinoli, fare
polpette e rosolarle nelle caraeunum (mosto cotto ridotto a meta)”. I Siciliani
da sempre riducono in polpette un pò di tutto: carne, pesce, verdura, uova,
formaggio e le 'ngranciano (rosolano) nell'olio.
I
Romani gustavano le ovamele: frittate condite con pepe e miele che ricordano le
omelette.
Il patè (pasticium) di fegato d'oca sembra romano, Plinio il Vecchio racconta
che Apicio immobilizzava le oche inchiodando le membrane interdigitali su una
tavola e le ingozzava di fichi miele e vino così il fegato (allora chiamato
iecur) raggiungeva dimensioni impressionanti. Lo iecur ficatum, ingrossato a
causa dei fichi, raggiungengeva dimensioni tali da essere chiamato solo ficatum;
termine rimasto nelle lingue neolatine (fegato in italiano, foie in francese,
higuado in spagnolo).
Anche il patè di olive nere non è altro che l'epityrum romano. Ancora oggi
gustiamo, con qualche modifica, le olive che Catone riporta nel De Agricultura:
"Togli il nocciolo a olive nere, bianche, screziate. Falle a pezzetti e aggiungi
olio, aceto, cumino, finocchio, menta; mettile in una ciotola di terra cotta.
Devono essere coperte dall'olio. Gustale cosi”.
Il “moretum romano”. Un pesto realizzato a freddo pestando nel mortaio erbe
aromatiche, formaggio, aglio, noci, aceto, sale e amalgamato con olio potrebbe
essere il progenitore dei pesti siciliani: il pesto trapanese che alcuni
vogliono far risalire all'agliata ligure, il pesto catanese, il pesto di
pistacchi brontesi, il pesto di olive. I Romani lo spalmavano su fette di pane.
Ricette del moretum si trovano nel “De re rustica” di Columella e in un poemetto
intitolato Moretum attribuito a Virgilio.
L'uso delle spezie era diffuso nella Roma imperiale. Il pepe è presente in molte
ricette di Apicio. Plinio il Vecchio ne considerava l'uso un segno della follia
popolare. Nella sua Naturalis historia ne riporta i costi elevati che variavano
da 45 denari al chilo per il pepe lungo, e 9 denari per il pepe nero. Ovidio
suggerisce, per risolvere i sessuali, di applicare localmente pepe mescolato a
semi di ortica.
Il sapa romano, mosto evaporato per un terzo, è il nostro vinu cottu, che lo
prepariamo con il mosto di vino come i Plinio disprezzava il popolare sapa che
era stato inventato per falsificare il dolce miele.
I
Romani conoscevano la canna da zucchero (saccaron) ma non sapevano estrarre lo
zucchero. Plinio scriveva: “Una massa simile al miele, raccolta in canne, bianca
come la gomma, fragile tra i denti, della grandezza massima di una mandorla è
impiegata solo come medicamento”.
IL SALE E
IL GARUM
I
Romani migliorarono e potenziarono la tecnica della salatura per conservare le
carni ed i pesci che dovevano esportare nelle varie regioni dell'Impero. In
Sicilia la produzione di sale era abbondante. Erano stati i romani a
perfezionare nel trapanese l'estrazione del sale dal mare con tecniche ancora
oggi in uso. Lo storico Tommaso Porcacchi. (1530- 1585) scrive: “Il quale (sale)
nasceva ancho da se stesso dalla schiuma dell'acqua marina che resta negli
scogli e negli estremi liti, presso l'idedeo Drepano".
I
Romani utilizzavano il sale non solo per conservare le vivande ma anche a fini
alimentari. Davano ai soldati una parte della paga sotto forma di sacchetti di
sale (da dove salario). Con Federico II il sale diventerà monopolio di stato.
Le terribili salse che i Romani avevano imparato dagli etruschi, come il garum
che spalmavano e servivano durante i banchetti che Plinio definiva marciume di
"cose putrefatte", non hanno contaminato la cucina siciliana. Il garum non
soddisfava i gusti di molti Romani. Seneca scrive a Lucillo: «Quel garum
preziosa poltiglia di pesci guasti, non credi che ti bruci le budella col suo
piccante marciume?”
Col garum i Romani condivano tutto e fungeva anche da sostituto del sale.
Il garum entrò nella farmacopea dell'antica Roma. Plinio (Libro XXX, 96) scrive
che col garum si guariscono ustioni recenti... è utile contro i morsi del cane e
sopratutto del coccodrillo e per le ferite che si diffondono e si infettano.
I
Siciliani, i Campani e gli Spagnoli lo producevano per farlo gustare ai Romani.
Pregiato era il garum di Cartagena (Spagna) confezionato in ampolle da due litri
e dal costo proibitivo di mille sesterzi (circa 1.000 €). Il giudizio di Plinio
il Vecchio nella Naturalis Historiae (77 d.C.) sul garum, se si pensa alla sua
composizione, è stato benevolo: «Si salino in un recipiente le interiora di
pesci e vi si aggiungano pesci di piccola taglia come sardine, triglie, menole e
bavose, che vanno anch'essi salati; poi si facciano ritirare al sole, mescolando
sovente. Quando sono ben marciti, si passi tutto al setaccio. La massa che
rimane nel setaccio si chiama alec; il liquido che passa è il liquamen. Anche
gli Islamici hanno una salsa simile al garum: il murri di pesce.
In Campania si prepara ancora un condimento dal profumo e dal sapo-re intenso:
la colatura di alici. Questa antica salsa è la versione raffinata del garum
romano. Ho avuto modo qualche anno fa di assaporarla in un ristorante di Cetara
(Salerno). Anche la sardella calabrese ricorda il garum romano.
Recentemente una azienda siciliana ha riscoperto, dopo secoli di oblio, la
ricetta del garum romano. Viene preparato con frattaglie di tonno macerate con
sale, timo, finocchietto selvatico, menta e rosmarino posto in contenitori di
vetro.
Fonte: SPIGOLATURE STORICHE
SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 -
©
tutti i diritti riservati - esclusiva
concessione del Prof. Schilirò per il sito web mimmorapisarda.it

|
È
certo che un record dell'arte culinaria di questa terra è quello delle
svariatissime influenze che sulla gastronomia siciliana vennero
sovrapponendosi via via: Greci, Romani, Arabi, Normanni, Angioini,
Aragonesi, Spagnoli, Inglesi... popoli provenienti dalle più lontane
contrade convennero nell'isola del sole e dei limoni portando, insieme a
brame di possesso e a progetti di conquista, usanze e ingredienti che si
innestarono, fondendovisi senza difficoltà, sulle tradizioni locali.
Cucina
tipicamente mediterranea, i suoi temi fondamentali sono olio, pasta,
pesce, frutta, ortaggi, erbe aromatiche; ma a questa base colorata e
fragrante, e che è identica a tutte le cucine meridionali italiane, si
aggiungono echi, sapori, profumi nuovi, di varia provenienza, spesso
inediti per il palato continentale, che derivano appunto dalla storia.
La
gamma dei piatti e delle creazioni è straordinariamente ricca ed è
particolarmente evidente nelle famiglie, sia in quelle modeste sia in
quelle aristocratiche.
Se
si ripercorrono il difficile passato della Sicilia e i vari periodi
delle dominazioni che l'isola subì, si ritrovano - una per una - le
tessere di quel mosaico policromo e ghiottosissimo che è il suo attuale
patrimonio gastronomico.
Della
Magna Grecia restano intatti i sapori
delle olive, della ricotta salata, del miele dei fiori, del pesce,
dell'omerico agnello alla brace e soprattutto del vino.


Al
periodo
romano risalgono invece piatti come le seppie ripiene, le cipolle al
forno, il "maccu", purea di fave cotte in acqua insaporita con
erbe aromatiche, che si condisce con olio crudo e si mangia con pane o
pasta. È un piatto semplice, che oggi si trova quasi soltanto
nell'interno dell'isola: per secoli è stato il cibo più frequente del
contadino e dello zolfataro, che se lo portavano, dentro la "quartara"
o anfora di terracotta, nei campi e in miniera.
Alla
dominazione araba riportano invece piatti di netto stampo orientale,
come il "cuscusu" (la forma più elementare e primitiva di
pasta alimentare che si conosca, minutissime palline di farina di semola
e acqua che vengono lasciate ad asciugare al sole e conservate) con cui
si realizza la famosa zuppa di pesce del Trapanese; la
"cassata", che certamente è il dolce più classico della
fantasmagoria dolciaria isolana; la "cubbaita", torrone al
miele con semi di sesamo e mandorle, e il gelido nettare che gli Arabi chiamavano "sciarbàt" e che univa alla neve prelevata
dall'Etna le essenze profumate di agrumi, frutti e fiori: da qui venne
il "sorbetto" che i gelatai siciliani portarono a fama
mondiale. Fu, quello arabo, il periodo in cui la Sicilia assunse ancor
più l'aspetto di isola felice, profumata e lussureggiante come un
giardino. Nuove colture (riso, agrumi, canna da zucchero, anice, ecc.),
nuove importazioni (spezie e droghe), nuovi impianti (le tonnare, per
esempio): nel generale fervore anche la tavola divenne più sofisticata
ed elaborata.
Al
periodo del dominio angioino e aragonese risale il popolare
"farsumagru",
che prima si chiamò "rollò", dal francese "roulé",
e che è l'indiscusso sovrano dei piatti siciliani a base di carne: un
ricco arrotolato di vitello che racchiude una farcia piena di ogni
bendiddio.
Echi di usanze
francesi si trovano in piatti popolari che ne
scimmiottano il nome con una certa ironia, come la "pasta cacata",
condita con ricotta fresca e un densissimo ragù, alla quale in qualche
modo si contrappone la semplicissima pasta e ricotta che dimostra come
la cucina siciliana riesce, grazie alla straordinaria qualità delle
materie prime, a creare nel modo più semplice una preparazione
magnifica. La ricetta arriva dalla tradizione popolare, sempre basata su
accostamenti elementari, e ricorda in qualche modo quella laziale dei
bucatini "cacio e pepe". In questo caso la pasta è del tipo
corto, formato ditalini o conchigliette. La ricotta deve essere
freschissima e va diluita in una tazza con un poco di acqua di cottura
della pasta. Alla fine si condisce tutto insieme e si completa con una
spolverata di pecorino grattugiato. Di origine francese è anche
l'"ancidda brudacchiata", che è la traduzione di
"anguilla in brouet", cucinata con pepe, zenzero, cannella,
chiodi di garofano e zafferano sciolto nel vino.

Si
giunge così al lungo periodo della dominazione spagnola in
Sicilia;
l'epoca dei Viceré. Al seguito dei Conquistadores spagnoli di ritorno
dall'America, si diffuse in Europa il pomodoro che, nel Sud d'Italia e
quindi anche in Sicilia, ebbe enorme fortuna trovando terreno ideale.
Pochi anni dopo fu la volta di un'altra protagonista della cucina
meridionale, la melanzana, anch'essa di origine sudamericana. Si
crearono con questi ortaggi piatti come la "caponata" di
verdure, tuttora uno dei più caratteristici e diffusi dell'isola. In
questo stesso periodo nacque il Pan di Spagna, base di molti dolci, e si
diffuse il cioccolato.
Il
capitolo più celebre della cucina siciliana è quello baronale. Nelle
sontuose dimore dei gattopardi dei secoli XVIII e XIX la tavola
raggiunse opulenza e fasto straordinari.
Il
popolo non aveva di che sfamarsi, ma i baroni e gli alti prelati si
contendevano i più abili "monsù", cioè i maestri della
cucina (dal francese "monsieur") che prendevano al loro
servizio per avere sempre una tavola ricca di invenzioni spettacolari.
È
rimasta celebre la descrizione che fece l'inglese Patrick Brydone di un
pranzo offerto nel giugno del 1770 dalla nobiltà di Agrigento al
proprio vescovo. "A tavola eravamo esattamente in trenta, ma sulla
mia parola non credo che i piatti siano stati meno di un centinaio.
Erano tutti guarniti con le salse più succulente e delicate... Non
mancava nulla di ciò che può stimolare e stuzzicare il
palato...". Tra le portate, quelle che più colpirono il
viaggiatore inglese furono le murene e il fegato di polli fatto
ingrossare a dismisura. A un certo punto del banchetto ci fu un
interessante scambio eno-gastronomico perché gli invitati britannici
furono pregati di preparare un ponce, bevanda di cui in Sicilia si era
sentito parlare ma che non si era ancora assaggiata. L'accoglienza fu
entusiasta, ma l'incredibile pranzo aveva in serbo altre sorprese. Al
momento dei dessert, continua il cronista anglosassone, "uno dei
camerieri offrì al capitano il simulacro di una bella pesca e questi,
impreparato a qualsiasi inganno, non dubitò affatto che si trattasse di
un frutto vero. Tagliatala in due, se ne cacciò subito in bocca una
grossa metà... ma tosto il freddo violento ebbe la meglio ed egli
cominciò a rotolare la pesca da una parte all'altra della bocca, con
gli occhi che gli lacrimavano; finché, non potendone più, la sputò
nel piatto imprecando: "Una palla di neve dipinta, perdio!"".

La
gustosa descrizione di Brydone offre la testimonianza storica di un'arte
- quella dolciaria, in particolare quella dei gelati - che non è andata
perduta. Basta entrare nelle più importanti gelaterie di Palermo, di
Catania, di Messina per capire come il gelato sia una tradizione
secolare. Nella rutilante esposizione di "spumoni", "spongati",
granite, "geli", "pezzi duri", sorbetti, si
incontrano tutti i gusti possibili e immaginabili: fra gli altri, il
gelato di fico d'India, il frutto-simbolo della Sicilia, e quello di
gelsomino o "scursunera", in cui si vorrebbe affondare la
lingua ma anche il naso, irresistibilmente. Straordinario è anche il
"gelu di meluni": è un gelato di cocomero in cui, nella pasta
spumosa e vermiglia dell'anguria occhieggiano pezzetti di cioccolato
amaro che imitano perfettamente i semi del frutto.
L'arte
della rappresentazione, la ricerca puntuale della verosimiglianza, la
perfetta abilità nell'imitazione sono caratteristiche tipicamente
siciliane e hanno la massima espressione nei celebri frutti di
"pasta reale" o "della Martorana", dal nome del
convento palermitano che anticamente aveva il monopolio di questa
preparazione. Questi dolci prelibati sono a base di pasta di mandorle la
cui consistenza morbida, plasmabile come creta, permette di modellare
qualsiasi forma: vengono di preferenza riprodotti frutti che,
opportunamente colorati, sono una vera e propria sfida alla natura e
compongono bellissime "nature morte". Altri soggetti
tradizionali sono agnelli pasquali, pesci e in genere simboli religiosi.
|

|
Peccati
di gola grazie agli arabi
La pasticceria siciliana presenta molte affinità con i gusti
esotici importati dall'Oriente: pistacchio, cannella e zucchero
Tre
sono le fonti a cui si rifà la cucina siciliana in fatto di dolci:
la prima è l'ambiente contadino, dove spettava alle donne
nell'approssimarsi di ogni festa religiosa e familiare, preparare i
dolci previsti per tali ricorrenze. Così, per la nascita del
primogenito maschio, considerato nel mondo contadino una vera e
propria provvidenza divina, si usava regalare una treccia di zucca
candita legata con un nastro rosso, ch'è un chiaro segno contro il
malocchio. La seconda fonte è legata ai monasteri, dove le monache
di clausura preparavano, inventandoli di volta in volta, dolci
ricchi e fantasiosi, che si tramandano fino ad oggi, esclusivamente
entro le mura dei conventi.
 La terza fonte è, infine, quella di
più recente acquisizione, e riguarda la raffinata pasticceria
importata in Sicilia da valenti pasticceri svizzeri, che dall'inizio
del secolo scorso si trasferirono nell'isola. Infatti i dolci
siciliani più conosciuti sono proprio quelli appartenenti alla
pasticceria svizzero-siciliana, che si trova in tutte le principali
città d'Italia. Fra le molte dominazioni che si sono
succedute nell'isola è sicuramente quella araba che ha impresso di
più la propria impronta, perché ha introdotto alcuni elementi,
quali il pistacchio, la cannella e lo zucchero, di cui si fa largo
uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Ma è attraverso la
creatività che la pasticceria siciliana tradizionale si rivela
ricca e variata, anche quando impiega ingredienti semplici e poveri:
la ciaurrina, un antico dolce tradizionale, ha come unico
ingrediente il miele. La terza fonte è, infine, quella di
più recente acquisizione, e riguarda la raffinata pasticceria
importata in Sicilia da valenti pasticceri svizzeri, che dall'inizio
del secolo scorso si trasferirono nell'isola. Infatti i dolci
siciliani più conosciuti sono proprio quelli appartenenti alla
pasticceria svizzero-siciliana, che si trova in tutte le principali
città d'Italia. Fra le molte dominazioni che si sono
succedute nell'isola è sicuramente quella araba che ha impresso di
più la propria impronta, perché ha introdotto alcuni elementi,
quali il pistacchio, la cannella e lo zucchero, di cui si fa largo
uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Ma è attraverso la
creatività che la pasticceria siciliana tradizionale si rivela
ricca e variata, anche quando impiega ingredienti semplici e poveri:
la ciaurrina, un antico dolce tradizionale, ha come unico
ingrediente il miele.
Ogni provincia della Sicilia conserva una propria tradizione in
fatto di dolci, così come per ogni festa popolare, religiosa e
familiare. La Pasqua e la commemorazione dei defunti sono le
festività più celebrate nell'isola. La settimana santa, tanto
sentita in tutta la Sicilia, diventa anche l'occasione per preparare
una varietà di dolci e pani rituali, legati al significato
religioso della Pasqua, elaborati con gli stessi usi che fanno parte
della tradizione agropastorale, presente non solo nella storia della
Sicilia, ma in quella dei popoli mediterranei. I pani rituali,
preparati a base di farina, uova, zucchero, pasta reale e ricotta,
sono vere e proprie specialità a cui vengono date forme diverse in
base ai riferimenti simbolici religiosi.
Oggi è usuale vedere in bella mostra, nelle vetrine delle
pasticcerie, vassoi con la frutta martorana, modellata da abili
pasticceri. Mentre tanti dolci sono diffusi in ogni parte
dell'isola, altri restano circoscritti a livello locale: la
pignolata a Messina, le crespelle a Catania, il
riso mantecato ad Enna, le arancine dolci ripiene di cioccolato e il
gelo di mellone a Palermo, le schiumette a Siracusa e le
impanatiglie a Ragusa. Alcuni dolci vengono preparati esclusivamente
in alcuni periodi dell'anno o per determinate festività patronali.
Simbolo gastronomico per eccellenza della Sicilia è la cassata,
tradizionale un tempo solo nel periodo di Pasqua, è oggi reperibile
tutto l'anno. Il nome deriva dall'arabo "qasat" che
significa scodella rotonda. È un dolce trionfale, un involucro di
pan di Spagna ripieno con una crema di ricotta freschissima
insaporita alla vaniglia e a un liquore dolce o rum, arricchita con
pezzetti di cioccolato, dadini di frutta candita, ricoperta con una
glassa verde al pistacchio e decorata con altra frutta candita,
scorzette d'arancia e altro.
Un altro esempio della rinomata dolceria siciliana legata alla
pasqua sono i quaresimali, croccanti biscotti fatti con le mandorle,
che nascono come pietanze votive legate alla Quaresima.
Dulcis in fundo, non sono da trascurare i gelati, che si mangiano in
ogni stagione, e quelli siciliani, sono indiscutibilmente i
sorbettieri più rinomati del mondo. I "gelatai" sono
capaci di inventare migliaia di gusti servendosi di tutti i tipi di
frutta fresca, secca o anche fiori, come il gelato di scurzunera
(gelsomino) che é in assoluto il più caratteristico.
Posto di rilievo, infine, si deve dare ai sorbetti (gelati senza
aggiunta di latte) ed alle granite, al limone, al caffè ed alle
mandorle, gradita pausa rinfrescante soprattutto nelle giornate
estive.
In Sicilia non c'è stagione che non abbia i suoi dolci
caratteristici. Nei sapori di un pasticcino, di una torta o di un
gelato, è possibile scoprire le millenarie stratificazioni lasciate
da tutti i popoli che hanno attraversato l'isola.
Le tradizioni gastronomiche di un luogo, infatti, come sempre
accade, dipendono dalla storia, dal clima ed anche dalla religione.
E così in Sicilia, in particolare a Palermo, da sempre sede dei
governanti stranieri, la necessità da parte dei cuochi di
trasformare cibi poveri, essenziali e genuini in pietanze che
mostrassero all'occhio critico dei regnanti, sfarzo e ricchezza ha
portato ad una varietà di sapori
e di decorazioni, che si riscontra soprattutto nei dolci.
Gli aspetti più evidenti della pasticceria siciliana sono
soprattutto due: le profonde radici arabe e il successivo sviluppo
nelle cucine conventuali.
È soprattutto durante le ricorrenze più importanti come il Natale,
il Carnevale e la Pasqua che la gastronomia siciliana dà davvero il
massimo, grazie ad alcuni piatti che oramai rientrano a pieno titolo
nella tradizione culinaria.
Simbolo gastronomico della Sicilia è la cassata, tradizionale un
tempo solo nel periodo di Pasqua, è reperibile tutto l'anno. Il
nome deriva dall'arabo "qasat" che significa scodella
rotonda. È un dolce trionfale, un involucro di pan di Spagna
ripieno con una crema di ricotta insaporita alla vaniglia e a un
liquore dolce o rum, arricchita con pezzetti di cioccolato, frutta
candita, ricoperta con una glassa verde al pistacchio e decorata con
altra frutta candita e scorzette d'aranci.
In occasione del Natale la cassata è uno dei dolci tipici,
richiesto in tutte le pasticcerie dell'isola, ma anche in numerose
località italiane. Insieme alla cassata è il buccellato. Dolce
ripieno di fichi secchi (o marmellata di fico), cioccolato, noci,
mandorle, uva passa, di origine antica, prende il nome dal tardo
latino buccellatum, cioè pane da trasformare in buccelli, ossia
bocconi, per la sua morbidezza.
Tipico dolce delle feste di Natale e delle cene di San Giuseppe è,
inoltre, la cubbaita, croccante dolce, fatto di semi di sesamo e
mandorle, cotti nel miele ibleo. Ed ancora i torroni, tipici
dell'interno dell'isola, che si presentano con il miele, con il
cioccolato oppure con mandorle e pistacchi. "Corona del pranzo
carnevalesco", a detta del Pitrè, il maggiore studioso del
folklore siciliano, il cannolo è una cialda farcita con ricotta
zuccherata ed aromatizzata, guarnita con canditi d'arancia,
cioccolato e zucchero a velo.
 |

|
"Norma" a Catania non solo significa
"Musica", ma anche il "non plus ultra" di ogni cosa: infatti
l’omaggio al Cigno catanese, autore di Norma, è stato ed è sempre senza
riserve. Ma anche se dovessimo scrivere "norma" con la enne minuscola,
avremmo sentenziato: pasta secondo l’alta tradizione degli antichi buongustai
catanesi. "Pari
‘na Norma", sembra una Norma, era ed è il paragone corrente per l’iperbolica
mania di cui sono sempre stati affetti gli abitanti della città.
 Da
quando questo paragone è stato dedicato alla popolare pasta? Nel 1920 in casa
Musco-Pandolfini in via Etnea, si svolse un pranzo che adesso ci appare in tutta
la sua storica prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era
ancora celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe
Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e
Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento.
Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui Da
quando questo paragone è stato dedicato alla popolare pasta? Nel 1920 in casa
Musco-Pandolfini in via Etnea, si svolse un pranzo che adesso ci appare in tutta
la sua storica prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era
ancora celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe
Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e
Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento.
Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui appartamento troviamo
riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Janu Pandolfini e i noti commediografi e
giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Quando Donna Saridda
portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la salsa di pomodoro, basilico,
melanzane fritte e ricotta salata grattugiata, dopo le prime religiose
forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che era, Nino Martoglio volle
complimentarsi con l’autrice con queste precise parole: "Signora Saridda,
chista è ‘na vera Norma!". Naturalmente, stante la presenza di tanti e
così autorevoli "gazzettini", la frase immediatamente si riseppe in
tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E dunque Nino
Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci commedie del
teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore di aver
ufficialmente battezzato "alla Norma" la popolare pasta catanese,
anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice
espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un diretto
ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini
appartamento troviamo
riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Janu Pandolfini e i noti commediografi e
giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Quando Donna Saridda
portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la salsa di pomodoro, basilico,
melanzane fritte e ricotta salata grattugiata, dopo le prime religiose
forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che era, Nino Martoglio volle
complimentarsi con l’autrice con queste precise parole: "Signora Saridda,
chista è ‘na vera Norma!". Naturalmente, stante la presenza di tanti e
così autorevoli "gazzettini", la frase immediatamente si riseppe in
tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E dunque Nino
Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci commedie del
teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore di aver
ufficialmente battezzato "alla Norma" la popolare pasta catanese,
anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice
espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un diretto
ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini
 |
|
Vuoi
sapere proprio tutto? Clicca
qui |

|

|

|
L'Azienda
In una citta' golosa e raffinata come Catania, la
Pasticceria Savia incarna i fasti della dolcezza, tra cannoli invitanti e
cassate variopinte, tra paste di mandorla e l'esplosione di colori del
marzapane.
Come consuetudine cittadina,da piu' di Un Secolo, dal
caffe' all'aperitivo,dall'arancina al pasticcino, a seconda dell'ora e degli
impegni, la Pasticceria Savia e' la meta preferita da giovani e meno giovani
impiegati e manager ranpanti nella pausa pranzo.
Fu fondata nel 1897 dai coniugi Angelo ed Elisabetta
Savia in quella zona anticamente chiamata Piano di Nicosia. Da li' mosse i
primi passi e accrebbe la sua esperienza grazie all'intuito e alla sagacia
di Alfio e Carmelina Savia trovo' degna sistemazione nel cuore della citta';
Per i pochi che non lo sapessero la Pasticceria Savia si
trova incastonata ad angolo tra la via Etnea e la Via Umberto, in quello che
Federico de Roberto battezzo' col nome prestigioso di Salotto di Catania.
In quell'illustre angolo matura, grazie ad Angelo Savia,
la tradizione dolciaria che trova i suoi punti di forza nell'eccelsa qualità
delle materie prime, nella magistrale professionalita' e cortesia del suo
personale e nel confezionamento dei prodotti sempre freschi e fragranti.
Forte di questi capisaldi la Pasticceria Savia ha
iniziato un nuovo capitolo della sua storia Da oggi insieme ai nipoti
Alessandro e Claudio, si presenta alla clientela in una veste completamente
rinnovata, conservando sempre la qualita' e le tradizioni di un tempo.
(savia.it)
|




Zio Angelo Savia

Una guerra antica, tutta catanese. Ma Savia è
l'arancino per antonomasia.
Clicca qui sotto per conoscere
tutto sull'arancino e la guerra con l'arancina
palermitana


L'
Azienda fu fondata negli anni trenta dal maestro pasticciere Gaetano
Spinella,
che volle allocarla nel "salotto buono" di Catania in via
Etnea, 300 di fronte al giardino Bellini. La
maestria del fondatore, rispettoso dei canoni della migliore
tradizione dolciaria siciliana, ne determinò un immediato successo.
Dal
1996 la società "Pasticcerie Siciliane Riunite" ha rilevato
l'Azienda, introducendo nella gestione moderni criteri manageriali che
si sono integrati ai sapienti insegnamenti del fondatore.



Gaetano
Mantegna aveva appena 10 anni quando inizia l'attività di apprendista
pasticcere. Nel 1946 decide di realizzare il sogno di una vita: aprire una
pasticceria tutta sua al centro di Catania.
La passione del fondatore, da subito, è rivolta verso le due specialità che
presto diventano i must della pasticceria: la gelateria, la pasticceria e le
"sculture" di martorana che, per bontà, bellezza e perfezione delle
fogge, diventano sempre più richieste e apprezzate in Sicilia e all'estero.
In
occasione dell'inaugurazione, Gaetano Mantegna realizza una delle sue celebri
sculture: un bellissimo pesce spada di martorana di 5 kg completamente
modellato a mano. L'opera ha avuto un successo tale da essere acquistata da un
ufficiale americano per poi donarla ad una baronessa inglese.

Già nel 1950 Mantegna vince il suo primo concorso per la realizzazione di una
vetrina straordinaria; i premi continuano fino alla medaglia d'oro del "Fipper"
e dell' "Aquila d'oro" della Confcommercio. In seguito, grazie
all'intraprendenza di Gaetano Mantegna, inizia in Sicilia la produzione
industriale del classico panettone milanese e dei gelati artigianali.
Una lunga storia fatta di passione e fantasia che ha continuato, negli anni,
ad entusiasmare generazioni di golosi.
Da
sempre situata in Via Etnea a Catania, in pieno centro storico, la pasticceria
Mantegna ha subìto negli anni importanti trasformazioni.
Oggi, infatti, Casa Mantegna non è solo sinonimo di qualità e bontà dei
prodotti che, oggi come ieri, continuano a vivere grazie alle antiche ricette
del nonno Gaetano; al fattore dolcezza, si è aggiunto anche l'eleganza degli
ambienti della nuova sala: "living room cafè". Un luogo di ritrovo
in cui la varietà dei sapori si coniuga con il servizio impeccabile di un
personale specializzato nel presentare the, cioccolate, cocktails e gustosi
aperitivi.


A
Belpasso, suo paese natale, il cavaliere del lavoro Francesco Condorelli
rappresentava una istituzione, cosi come la sua industria dolciaria, che proprio
lo scorso anno ha festeggiato trenta anni di attività e di successi, derivati,
in rnassima parte, dai torroncini commercializzati in tutto il mondo.
La
notizia della scomparsa di Condorelli, ha offerto l'occasione per scoprire un
personaggio che con i suoi 91 anni di esistenza pienamente vissuta, ha
contrassegnato una pagina positiva dell'imprenditorialità siciliana sin da
quando, ventunenne, nel 1933, divenne proprietario della pasticceria di Borrello.
Spirito
irrequieto e curioso, Condorelli conobbe anche l'esperienza dell'emigrazione.
Per un breve periodo della sua vita, su sollecitazione di un conoscente, decise
di trasferirsi in Istria e nel 1939 giunse a Pola. L’avventura istriana fu
breve, cosi come quella che lo portò, dopo la guerra, a Malta. Tornato
definitivamente in Sicilia, nonostante fosse provato dai combattirnenti e dalla
prigionia patita, mostrò tutta la sua tempra e si fece protagonista della
locale vita imprenditoriale. La sua pasticceria cominciò ad essere frequentata
dalle numerose comitive di gitanti che passavano da Belpasso, per salire a fare
escursioni sull'Etna. Con le sue granite Condorelli fece ancora più dolci gli
anni della- dolcevita- come rivelano le foto che lo ritraggono, sempre
elegantissimo e sorridente, accanto ai personaggi famosi dell'epoca, spesso
appartenenti al mondo dello spettacolo. Aneddoti, racconti, episodi e ricordi
biografici furono raccolti dal Condorelli in un volume di ricordi, "La mia
vita", pubblicato recentemente da Maimone. Nelle pagine autobiografiche,
con la memoria prodigiosa che lo contraddistingueva, il cavaliere ci permette di
entrare nel suo mondo più intime, in quello dei suoi affetti, ma anche nella
vita sociale ed economica della provincia etnea. Significativi, per i dettagli e
gli spunti di riflessione, le pagine che egli dedica agli anni del boom
economico, quando la vita della zona etnea, pur tra gli alti e bassi dovuti alle
difficoltà del la ripesa post bellica, fece di Catania la Milano del Sud.
A
questo processo di sviluppo contribuii anche l'attività imprenditoriale di
Condorelli. Ma il vero salto di qualità egli lo fece negli anni Settanta,
quando inventò un prodotto - il torrone morbido monodose con glassa - che ha
conquistato il mercato mondiale per la stia bontà e per merito di una abile
campagna pubblicitaria, affidata a personaggi siciliani che hanno avuto successo
nel mondo dello spettacolo. I messaggi promozionali e innovativi - celebre gli
spot con i Re Magi - identificano immediatamente ed efficacemente i "Torroncini
CondorelIi". Ma forse non tutti sanno che l'ìdea del morbido monodose
maturò in seguito ad una cena in casa di una vedova a Venaria Reale in
provincia di Torino. Quella sera il dolce era proprio una stecca di torrone che
venne rotto con un grosso coltello in parti disegnali. A Condorelli, che era
l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e questo non gli sembrò giusto, per non
parlare dei problemi di masticazione che, a causa della durezza, creava
soprattutto alle persone anziane Gli balenò l'idea di un torrone morbido, dal
gusto delicato, incartato in porzioni singole. E da qui anche il salto di
qualità perché il marchio Condorelli divenne presto sinonimo di torroncino.
Oggi nell'industria dolciaria Condorelli si trasformano ogni giorno settemila
chili di mandorle per confezionare 15 mila chili di torrone morbido ricoperto in
sette glasse diverse, L'industria dà lavoro a 54 dipendenti fissi, a 66
stagionali e a 96 agenti, che coprono tutto il territorio nazionale. Sono cifre
imponenti e - siamo certi - destinate ad accrescersi con la istituzione della
Fondazione, nata per ricordare uno dei più importanti imprenditori siciliani
nel settore dolciario.
Il torroncino che esporta
l'immagine della Sicilia in trenta Paesi del mondo
La Sicilia, 5 Aprile 2014 - Ombretta Grasso

Catania. È cresciuto tra il profumo del miele e l'aroma
delle mandorle tostate. Da bambino, racconta, passava i pomeriggi facendo la
glassatura di cioccolato e incartando a mano, a uno a uno, quei pezzetti di
torrone che sono diventati il marchio di una dolce storia di successo.
Giuseppe Condorelli, 47 anni, guida da più di 10 anni l'azienda di famiglia
che da Belpasso con il suo torroncino ha conquistato clienti in tutto il
mondo, compresa una principessa degli Emirati Arabi, ed è arrivato sugli
scaffali di 30 Paesi: negli Usa e in Germania, in Belgio «e pure in
Svizzera», sottolinea con l'orgoglio di vedere le sue tavolette nella patria
della cioccolata.
«L'idea a cena da amici»
Un'azienda con 49 dipendenti e 60 stagionali che lavorano
da settembre a dicembre a quelle prelibatezze nate da un pizzico di genio:
una sera a cena da amici a Venaria Reale, in provincia di Torino, gli viene
offerta una stecca di torrone spezzata con un grosso coltello in parti
diseguali. A Condorelli, che era l'ospite, fu dato il pezzo più grosso e
questo non gli sembrò giusto. Così, invece della tradizionale stecca di
torrone, pensò a torroncini monodose da distribuire in pezzi uguali, e a
quella nuova morbidezza che consente di gustarli con più facilità.
Un modo di unire la tradizione con l'innovazione. Scelta
mai tradita. Si intitola, infatti, "I dolci tra modernità e tradizione" la
giornata che per il quinto anno ha organizzato con la Fondazione dedicata al
padre, il cavaliere Francesco Condorelli - questa mattina alle 10 al Museo
diocesano di Catania - una tavola rotonda in cui si confronteranno
economisti e sociologi, operatori del settore e imprenditori. «La
pasticceria siciliana esprime ancora prodotti fortemente legati alla
tradizione - spiega Condorelli - e anche con l'avanzare della tecnologia
continuano a essere realizzati con modalità e ingredienti tipici. Dietro i
dolci siciliani c'è tutto un mondo di ricordi, di profumi, di tradizioni
antiche. Basti pensare al legame fortissimo che c'è con il territorio e con
le feste religiose, dalle olivette di Sant'Agata alle sfince di San
Giuseppe. Dolci che hanno storia e cultura da valorizzare. Mi sembra
importante confrontarsi su come salvaguardare questo patrimonio creando un
sistema che valorizzi l'eccellenza all'interno di uno sviluppo economico e
sociale».
Nel pomeriggio il momento più goloso con il concorso e la
degustazione delle "opere" presentate dai maestri pasticceri e dagli
apprendisti di tutta la Sicilia, da Trapani e dall'Alberghiero di
Caltanissetta, da Catania, Scicli e Messina. «Gli iscritti sono 35 e
dovevano cimentarsi con la presentazione di un dolce pasquale al
cioccolato», spiega. «La dolceria è una forma d'arte, non basta preparare un
buon dolce, bisogna anche saperlo presentare, dargli un aspetto che incanti
l'occhio e solleciti il gusto». Premi in denaro per
 i
primi tre di ciascuna delle due categorie, pasticcieri (1.500 euro per il
primo classificato) e apprendisti pasticceri (1.000 euro), ma soprattutto il
valore simbolico di essere valutati da sette maestri. «Tra le finalità della
fondazione c'è quella di tenere unito il gruppo di pasticceri siciliani.
Questa è un'opportunità di offrire una vetrina alla loro abilità, ai nomi
già affermati ma anche ai giovani talenti». i
primi tre di ciascuna delle due categorie, pasticcieri (1.500 euro per il
primo classificato) e apprendisti pasticceri (1.000 euro), ma soprattutto il
valore simbolico di essere valutati da sette maestri. «Tra le finalità della
fondazione c'è quella di tenere unito il gruppo di pasticceri siciliani.
Questa è un'opportunità di offrire una vetrina alla loro abilità, ai nomi
già affermati ma anche ai giovani talenti».
«Grazie a Baudo»
La pasticceria artigianale Condorelli è nata nel ‘33 a
Belpasso, grazie all'intraprendenza del cavaliere Francesco, che aveva
cominciato a lavorare come garzone di dolceria. Negli anni 60, con
l'intuizione di reinventare il torrone, si trasforma in una piccola
industria. Il vero salto nell'83 grazie a un siciliano eccellente. «Pippo
Baudo ci chiese di fare da sponsor a Domenica in. Un'operazione audace ma
che ci fece conoscere in tutta Italia. Era la svolta». L'altro siciliano che
con la sua simpatia irresistibile ha dato volto al torroncino, consacrandone
la celebrità, è Leo Gullotta, «per 25 anni il nostro testimonial
straordinario». dallo scorso anno lo spot è affidato a Francesco Pannofino.
Oggi, l'azienda in piena attività produce 150 quintali al
giorno di torroncini, seguiti, per volumi di vendita, dal latte di mandorla,
«molto apprezzato anche al Nord dove si beve tutto l'anno», e da nuove
golosità: le rivistazioni delle paste di mandorla, come "Lapilli" e
"Libecci", le uova di pasqua, le tavolette di cioccolata con l'arancia
candita, con la granella di mandorle pralinate, di cioccolato bianco con
pistacchio di Bronte. E già si sta lavorando a un nuovo prodotto, come
sempre una ricetta tipica rivisitata.
Negli ultimi anni la crisi ha colpito anche questo
settore. «Si compra meno, ma per fortuna non si rinuncia al dolce. Noi
resistiamo perché abbiamo puntato sulla qualità. Il nostro è un segmento di
fascia media: chi fa un regalo non cerca solo il prodotto, ma vuole
un'emozione». Qualità anche negli ingredienti. «Usiamo mandorle siciliane e
mediterranee, non quelle californiane che sono più legnose». Snocciola una
poesia di delizie: la romana, fascionello, genco, pizzuta d'Avola, pg
Sicilia e la prelibata tuono, «al cento per cento dolce».
I segreti del successo
Il futuro? Per Giuseppe continuare a far crescere
l'azienda, mentre la sorella Gloria si occupa della pasticceria e del punto
vendita catanese. «Restare in Sicilia e portare avanti la nostra attività in
cui manteniamo un rapporto familiare con chi lavora - conclude Giuseppe
Condorelli - E soprattutto salvaguardare sempre il tocco artigianale: nel
nostro torroncino, la miscelazione della frutta secca, mandorle e pistacchi
tostati, viene ancora fatta manualmente».
E lo dice ancora con un pizzico di orgoglio, «perché la
nostra isola ha tante risorse, ma non riusciamo a fare sistema. Così come
hanno fatto i produttori di vino, dovremmo potenziare la nostra qualità,
credere di più nelle nostre potenzialità e fare diventare un modello del
settore agroalimentare i nostri dolci siciliani».

Profumo è la parola chiave che descrive meglio di ogni altra la
pasticceria Russo, piccolo e storico laboratorio di Santa Venerina,
paese etneo. Profumo di dolci, di cannella, mosto cotto, canditi,
chiodi di garofano, mandorle e liquirizia in un mix che ci riporta
indietro. Al tempo in cui a spadroneggiare non erano solo cannoli e
cassate, di cui qui per scelta non parleremo, ma i mille altri dolci
di Sicilia, quelli creati in varietà infinite nei piccoli borghi di
provincia. Delizie aromatiche, paste secche e biscotti di ogni tipo.
E’ il 1880 quando il signor Lucio, nonno dei fratelli Russo, attuali
proprietari dell’omonima pasticceria, appena diciannovenne e figlio
di ebanisti, decide di partire per Catania e lavorare in una bottega
di dolci. Gli basta un mese per fare bagaglio della propria
esperienza, ritornare al paese, aprire un suo laboratorio e
inventare i “biscotti ca’ liffia” da vendere nei battesimi
organizzati dalle famiglie benestanti.
Per ogni battesimo chili e chili di paste tra cui ne spiccavano tre,
come piramidi: uno per il parroco, uno per la levatrice e uno per la
madrina, ospiti d’onore.
Sono passati 135 anni da quel momento, ma la specialità dei fratelli
Russo è sempre la stessa. Stessa ricetta, stessa preparazione,
stesso ingrediente: la “liffia”. Cacao con aggiunta di zucchero e
acqua, un’emulsione che viene “alliffiata”, raffinata, con la sua
lavorazione. Ne viene fuori una glassa che mani sapienti fanno
scivolare sul biscotto.
Il profumo diventa allora quello della storia. Tre generazioni che
continuano nello stesso mestiere. A impastare, mescolare, riempire,
decorare, infornare con la calma e la pazienza che solo i veri
pasticceri e i veri artigiani possono avere.
Da buon figlio di ebanista, il signor Lucio diede la giusta
importanza all’arredamento acquistando un mobile da una antica
farmacia in chiusura, che servisse da vetrina per i dolci e separé
tra la bottega aperta al pubblico e il piccolo laboratorio.
Quel mobile è ancora li, imponente e caldo, vigile pastore dei dolci
esposti in vetrina.
Ancora è lì, presentato con lo stesso orgoglio da Anna, la sorella
più piccola dei Russo. Un po’ in contrasto con la sala destinata ai
clienti, meno curata nei dettagli, poco accogliente e fredda
d’inverno. Un contrasto accettabile perché rispecchia autenticamente
le peculiarità dei fratelli, divenuti pasticceri contro la volontà
dei loro genitori.
Accogliente, fiera e intelligente, Anna è l’anima della pasticceria
Russo. E’ lei che tiene unita la famiglia mediando tra il
laboratorio e la sala, tra i fratelli, tra l’azienda e i clienti,
tra il passato e il futuro della pasticceria. E’ l’unica dei tre ad
avere una figlia e due nipoti, speranza di continuità di una
tradizione ormai secolare nella produzione di dolci che va
preservata e tramandata.
Introverso, delicatamente schivo, Salvatore sta alla cassa, accenna
un sorriso distaccato senza mai riuscire a lasciarsi andare. Gentile
su richiesta, senza troppo pretendere, è lui che si occupa con
attenzione e meticolosa dedizione della contabilità dell’azienda
familiare.
E poi Maria Nevia. Curiosa, creativa, vivace e testarda. La vera
pasticcera: il cuore dei Russo. Infinitamente appassionata. Da 49
anni lavora, stampa e decora la pasta reale.
Altra specialità composta da zucchero e mandorle che insieme danno
vita ad un’imitazione della natura nelle sue infinite forme.
Una pasta che si trasforma nei frutti locali, nelle mele dell’Etna
(le cosiddette puma cola) o nelle fragole di Maletto, nei fichi
d’india, negli agrumi (mandarini e tarocchi), e poi frutta secca
come i pistacchi di Bronte.
E ancora in ortaggi, cozze, “masculine ra magghia” e pesci di ogni
tipo, tutto rigorosamente siciliano. Impossibile alla vista
distinguere tra il vero e il falso.
Dai Fratelli Russo non potete perdere la mostarda fatta con mosto
cotto, ridotto della metà, e cenere di sarmenti in infusione. Niente
zucchero aggiunto. Bastano i sarmenti (tralci di viti) ad addolcire l’uva ed eliminarne
l’acidità. Il tutto viene poi filtrato, addensato e messo negli
stampi per la stagionatura. Ne vengono prodotte due tipologie. La mostarda fresca, consigliata
per i più golosi, è una crema gelatinosa e scura ricoperta di
cannella, da mangiare al cucchiaio. A pezzi invece quella stagionata, presentata su foglie di alloro che
anticamente avevano la funzione di allontanare gli insetti durante
la stagionatura.
In un’antica pasticceria siciliana è obbligatorio assaggiare la
cotognata. Provarla significa entrare nelle case di ogni singola
famiglia dell’isola ossessionate dalle tradizionali e cicliche
preparazioni legate ai periodi dell’anno.
Preparata con mele cotogne, frutto aspro utilizzato solo per
preparare marmellate e, per l’appunto, le cotognate, fatte indurire
in stampi di terracotta, talmente belli da diventare col tempo
oggetti di arredo.
Consigliamo di assaggiare le tortine paradiso, versioni in miniatura
della torta paradiso, inventate dal padre dei Russo, Giuseppe, che
volle trovare il modo di non buttare via i tuorli delle uova usate
per creare le paste di mandorla.
Ne vennero fuori delle tortine golose ma un po’ dure, motivo per cui
vennero in seguito ammorbidite con l’aggiunta di albume.
Da provare anche i pasticcioni o le paste secche fatte con la
“zuccata”, una zucca lunga dalla buccia verde e dalla pasta bianca,
che viene fatta decantare su sale grosso per perdere acidità e
lavorata poi con lo zucchero. Ottima anche come frutta candita.
Infine, nonostante la nostra scelta iniziale, non possiamo fare a
meno di consigliare il cannolo, meglio ancora se con crema
pasticciera e spolverata di cannella regina. Se poi fate colazione e
i vostri palati non si sono stancati di peccare di gola, prendete
una granita alla mandorla amara e un croissant al miele dell’Etna.
Lo so, siamo in Sicilia, mica in Francia, ma sappiamo fare tutto.
Pasticceria F.lli Russo
Via Vittorio Emanuele, 105 – S. Venerina (CT)
Tel/Fax +39 095 953202
email: informazioni@dolcirusso.it
http://www.dissapore.com/grande-notizia/pasticceria-russo-santa-venerina-recensione/

Nonna Vincenza è di un paesino in provincia di Enna, Agira. Qui, sin
dall’età di sei anni, aiuta zia Provvidenza, suora laica e dolciera del
paese, nella produzione artigianale della tipica pasticceria tradizionale
siciliana destinata ai matrimoni. Era infatti usanza per i nubendi andare a
prenotare prima i dolci da Sr Provvidenza per poi pensare a tutto il resto.
Così Vincenza, giorno dopo giorno, impara i segreti della zia e si
appassiona al punto da aprire, molti anni più tardi, la sua pasticceria: I
dolci di Nonna Vincenza. Ma andiamo con ordine. Dopo l'infanzia passata ad
Agira, si innamora del capo coro della chiesa del paese, Giuseppe, lo sposa,
mette su famiglia e, sempre con lui, si trasferisce a Catania
. Una volta
arrivata nella
città barocca, la sua passione per i dolci non svanisce: lei vorrebbe aprire
una pasticceria ma il marito, con la passione per la musica, non è poi molto
d'accordo. La cosa non ferma Vincenza che comincia a preparare dolci per i
parenti e gli amici, nel frattempo i sette figli crescono e la convincono a
concretizzare il suo sogno. Arriviamo così al 5 febbraio 1997, festa di
Sant'Agata, la più importante festa religiosa di Catania. È in questo giorno
che viene inaugurata la sede storica della pasticceria a gestione familiare,
caratterizzata da uno stile elegante, raffinato, e che sta espandendosi in
Italia e prossimamente all'estero.
Dal 1997 a oggi la pasticceria di Vincenza ne ha fatta di strada,
anche grazie alla lungimiranza dei tre figli coinvolti a tempo pieno
negli affari dell'azienda. Alessandro si occupa della produzione,
Salvo dell'aspetto commerciale e Paolo Pistone, il primogenito, è
colui che sceglie le materie prime. “Il tutto è coadiuvato da mamma
Vincenza che, nonostante i suoi ottantatré anni, ci consiglia e ci
sostiene”. Paolo parla a nome di tutti i fratelli. “È soprattutto
grazie a lei che oggi abbiamo dieci punti vendita tra Catania, Roma
e Bologna ed è sempre grazie alla sua capacità di appassionarsi e di
appassionare che continueremo a diffondere le tradizioni siciliane
in Italia e tra un po' anche all'estero”. La prossima apertura è
prevista agli inizi di dicembre nella Strada Maggiore, centro di
Bologna, e tra non molto apriranno negozi a Londra, in zona Oxford
Street, e a New York: “Ci stiamo già muovendo e siamo andati a
vedere un po' di location papabili. I negozi saranno a Manhattan
mentre il laboratorio sarà in periferia. In questo caso il
caseificio si farà in loco perché il latte di qualità lo si può
procurare ma per quanto riguarda la ricotta, questa, necessita di
tecniche e procedure particolari”. Tale scelta strategica, portare
il loro know how siciliano a New York utilizzando le materie prime
del luogo (lì dove è impossibile trasportarle da Catania), è
applicabile a tutte le città e sembra vincente dal punto di vista
della qualità dei prodotti. “È innegabile che la ricotta fatta al
momento, con la sapienza dei casari siciliani, sia migliore di una
ricotta, proveniente sì dalla Sicilia, ma che ha dovuto subire ore e
ore di volo”.

Se da una parte c'è questo slancio verso l'estero, dall'altra Paolo
e i suoi fratelli stanno puntando molto sul loro territorio. “Stiamo
investendo molto sull'agricoltura: abbiamo undici ettari di
mandorleto ad Avola e un pistacchieto di cinque ettari a Bronte.
Sempre a Bronte, abbiamo gli aranceti e vogliamo istallare delle
arnie per il miele (che ora comprano a Zafferana Etnea e a Sortino),
tra le coltivazioni. L'obiettivo? L'auto approvvigionamento, anche
se per ora la produzione non è sufficiente”. Oltre alle
coltivazioni, Paolo, vorrebbe aprire un caseificio anche a Catania.
Per ora la ricotta arriva dal caseificio Fioretta e dal consorzio
Ragusa Latte. Questa viene poi trasportata a Roma e a Bologna dentro
dei furgoni di loro proprietà, rispettando la catena del freddo a 4°
C
Oltre alla ricotta, vengono trasportati tutti i loro prodotti:
pasticceria secca alle mandorle, ai pistacchi, al mandarino,
all’arancia; infasciatelli, buccellati, nocatole, olive di
sant’Agata, pesto di pistacchi, creme in barattolo. E ancora
cassatine e cassatelle, pasta di mandorla, dalla frutta martorana ai
pasticcini aromatizzati al limone, al mandarino, al caffè o al
pistacchio. Non solo dolci ma anche i rosoli della Nonna, al limone,
alla cannella, all'alloro, ai fichi d’india, al latte, al
finocchietto... Ogni giorno arriva tutto dalla Sicilia, insieme al
resto della materia prima per la produzione fresca che, nella
maggior parte dei punti vendita, avviene nel laboratorio per
garantire la qualità dei prodotti. E negli altri punti vendita,
quelli che il laboratorio non ce l'hanno, come vi organizzate? “In
questi casi facciamo arrivare i cannoli già pronti: all'interno
della cialda c'è uno strato di cioccolato per evitare che si inzuppi
la cialda stessa. Lo sappiamo che non è il massimo ma secondo noi è
il male minore. Tra l'altro quando nell'aeroporto di Catania
proponevamo i due tipi di cannoli, quelli classici e quelli con
copertura di cioccolato, vincevano i secondi”.
E a proposito di aeroporti, ci sono due punti vendita in quello di
Catania (agli arrivi e alle partenze), uno nell'aeroporto di Bologna
e, ultimo in ordine di apertura, in quello di Roma Ciampino. Ma cosa
li ha spinti ad aprire dei negozi in luoghi così spiccatamente non
luoghi? “Dopo l'apertura nella piazza della chiesa barocca di san
Placido a Catania ci siamo resi conto che i nostri prodotti sono
apprezzati sia dagli italiani che dagli stranieri. Nonostante oggi
la percentuale di vendite agli italiani sia del 60%, contro il 40 di
quelle destinate agli stranieri, queste ultime stanno aumentando
moltissimo. Così abbiamo pensato di aprire negli aeroporti, dove si
possono intercettare anche molti stranieri. L'investimento sta dando
i suoi frutti, basti pensare che il punto vendita dell'aeroporto di
Catania è il nostro maggior store a livello di fatturato”.

È ovvio dunque che la famiglia Pistone abbia dovuto investire molto
ma è altrettanto evidente che le cose stiano girando bene sia a
livello economico (dato che dalla loro parte c'è anche un'economia
di scala che permette di trattare sul costo delle materie prime) sia
a livello di immagine. Sì, perché nei loro punti vendita viene
proposta la tradizione siciliana, quella giusta, quella vera, che
non ha nulla a che fare con i cannoli ingialliti che si vedono in
molti bar e pasticcerie. “Per mantenere qualità e artigianalità ci
deve essere prima di tutto una selezione spietata delle materie
prime. Poi un controllo costante su tutti i prodotti che escono dal
magazzino centrale di Catania e infine bisogna avvalersi di
personale preparato: tutte le persone che lavorano nei nostri store
sono formate. Ciascuno di loro sa come riconoscere una ricotta
buona. Così, anche se ci dovesse essere un intoppo durante il
trasporto, tutti sono in grado di accorgersene. Il segreto è
assaggiare. E loro lo devono fare sempre, perché ci sono ingredienti
che all'olfatto sembrano buoni e poi, al gusto, si rivelano
difettosi. Per esempio, se il miele surriscaldato ha un retrogusto
di fumo, non va bene”. E un cliente che prima di comprare, e dunque
assaggiare, deve giudicare attraverso la vista, come fa a
riconoscere un buon cannolo? “Diffidate dai colori sgargianti: no ai
pistacchi verde fluo o ai canditi arancione fosforescente. A
proposito di canditi, io li eviterei perché coprono il sapore
delicato della ricotta che deve essere bianca. Il color giallino è
intollerabile. Poi tra cialda e ricotta non ci deve essere spazio,
se c'è, i cannoli hanno più di un giorno”. E così, oltre ad aver
scoperto una bella storia imprenditoriale tutta italiana, abbiamo
anche il tutorial per riconoscere il cannolo impeccabile...
www.dolcinonnavincenza.it
a cura di Annalisa Zordan
http://www.gamberorosso.it/it/food/1020701-i-dolci-di-nonna-vincenza-tutta-la-storia-da-catania-a-new-york

In centro, famoso era
Finocchiaro, preferito da attori di varietà
quando essi si esibivano a Catania, e dove abitualmente consumavano i
loro pasti i giocatori della locale squadra di calcio. Altro ristorante
rinomato era il "Venezia" in via Montesano e gestito da
Indelicato. Ma si andava volentieri da Gennarino, in piazza Manganelli,
o al "Rumba", angolo vie Etnea Carcaci (al primo piano)
gestíto da De Maria, o da Alba, che prima di trasferirsi in via
Corridoni aveva l'originaria sede, se non ricordo male, in via
Penninello e si chiamava
"Bolognese". Altri noti ristoranti di
quel periodo: il "Trinacria", il "Ciclope", Lorenti,
"Rivoli", "Antonella" (piazza G. Verga) noto anche
per una frequentazione perlomeno sospetta.
A Piano Tavola venne aperto (durò poco, purtroppo) il "Chicchirichì",
caratteristico locale in cui si servivano pietanze romane, che non
disturbò la fama di La Rosa (porchetta e zuppa di fagioli) ubicato nei
pressi. A nord, verso la città alta, c'era "Donna
Palma"
e più sù, a Cerza, Don Santino
dove con pochi spiccioli si gustavano ottimi legumi.
Altre mete, per le crispelle,
Stella, Pistorio (che iniziò in piazza
Carlo Alberto) e Milardí in piazza Spirito Santo. Per le pizze era
privilegiata "La Fattoria",
all'interno del "Sangiorgí",
in cui furoreggiava Carmine che fu il primo a portare la vera pizza
napoletana a Catania.
Fra i bar e le pasticcerie è d'obbligo naturalmente ricordare Caviezel
dei mitici Nicolosi, Alíoto, Leopardi, Anastasi, Costa, Caudullo,
Ragusa, Fassari, i Tusa, Licciardello, Rutella, Gíuffrida, Alivu,
Campagna ecc.; Ardizzone, sempre in via Etnea alle spalle della statua
di Garibaldi; Tripi, che rimaneva aperto l'intera nottata e dove io presi una
terrificante sbornia di birra al demoniaco jocu du patruni supra e sutta;
il "Bocconcino" (di Carmelo Li Sciotti) in piazza Duomo che
fungeva anche da rosticceria;
Corsaro in via Santa Maria del Rosario,
bar dei giornalisti e quindi male in arnese.
In questa brevissima rassegna condotta sul filo dei ricordi, dunque
necessariamente incompleta (e delle omissioni ne è corresponsabile
l'amico Rodolfò Bandieramonte che mi ha aiutato in tale sforzo di
memoria), vorrei per mio e, nonostante tutto, altrui decoro non
menzionare le varie putìe in cui con immonda continuità ci riversavamo
la sera per ingozzarci di vili pasti e altrettanti vili libagioni. Ma
non posso, quantomeno per la memoria del lettore, non ricordare (oltre
Don Neddu) la putìa accanto al Castello Ursino e i cui titolari
avrebbero poi realizzato il "Nord Ovest", oggi in nostalgica
rovina.
da
"A Catania con amore" di Aldo Motta - Edizioni Greco


Il ristorante Gennarino, presso il Palazzo San Nicolla in zona Quattro Canti (Via
Antonino di Sangiuliano, 281)


Oggi
al Caffé si va per prendere il caffé. Da soli, o anche in compagnia di un
amico, col quale, volendo, si possono scambiare i soliti convenevoli, e spesso
anche insipide parole di prammatica. Il tutto presentato in confezione ridotta
e sorbito come il più ristretto dei caffé. Giusto il tempo dí vuotare la
tazzina e accendere la sigaretta. Poi, un saluto frettoloso e via di ritorno
alla base di partenza: casa, ufficio, negozio, scuola; quello che sia.
Oggi si va al Caffé per assumere caffeina, di solito nelle ore meridiane. Ma
se si va nel pomeriggio, non cambia niente. E il Caffé, inteso come locale
nel quale si ammannisce l'aromatica, bevanda, può essere sempre lo stesso,
magari quello più a portata di mano ma può anche essere un altro, o cento
altri, all'angolo di casa, nel centro storico, in un lontano quartiere di
periferia.
Passare da un Caffé all'altro, da un giorno all'altro, o nell'arco della
stessa giornata, non interessa nessuno, non scandalizza nessuno, non dice
niente a nessuno, purché nella tazzina ci sia il contenuto che ci deve
essere, lungo, stretto, amaro, dolce.
Una volta, fino all'esaurirsi degli anni Trenta, al Caffé si andava píù nel
tardo pomeriggio che di mattina, sempre nello stesso locale. E, a meno dí
fatti eccezionali o di sopravvenute esigenze, non erano ammesse deviazioni,
né tollerati ripensamenti, né tantomeno tradimenti.
Si andava, forse anche per degustare una tazzina di caffé, certamente per
l'ineffabile piacere di incontrarsi o magari scontrarsi con gli amici,
dialogare, esibirsi, pontificare, scambiare pensieri, idee, opinioni.
Naturalmente, seduti a proprio agio, come nel più accogliente dei salotti.
La tazzina consumata all'impiedi non era pensabile, tranne al bar della
Stazione, o in certi locali anonimi, quando non se ne poteva fare a meno.
Nel centro storico della città, prima degli anni Trenta, prosperarono Caffé
di così chiara rinomanza da passare se non alla grande storia, certamente
alla piccola storia di Catania.
Furono locali ricchi d'una propria identità, dove persone di spiccata
levatura, d'alto ingegno, di nobile prosapia, trascorrevano ore e ore a
discutere, a confrontarsi, a litigare. A bassa o ad alta voce, a seconda della
scabrosità dell'argomento, dentro nei mesi freddi, fuori d'estate, sempre
allo stesso posto, attorno allo stesso tavolo, serviti dallo stesso cameriere.
In quel tempo, in alcuni di codesti Caffé (ma anche nel retro di certe
farmacie e nei séparés di talune "case" di lusso), vennero
discussi argomenti di politica locale, si stabilirono nuove alleanze, si
formularono programmi, si avviarono contese cavalleresche.
Ma, con la politica, non si esauriva il discorso. Si dibattevano pure problemi
di carattere letterario, di poesia, di arte, di costume. Si parlava, si
sparlava, si recitava a soggetto.
Ai tavolini di quei Caffé, scrittori già arrivati vergarono pagine
significative di alcuni loro romanzi. Furono quelli i Caffé politici e i
Callé letterari. Ritrovi che oggi potremmo chiamare i Caffé della memoria.
Fu prerogativa tutta catanese? No.
Milano, Roma, Firenze, Padova, Venezia, Viareggio, Pisa, Napoli ebbero i loro
Caffé della memoria: il Rosati, il Greco, lo Strega, l'Aragno, il Giubbe
rosse, il San Marco, l'Ussero, il Gambrinus.
Scriveva Riccardo Bacchelli: "Se si pensa che un tempo andavamo al Caffé,
in media due volte al giorno, le prime ore del pomeriggio, e a passarvi la
serata, ci si avvede di quest'altro cambiamento nel costume nazionale. La più
parte dei Caffé hanno chiuso; i pochi che resistono sono cambiati; pochissimi
sussistono, e come cimeli di tempi andati. Il carattere pubblico, aperto,
spontaneo e libero delle riunioni ch'essi procuravano, aveva il gran pregio
della liberalità; e gli stessi vizi e difetti ad esso inerenti, coi parlatori
a vanvera quando c'erano, vi trovavano naturale e spontanea correzione. ( ...
) La liberalità di tal costume, che esigeva e importava una semplicità e
discrezione civile e civica, cominciò a essere osteggiata e ferita a morte da
quando principiò la sopraffazione a sormontare la díscussione, e alla scelta
ragionata fu sostituita l'imposizione imperiosa: politica, ideologica,
polemica, diffamatoria, e finalmente verbalistica, ingiuriosa, dispotica...
Non si tratta di rimpiangere né di ripristinare caffé-salotto perché i
rimpianti sono oziosi e il voler ripristinare è vano. Per altro, in un
consorzio dove tendiamo ad essere ognuno sui piedi e a ridosso dell'altro,
senza vera ed efficace comunicazione socievole, qualche consuetudine e
istituto che sostituisse il caffé-salotto non sarebbe inutile".
fonte "Catania anni Trenta"


 Ubicata
nel lato ponente-tramontana del palazzetto Biscari, constava di due
ampi saloni e aveva l'ingresso su piazza S. Nicolella. Gestita dai
fratelli Tscharner Ubicata
nel lato ponente-tramontana del palazzetto Biscari, constava di due
ampi saloni e aveva l'ingresso su piazza S. Nicolella. Gestita dai
fratelli Tscharner , svizzeri d'origine catanesi d'adozione, la
Birraria era il ritrovo preferito dai giornalisti, ma anche dai
commercianti, negozianti, funzionari della vicina Posta. , svizzeri d'origine catanesi d'adozione, la
Birraria era il ritrovo preferito dai giornalisti, ma anche dai
commercianti, negozianti, funzionari della vicina Posta.
I giornalisti, preponderanti e rumorosi,
"occupavano due tre tavoli del settore loro riservato, discutendo
commentando vivisezionando i fatti del giorno, preferendo fatti e
misfatti politici, esaltando o censurando ministri senatori
deputati, con una libertà di giudizio che li rendeva deliziosamente
interessanti. Per loro gli Albertina, i Luzzatto, i Morello, gli
Scarfoglio altro non erano che colleghi collocati dalla geografia e
dal caso, più in vista; con costoro, all'occasione, volentieri
polemizzavano; e le occasioni non mancavano, giacché è utile tener
presente che uno che se ne intendeva, Francesco Crispi, aveva
definito Catania di quegli anni la più difficile prefettura del
Regno, e Catania, dai caporioni ai maneggioni della politica, a tale
definizione teneva assai, se ne gloriava, anzi ".
Non vi furono intellettuali, oltre ai
giornalisti, fra gli abituali frequentatori della Birraria? Vi
furono. Basterà ricordare Francesco Guglielmino e Nino Martoglio. Nel '14, la Birraria si trasferì al pianterreno
del palazzo Tezzano, con tre ingressi su via Etnea.

Il nuovo locale si impose all'ammirazione dei
catanesi per l'ampiezza, l'armoniosa compostezza delle strutture
interne, l'aristocratica sobrietà dell'arredamento.
Sul frontale esterno, al riparo d'una longilinea
pensilina di vetro, campeggiavano ventidue grandi lettere d'ottone
brunito: Grande Birraria Svizzera. Tra un ingresso e l'altro,
guarnite dagli stipiti intagliati in pietra tenera di Siracusa,
facevano spicco due eleganti lastre di marmo con l'indicazione di
alcune specialità della Ditta. Ne fu autore l'architetto Paolo
Lanzerotti, gentiluomo e musicologo, professionista di largo
ingegno, apprezzato e richiesto a Catania e fuori.
Inaugurata il 29 maggio del 1915, con una fastosa
cerimonia che riempì le cronache cittadine, la grande birraria
divenne il ritrovo più accogliente, ambito e salottiero della città,
in aperta gara col Diana di Milano, allora ritenuto il più elegante
Caffé d'Italia.

Un'orchestrina di taglio viennese deliziò le
serate della Catania bene che, dame in testa, affollò
l'aristocratico locale in quell'epoca.
Scomparsi i fratelli Tscharner, prima il
maggiore, poi il più piccolo che si era sposato ad un'avvenente
donna, già violinista nel l'orchestrina di cui si è appena detto,
nei primi anni Trenta il prestigioso locale passò nelle mani
dell'indimenticabile Peppino Lorenti.
Riammodernato secondo il gusto e le esigenze dei
nuovi tempi, impreziosito da alcune sanguigne di Roberto Rimini,
dotato di un'ampia sala di biliardi nei cantinati, la grande
birraria si trasformò in Gran Caffé Lorenti, perpetuando i
fasti della sua tradizione.
A quei tavolini infiorati, affluirono personaggi
di rango, professionisti di grido, artisti famosi, alti gerarchi.
Ne ricordiamo solamente alcuni: Attilio Momighano
e la sua bellissima moglie; Francesco Guglielmino dall'inseparabile
pipa; Giuseppe Villaroel infaticabile ricercatore d'immagini
poetiche e di donne procaci; Vitaliano Brancati coi fedelissimi
Leone, Giardina, Rapisardi, Centorbi, Ardizzoni, Rossi, Blandini.
Un tavolo a parte eran soliti occupare Vincenzo
Zangara, Lo Giudice e Pietrangelo Mammano.
Saltuariamente vi bazzicavano alcuni giovani di
belle speranze, come Arturo Mannino e Vittorio Frosini, ai quali
incombeva l'onere e e l'onore di accompagnare a casa i due poeti,
Villaroel e Guglielmino, quando s'eran fatte le ore piccole.
Serate memorabili furono quelle in cui coi
maestri vollero misurarsi, in dotti conversati o in tenzoni poetiche
estemporanee, Ferdinando Cajoli, Vito Mar Nicolosi, Prestinenza,
Giacomo Etna, Gesualdo Mantella.


 Nel
1930 Giuseppe Lorenti, avendo saputo che il gestore Rizzo si
accingeva a lasciare la Birreria svizzera di via Etnea 141-143-145,
la prese in affitto. Il locale, dopo pochi mesi, gli fu offerto in
vendita e Lorenti lo acquistò. Poteva contenere 500 persone sedute a
tavolino, funzionava da ristorante, bar, gelateria e sala da
biliardo. Nel
1930 Giuseppe Lorenti, avendo saputo che il gestore Rizzo si
accingeva a lasciare la Birreria svizzera di via Etnea 141-143-145,
la prese in affitto. Il locale, dopo pochi mesi, gli fu offerto in
vendita e Lorenti lo acquistò. Poteva contenere 500 persone sedute a
tavolino, funzionava da ristorante, bar, gelateria e sala da
biliardo.
Nel 1934 divenne un café chantant: per la prima
volta nella storia di Catania in un pubblico esercizio suonava
un’orchestra, composta da sette donne e diretta dalla borghese
Soffritti. Questo divenne il locale di moda di Catania, nel quale
conveniva la migliore società.
Nel 1935 il Gran caffè Lorenti lanciò a Catania i
coni gelati (semplice 20 centesimi l’uno, con panna 50 centesimi),
che andavano a ruba; fra gli ospiti di riguardo, prima che
scoppiasse la guerra, il gran caffè accolse il duca di Windsore il
re d’Inghilterra Edoardo VIII.
Nel 1939, il locale fu
arricchito di sei grandi dipinti murali del pittore Roberto Rimini e
durante la guerra era anche meta dei militari tedeschi; l’8 luglio
1942 fu parzialmente danneggiato da una bomba e, pertanto, chiuso.
Riparato in seguito, fu occupato dalle truppe
inglesi; al pubblico italiano fu riaperto nel 1945 e nella serara
inaugurale si esibì un’orchestrina diretta da Mario Giusti
(batterista) e composta tutta da catanesi.
Mentre si accingeva a riparare definitivamente il
locale, Lorenti ricevette offerte vantaggiose dall’UPIM, per
l’affitto; fu così che, nel 1948, l’ampio locale fu ceduto in
affitto alla grande organizzazione di vendita e il Gran caffè
Lorenti cessò di esistere con grande rammarico dei catanesi.
E' morto a 86 anni
Ugo Lorenti.
Finisce con lui una dinastia di
commercianti conosciutissimi a Catania. Il commendatore Peppino Lorenti, il
capostipite, prima della seconda guerra
mondiale gestiva il ristorante del Sangiorgi, in via di San Giuliano, dove
si esibivano le grandi compagnie di rivista. Poi aveva realizzato la
Birreria Lorenti in Via Etnea, un vasto locale di lusso di fronte alla
Pasticceria Svizzera dei Caviezel.
Allora Via Etnea era il salotto di Catania che si racchiudeva nei cento
metri tra piazza Stesicoro e la statua di Garibaldi di fronte alla Villa
Bellini e all'albergo Italia. In quei 100 metri c'era il «cuore» della
città: salendo verso la Villa sulla sinistra c'erano il negozio di tessuti
degli svizzeri Caflish, la farmacia chic di Spadaro Ventura, la rosticceria
Giardini, il cinema Sala Roma, la Birreria Lorenti, l'orologeria Cicala, e
il palazzo delle Poste; sulla destra il negozio di dischi Riva, la
Pasticceria dei Caviezel, l'ingresso dell'albergo Central Corona con due
leoni di marmo, il negozio di occhiali Balestrazzi dove lavorava la
commessina Eugenia Bonino eletta Miss Italia, lo studio fotografico del
signor Marino nel cui archivio c'erano le foto della vecchia Catania e poi
le rinomate pasticcerie Spinella e Savia prima di svoltare in via Umberto. I
locali della Birreria vennero poi ceduti all'Upim e Peppino Lorenti, padre
di Ugo e Ferruccio, decise di trasferirsi al Viale XX Settembre per
realizzare assieme a Ugo il gran Caffè Lorenti.

Il commendatore aveva capito
con largo anticipo che il Viale sarebbe diventato il nuovo salotto della
città. All'angolo con piazza Giovanni Verga, il Caffè Lorenti divenne presto
frequentatissimo da avvocati e loro clienti per la vicinanza del Palazzo di
Giustizia. Ci andavano
anche i giovani della Catania bene perché in un salone si tenevano i primi
tè danzanti. D'estate i tavolini venivano messi fuori fino a tarda sera e
molti ragazzi aspettavano che passasse l'autobus per il Lido dei Ciclopi
inaugurato agli inizi degli anni 50. Era un punto di ritrovo gradevole
perché in quegli anni non erano molte le auto in circolazione e quelle poche
che giravano erano viste con grande curiosità.
Al Caffè Lorenti la domenica mattina erano soliti ritrovarsi gli ex
pallanotisti catanesi, quelli che avevano fatto parte della bella gioventù
catanese,
Franco Pintaldi «Taralla», Ciccio Calabretta, Saverio Barbagallo,
Geo Magrì,
i fratelli Armando e Pietro
Cucinotta e tutti gli altri compagni
d'avventura. Poi il figlio del commendatore Ugo, realizzò un suo ristorante,
battezzato Rivoli, che era uno dei più belli di Catania ed ebbe lunghe
stagioni di successo. Il ristorante Lorenti si spostò anche alla Nave, nella
villa appartenente al notaio Pittella sul mare di Ognina. Stavolta non ebbe
gran fortuna, forse perché era troppo di nicchia, tanto che chiuse e poi vi
si insediò il Club della Stampa allora retto da Filippo Galatà, giornalista
ed alto dirigente della Provincia. gli ex
pallanotisti catanesi, quelli che avevano fatto parte della bella gioventù
catanese,
Franco Pintaldi «Taralla», Ciccio Calabretta, Saverio Barbagallo,
Geo Magrì,
i fratelli Armando e Pietro
Cucinotta e tutti gli altri compagni
d'avventura. Poi il figlio del commendatore Ugo, realizzò un suo ristorante,
battezzato Rivoli, che era uno dei più belli di Catania ed ebbe lunghe
stagioni di successo. Il ristorante Lorenti si spostò anche alla Nave, nella
villa appartenente al notaio Pittella sul mare di Ognina. Stavolta non ebbe
gran fortuna, forse perché era troppo di nicchia, tanto che chiuse e poi vi
si insediò il Club della Stampa allora retto da Filippo Galatà, giornalista
ed alto dirigente della Provincia.
Per più di 70 anni il nome della famiglia Lorenti è stato sinonimo di
ritrovi signorili: la morte di Ugo richiama con nostalgia il ricordo di
quella Catania che «chiu va e chiu bella addiventa», come diceva Turi Ferro
alla Radio in «Tutta la città ne parla».
Tony Zermo

il Gran Caffè Lorenti


foto
di Stefano Corso (Cufter)

anni 30-40 - la succursale estiva alla Villa Bellini

RICORDI DEGLI ANNI PASSATI




Il ristorante del Teatro Metropolitan (foto di Franz Cannizzo)

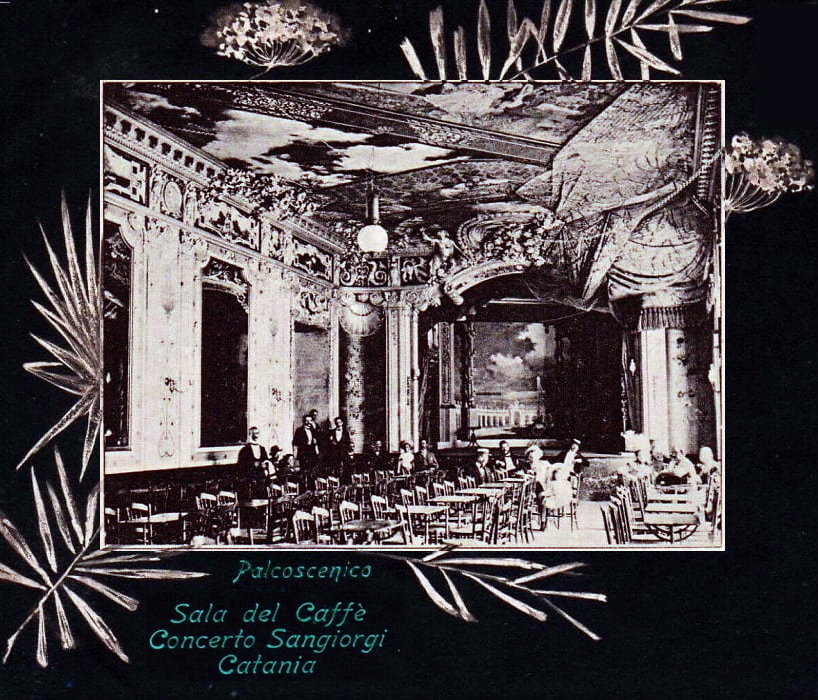
I LOCALI OGNINESI
LA PIZZA A CATANIA
Chi di noi non è cresciuto con il buon sapore della pizza
.gioia e delizia non solo per il palato ma anche per i nostri occhi ,è uno degli
alimenti più gustosi e ricercati ;nel corso degli anni le nostre città si sono
riempite di pizzerie ed i gusti sono notevolmente aumentati;a volte riesce
persino difficile scegliere una pizza leggendo il menu ! E non è sempre
necessario andare in pizzeria poiché panifici e bar sono attrezzati a soddisfare
i gusti dei propri clienti.....insomma la pizza oggi si trova ovunque e
dovunque! pizzeria poiché panifici e bar sono attrezzati a soddisfare
i gusti dei propri clienti.....insomma la pizza oggi si trova ovunque e
dovunque!
Ma non è stato sempre così, anzi i nostri nonni e bisnonni
non hanno avuto il piacere di conoscerla e gustarla !È un piatto che a Catania e
in tutto il mondo è stato "adottato" ma è un'invenzione napoletana.
Tralasciando l'origine della pizza, quando arriva per la prima volta la pizza a Catania e come ci
arriva?
Vi sorprenderà sapere che la sua presenza a Catania è,
diciamo,piuttosto recente; essa arrivò soltanto nel dopoguerra, nel novembre del
1946! Pare che fu preparata per la prima volta da due pizzaioli napoletani nel
ristorante aperto dal cav. Guglielmo Sangiorgi adiacente all'omonimo Teatro!
Eccone il racconto di Nello Pappalardo nel libro "Il
Sangiorgi:novant'anni di vita spettacolo e costume a Catania ":
<<Nei primi giorni di novembre si apre LA FATTORIA, un
ritrovo, che nell'architettura riproduce un tipico cortile agreste con falsi
balconcini, botti di vino e foglie di stucco. Funge da "ridotto "da dancing, e
presto vi si potrà gustare anche la famosa pizza confezionata da due pizzaioli
napoletani veraci ingaggiati appositamente, i fratelli Carmine ed Alfonso
Marrazzo ,con i quali collabora,per il fondamentale momento dell' "infornata"
,il catanese Carmelo Uccellatore. All'inaugurazione, con una apprezzabile
manifestazione di schietto sapore folkloristico,che fu radiotrasmessa ed alla
quale partecipò il complesso de "Gli amici del Dialetto "(Corriere di Sicilia, 8
novembre 1946), il poeta Giovanni Formisano, autore del testo E vui durmiti
ancora, dedica al gestore una poesia in dialetto, A Guglielmu Sangiorgi.>>
Turi Giordano per Obiettivo Catania






il
ristorante "scoglio di frisio" aveva una terrazza su palafitte,
attaccato alla "villa Spadaro" che in seguito divenne "ristorante
Costa Azzurra". Gli scogli in primo piano furono stravolti,
servirono da fondamenta su cui si impiantò l'allargamento della
terrazza Costa Azzurra, è visibile lo storico "scoglio bianco" e
l'antichissima "noria" circolare
Mario Strano


La Terrazza Balsamo fondata nel 1944, ormai storico
locale Catanese, racchiude i profumi, i sapori e gli incanti dell'isola,
esaltando gli aromi semplici e genuini delle ricette tipiche locali.
Una cena a base di pesce freschissimo, una pizza fatta
secondo la migliore tradizione Siciliana, queste sono solo alcune delle
tentazioni che offre la tradizione gastronomica di Catania. Questo locale
offre un ricco menù a vostra scelta per ogni tipo di sapore mediterraneo
terra di mare.
Oggi non esiste più.
IL PICCOLO GRANDE LORENTI, IMPRENDITORE
CATANESE
Giuseppe Lorenti, un uomo
piccolo,intelligente,straordinariamente attivo,diede vita a Catania
ad una serie di iniziative nel campo della ristorazione.Nato ad
Agrigento nel 1892,emigrò giovanissimo in Argentina,lavorò come
fattorino nella locale azienda dei telefoni e progredi' fino ad un
passo dall'assunzione come funzionario.Ma lo scoppio della I Guerra
Mondiale lo fece rientrare in Italia,dove fu spedito al fronte,fu
ferito,trasportato a Catania,poi assegnato ai servizi di mensa della
caserma "Feo".Trovò moglie e fissò cosi' la Sua residenza definitiva
a Catania.Fu nel 1930,ritiratisi Timarco e Rizzo che assunse la
gestione dell'intera "Birreria Svizzera" di Via Etnea
141-143-145,locale che dopo pochi mesi acquistò a condizione
vantaggiose (1 milione di lire che fini' di pagare,a rate,nel
1940).Il "Gran Caffè Lorenti" poteva contenere 500 persone sedute a
tavolino.Nel 1934 divenne "Caffè Chantant" (per la prima volta a
Catania in un pubblico esercizio suonava un'orchestra,composta da
sette donne e diretta dalla Bolognese Soffritti).

anni Sessanta - la nave sulla scogliera di San
Giovanni Li Cuti. Poi Club della Stampa e Lido Gambero.
Questo divenne il
locale alla moda di Catania,nel quale,sia la mattina che la sera,
conveniva la migliore società Catanese.Nel 1935 lanciò a Catania i
coni gelato (inimitabili i lattemiele) e vendette ben 10.000 coni
quando il gerarca PNF Achille Starace,si recò per un'adunata al
Giardino Bellini.Accolse il Duca di Windsor e nel 1939 il locale fu
arricchito da sei grandi dipinti murali del pittore Roberto
Rimini.Durante l'ultima guerra fu frequentato dal maresciallo
Tedesco Kesselring (fu effettuato anche un collegamento radiofonico
con Berlino).L'8 Luglio 1943 il "Gran Caffè" furono parzialmente
danneggiati dai bombardamenti aerei e quindi chiusi.Riparati,in
parte,furono occupati dagli Inglesi e riaperto al pubblico nel
1945.Nel 1948 Lorenti cedette in affitto i locali alla "Upim",a
fronte di un'offerta vantaggiosa e si propose con altre iniziative
imprenditoriali in città, sia in Corso Italia che sul lungomare di
Catania,a San Giovanni Li Cuti,scorcio che possiamo ammirare in
questa splendida cartolina che Mi è stata spedita da un amico della
famiglia Lorenti,Alessandro Russo ,che ringrazio per il gentile
pensiero nell'invio di questa splendida immagine d'epoca (siamo
durante gli anni '50 del secolo scorso),insieme a molte altre che
pubblicherò in questi giorni su questa pagina e domani, domenica,
con alcune anticipazioni sulla mia rubrica settimanale sul giornale
on line NewSicilia .
Franz Cannizzo

quel che resta del Selene

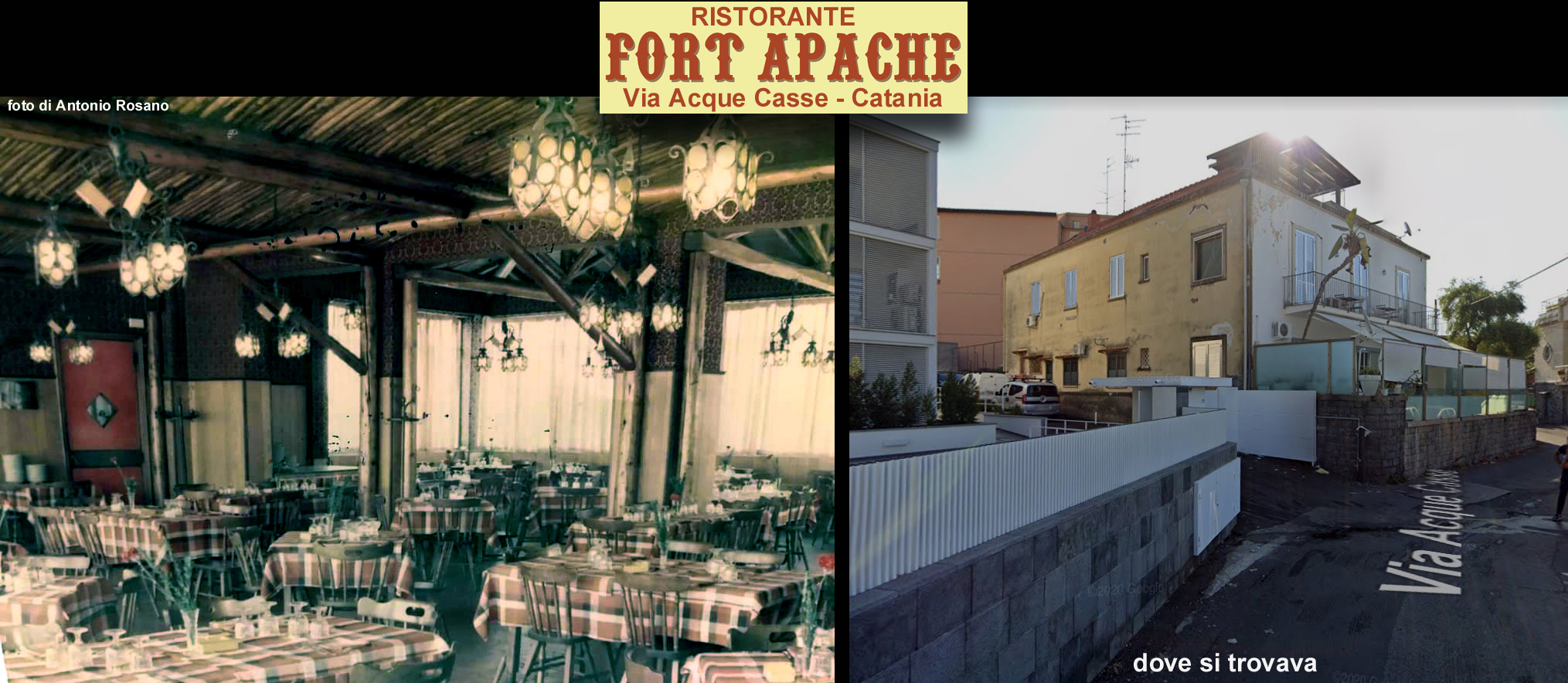

Storia non meno colorita e illustre ha il Baglio
del Cav. Vincenzo Tricomi. Attiguo alla dolceria dello stesso
Tricomi, il Baglio si apriva nella corte del palazzo Raddusa, con
ingresso su via Etnea 28.
Di lunghe radici (la sua nascita rimonta al
1828), visse stagioni più o meno fortunate, ma fu sempre all'altezza
di se stesso.
Accolse nel suo seno "la politica locale, le idee
di De Felice, gli epigrammi di Picardi, gli strali di Rapisardi, le
arrabbiature di Giovanni Milana, i sonetti di Nino Martoglio, le
palinodie di Gigi Placchi, l'enfasi di Vincenzo Saitta, i
dormiveglia di Salemi, le romanze di Giovanni Falsaperia, le
apparizioni di Mario Ciancio, i ditirambi di Corvaja. Caro a tutti,
era come un occhio di buona salute, arzillo e loquace ".
Era anche di poche pretese, il vecchio Baglio:
tre soldi mezza granita e un panino, due soldi un caffé, sei soldi
un gelato.
Le lire in giro erano poche a quei tempi, ma
troppe le mosche, specialmente d'estate, e il Baglio, d'estate,
viveva la sua pittoresca, romantica giornata!


Un giorno, il Caffé di don Vincenzo Tricomi
chiuse i battenti, e del Baglio non si parlò più per diversi anni.
Agli inizi degli anni Trenta, un uomo di grande
mestiere e di grandissimo cuore, Alessandro Caviezel, rilevò l'ex
Baglio, annessi e connessi, e nel solco della grande tradizione
dolciaria, già sperimentata in via Etnea 202, lo trasformò in un
raffinato ritrovo, dove non si parlò più di politica locale né più
si recitarono odi e ditirambi, ma si degustarono gelati e sorbetti,
preparati con materie di primissima qualità, come imponeva la
serietà, lo stile, la rinomanza della
Pasticceria Svizzera A. Caviezel e C.
La sede centrale si trovava in Via Etnea 200 e fu
aperta nel 1914. Vi erano poi la succursale in Via Etnea 32, tra
Piazza Duomo e Piazza Università, aperta dal 1927, e altre sedi a
Palazzo Bruca in Via Vittorio Emanuele 201 e al castello Mirone in
Corso Italia.
Per organizzare i propri ricevimenti, si
appoggiava a palazzo Bruca, palazzo del Toscano, villa Manganelli,
palazzo Biscari, ecc.
|


GLI
SVIZZERI A CATANIA
Gli
svizzeri Alessandro Caviezel e Ulrico Greuter
giunsero a
Catania nei primi del '900, dove aiutati economicamente dalla ditta
Fratelli Caflish, fondarono la Pasticceria Svizzera "A.
Caviezel & C." con sede in via Etnea.

Dopo
le prime difficoltà, comincio la espansione della produzione
svizzero-tedesco-austriaca ad opera di valenti pasticceri provenienti
da quelle nazioni. La
sede di via Etnea fu restaurata nel 1949 diventando punto di ritrovo
della migliore società catanese.
Ceralacca
rossa su un foglio bianco, una scritta sfumata a confondere un ricordo
d'infanzia... un'immagine, incontrata per caso, a stimolare un
riflesso di sapori e di ricordi lontani... vaghe sagome di un passato
che solo in parte mi appartiene tornato così a ricomporsi, come per
magia...
....l'albero
di Natale, sotto, una cesta colma di doni ... una scatola trasparente
profanata dalle mani di un bambino dentro cui compare una scritta
ancora poco leggibile: "cotognata"Caviezel"...
Mio
padre, ancora giovane, zii lontani, borselli in mano, maggiolini e
fiat 127 circolano per le strade di una città, di campagna, di paste
prese da Caviezel...
La
tv in bianco e nero, il volto di Mina, ancora reale, le sue canzoni,
...il campanile del borgo a ripassare le ore, lente e infinite ...e ti
accorgi che forse basta poco per colorare di ricordi l'infanzia fugace
ed effimera come tutte le cose destinate a cambiare o a sparire...
...così cambiò il volto di una città nobile, a diventare grigia,
violenta deserta...
...così
cambiarono le abitudini, fatte di fughe da un centro invivibile,
...così cambiarono i gusti ancora accecati da un ricordo stordito
dalla nostalgia per un epoca bella e confusa......così sparì
Caviezel...un giorno la città si sveglia torna il sole dopo una lunga
notte buia.
Timidi
ricordi fanno capolino e trovano spazi in angoli nuovi ed antichi che
mutano in progressive certezze......"è vero Catania vive"
par di sentire dire ai residui passeggeri già adulti all'epoca dei
miei ricordi d'infanzia, ...spazzati i resti grigi di anni bui e
deserti, l'orgoglio di chi ama la nostra città torna prepotente a
farla rivivere......infine una scatola trasparente a custodire il
profumo delle cotogne di Sicilia, ...un foglio di carta con la
ceralacca rossa,
...il
miracolo di un ricordo che si fa presente... ...odori, sapori unici,
l'insegna più nobile di una città che opera torna
a
brillare nel cuore dei catanesi... ...e sembra dire ...ben tornati a
Catania...ben tornato Caviezel...
Marcello
Gulisano 31/10/1998 (da caviezel.it)
da
Lucacaviezel.com

Ho
curato per oltre quarant'anni il settore produttivo della nostra
Pasticceria Svizzera, A.Caviezel & C. in Catania che contava nei
momenti di maggiore fioritura in laboratorio oltre 70 fra pasticcieri
e aiutanti. Tutta l'azienda, composta da tre pasticcerie ed un
ristorante, contava oltre 200 collaboratori.
Insegno
da oltre 30 anni nel settore della gelateria avendo iniziato
l'attività con Corsi professionali per gelatieri al Politecnico del
Commercio di Milano dove ho introdotto per la prima volta in Italia
per gelatieri artigiani la tecnica della formulazione delle ricette
attraverso il bilanciamento degli ingredienti.
Da
allora mi dedico alla formazione professionale per inizianti ed
all'aggiornamento continuo per gelatieri avanzati.
Ho
collaborato alla costituzione della Scuola Europea del Gelato presso
il CAPAC in Milano alla quale presto il mio contributo in qualità di
esperto. Insegno anche presso CAST ALIMENTI, sede della Accademia dei
Maestri Pasticcieri Italiani in Brescia, dove si svolgono in
particolare Corsi di specializzazione per pasticcieri e gelatieri
avanzati in occasione dei quali vengono rilasciati i Diplomi Master.
Dedico il mio tempo disponibile alla conduzione di brevi Corsi di
formazione, di aggiornamento e di specializzazione per gelatieri sia
in Italia che all'estero.
Collaboro
da anni con varie riviste del settore come "Il Gelato
Artigianale", "Pasticceria Internazionale" e "Bar
Giornale" e ho pubblicato due testi di base su "Scienza e
Tecnologia del Gelato Artigianale " e "Scienza e Tecnologia
del Semifreddo Artigianale", pubblicati da Chiriotti Editore di
Pinerolo.
Mi
sono stati assegnati numerosi premi e riconoscimenti tra i quali uno
dei primi "CONO D'ORO" dal Comitato Nazionale dei Gelatieri
Italiani, una MEDAGLIA D'ORO dalla Accademia dei Maestri Pasticcieri
Italiani quale "Riconoscimento per avere comunicato ed insegnato
l'arte del gelato artigianale in Italia e nel Mondo" ed una
MEDAGLIA D'ORO dalla Accademia della Gelateria Italiana e dalla
rivista Gelato Artigianale per "l'opera di didattica e diffusione
della cultura del gelato artigianale profusa nella crescita
professionale dei colleghi".
Ho
collaborato con l'Istituto della Enciclopedia Treccani in Roma per la
ricerca e la stesura di documentazione relativa alla storia del
gelato.
Il
lavoro mi apparteneva...parola di Luca Caviezel!
di Silvia Ventimiglia - 18 Febbraio
2013
La mattina dell'intervista sono andata, con lo spirito
della giovane/vecchia, per un viaggio nel passato ed ho trovato un
vecchio/giovane che mi ha portato a spasso per il presente ed il futuro.
Bella lezione per chi, come me, coniuga piu' spesso il passato di quanto sia
giusto e sano.
In una splendida mattina d' inverno, riscaldata da un
sole primaverile, raggiungo a San Gregorio casa Caviezel. Mi attende Luca,
classe 1923 (esattamente del 27 settembre), erede di quella grande famiglia
svizzera che ai catanesi ha fatto conoscere le delizie della pasticceria
mittleuropea e... non solo!
La A.CAVIEZEL PASTICCERIA SVIZZERA appartiene al Dna di
Catania come la Villa Bellini, il Liotru e non c'è persona che abbia
vissuto, tra il 1914 e il 1995, che non abbia interrotto le proprie
passeggiate lungo il salotto barocco di Catania, Via Etnea, facendo una
tappa che significasse goduria per il palato. Si trattasse di un cannolo, di
un semifreddo, di una fetta di Foresta nera e... finiamola qua altrimenti mi
sale la glicemia!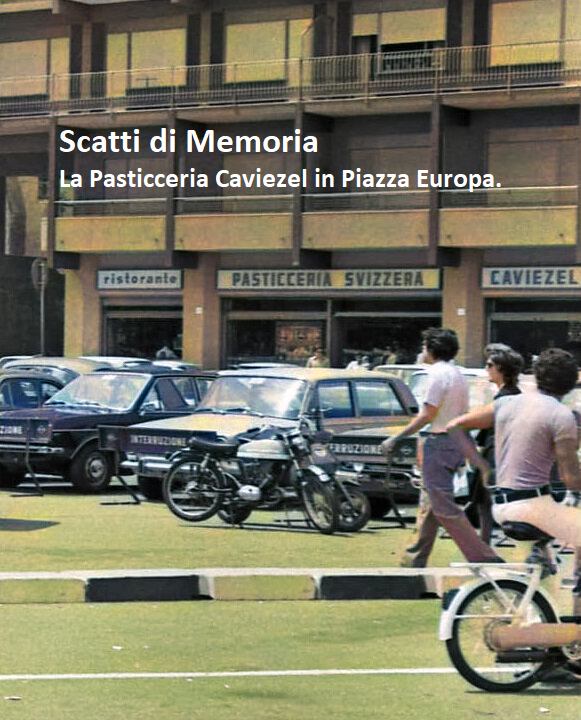
La simpatia per la persona, preceduta da un' ammirazione
sconfinata per quanto fatto da Lui e dalla Sua famiglia, si era rinsaldata
nella breve telefonata, complice il Suo pupillo Gianluca Mignemi, figlio di
Saretto, grande ristoratore catanese - “...Se non Le crea disagio, potremmo
vederci a casa mia. Non troverà nessuno, solo me... è giusto che lo sappia”.
Uomo d'altri tempi, Luca Caviezel, con un'attenzione ed
un rispetto che, al giorno d'oggi, è merce rara. Rarissima.
Spero di non averlo deluso nel momento che gli faccio
presente che non ho alcun problema ad aderire alla Sua richiesta. Anzi, ne
sono felice. In casa, da soli, potrò dare libero sfogo alla mia curiosità
senza disturbi o distrazioni.
Scende ad accogliermi al cancello ed una vigorosa stretta
di mano suggella l'avvenuta conoscenza. Giusto il tempo di dire due parole
di ringraziamento per il tempo che vorrà concedermi e passerò buona parte
della mattina ad ascoltare, ascoltare, ascoltare...dirò poco.
Pochissimo. Sarà Lui, da bravo nocchiero, a dirigere
l'intervista sul piano che piu' gli è congeniale. Quello del lavoro con
qualche puntatina nostalgica... di quelle che piacciono tanto a me.
Da subito saprò che molte delle informazioni in mio
possesso sono errate o incomplete.
“Vediamo di fare ordine...ragazza mia!”.
E qui comincia l'avventura, narrata con dovizia di
dettagli, alla faccia di una smemoratezza piu' dichiarata che reale.
Siamo alla fine dell'800 e dalla Svizzera, esattamente
dal confine con l'Austria...dal Cantone dei Grigioni... da Pitasch (110
abitanti in tutto), Alessandro Caviezel, padre di Luca ma anche di
Mario...Stefano...Anna Maria e Reto, decide di venire in Sicilia. Tra i
monti, laddove pascola il Suo bestiame, si è sparsa la voce che un tizio sta
andando a Palermo e così, date le condizioni precarie di tutte le famiglie
numerose, aggiungo io... in ogni latitudine, decide di imbarcarsi in
quest'avventura.
“Lì parliamo il romancio, la
quarta lingua ufficiale nazionale. Siamo circa 195.000 a parlare 'sta lingua
neoladina antichissima, studiata dai filologi”
Ne va orgoglioso...così come delle origini della Sua
famiglia che affonda radici nel lontano 1500. A tal proposito ricorda un Suo
omonimo, Lucas Caviezel, che ritroviamo nella Battaglia dei Giganti a
Marignano (oggi Melegnano...vicino Milano) del 1515”.
Gli svizzeri – aggiunge - sono stati
sempre soldati mercenari nelle piu' grandi battaglie in Europa”.
Ricorda che a Solferino, nel 1860, un tale ginevrino,
Henry Dunant, diede aiuto ai tantissimi giovani, di entrambe le fazioni, che
morivano dissanguati. Ritornando in Svizzera, Dunant – memore di ciò che
aveva vissuto – aveva fondato la Croce Rossa il cui stemma, per l'appunto, è
l'inverso della bandiera svizzera, croce rossa in campo bianco. Un popolo
attivo, quello svizzero, profondamente diverso da quello siciliano che,
tranne in occasione dei Vespri, non
.jpg) si è mai ribellato ed ha sempre
subìto...”Sissignori...vossaberenica” ...lo dice con tono partecipato e
divertito. si è mai ribellato ed ha sempre
subìto...”Sissignori...vossaberenica” ...lo dice con tono partecipato e
divertito.
E' un fiume in piena, il Maestro Caviezel! E continuando,
si sofferma sulla Costituzione federale del 1291 che riuniva i 3 Cantoni e,
per completare l'informazione, fa il segno con le tre dita che oggi ha il
significato di “Vittoria” e che, invece, è sempre stato il tratto distintivo
delle Guardie svizzere che, famose nel mondo, tutelano - tra l'altro -
l'incolumità del Santo Padre.
Preso un vecchio testo, mi chiede di leggerne qualche
riga. Ascolta commosso e con sentimenti di profonda partecipazione.
“Il segreto della Svizzera?...si chiede a
voce alta... il rispetto che ha sempre avuto per le minoranze! Ventisei
piccole repubbliche... ognuna con il proprio governo e laddove, specifica,
quest'ultimo non può essere italicamente ladro in quanto è tenuto, con
periodicità, a dar conto delle spese e delle entrate. Là non esistono gli
onorevoli ma i semplici deputati. Bossi – aggiunge orgoglioso – dovrebbe
imparare dalla Confederazione elvetica!”
Lo interrompo... Ma perchè se in Svizzera si sta così
bene, i Caviezel sono emigrati in Sicilia?
Ritorna ai ricordi del padre....del Suo essere
contadino...dell'appartenenza ad una famiglia numerosa.
“Venne qui in Sicilia per necessità, come
succede a tutti gli emigranti”.
Prima ancora di soffermarsi sull'arrivo, ama raccontare
della Sua patria che, sottolinea..
“non era patria di pasticceri
come, erroneamente, si pensa ma di contadini la cui cultura, come quella dei
marinai, impone di fare fronte comune contro la forza della natura. Gli
svizzeri non hanno mai avuto grandi risorse né oro nè argento...solo tanta
erba. Erano contadini. Oggi la situazione è diversa...ma tutto ciò che
sappiamo l'abbiamo imparato da altri. L'arte di lavorare il cioccolato, ad
esempio, l'abbiamo imparata a Torino. Fu il Signor Cahier ad andare,
imparare e tornare in patria.
A proposito, aspittassi...”
e torna sui suoi passi con un magnifico pacco di
cioccolatini svizzeri al cui richiamo non mi sottrarrò. No, di certo!
La simpatia aumenta man mano che parla ed alterna i
classici E DUNQUE...da DONC... derivanti dalla familiarità con la lingua
francese...con i sicilianissimi CCA SEMU! Un catanese mittleuropeo, non c'è
che dire!.jpg)
Continua...“Mio padre partì a 15
anni, nel 1900, con un paio di scarpe e due paia di calze. A peri,
naturalmente...non aveva manco u cavaddu. Passò il Reno e, via via, la
Foresta Nera. Fu in quell'occasione che vide, per la prima volta, una
locomotiva...impiegò 3 giorni per arrivare a Palermo meta di tanti, dopo la
fuga dei Borboni. A quel tempo, la Sicilia era amata per la sua
bellezza...era la patria degli aranci...veniva decantata da Goethe per la
Sua magnificenza e qui comincia a citare, con enfasi partecipata,
qualche verso in tedesco.
L'influenza degli Arabi, poi, aveva
lasciato traccia anche nel...gelato. Ne furono Loro gli inventori!”
Ma come...dico meravigliata ...non furono i Caviezel????
“No...e sorride. Il gelato l'hanno
inventato gli Arabi solo che da Loro era una sorta di bevanda, il sherbet.
In Sicilia è diventato pastoso. Per opera di chi, nonostante varie ricerche,
ancora non si sa con esattezza....Anche la cultura gastronomica, qui, è
frutto di varie influenze, poi elaborate, che hanno dato vita a prodotti di
stile...unico. E lo dice con tono convinto e trionfale!
Tornando a mio padre, siccome era
piccolino di statura ma anche di età, lo soprannominarono “Il piccoletto” e
lo misero a pulire vetrine. A poco a poco, andò avanti. A Palermo, già dal
1870 c'era la Pasticceria Caflish (puntualizza che non trattasi della
stessa famiglia che a Catania ebbe fortuna con i tessuti e con i casalinghi)
che continuava a chiamare svizzeri a lavorare giu'.
Mio padre, che faceva coppia con Ulrico Greuter, ad un certo punto, aveva
pensato di andare in Transval alla ricerca di petite d'oro ma fu subito
persuaso dall'amico che lo convinse a rimanere, quantomeno, in Sicilia e
dopo un viaggio in lungo e largo per l'isola...l'approdo definitivo a
Catania. E sa perchè? Perchè durante una visita, mio padre notò, in un
locale, un cameriere addormentato durante l'orario di lavoro e da un'altra
parte, vetrine sporche e con qualche mosca morta”. Pensò bene, pertanto, di
apportare giuste modifiche a quell'andazzo.
Immagino l'orrore provato da uno svizzero davanti
all'approssimazione che, talvolta, contraddistingue noi catanesi.
Insomma, come fu o come non fu,
Alessandro Caviezel ed il Suo amico Greuter decisero di stabilirsi a
Catania...che Dio Li abbia in gloria!
“Il problema erano i soldi...Allora il
consolato era retto da Vittorio Caflish (questo sì della famiglia nota a
Catania per i tessuti e per i casalinghi)che lo invogliò a fare società con
Lui. Lui avrebbe messo il 50%, mio padre ed il Suo amico il restante 50%.
Partivano in quinta, avendo una banca privata alle spalle... proprio il
Banco Caflish che aveva sede in Via Biondi 8 “ nelle cui vicinanze
(esattamente in Via Recalcaccia)...molti anni dopo – aggiungo io –
esattamente nel 1970, trovò la morte Giovanni Caflish vittima della prima
rapina eclatante avvenuta nella nostra città.
Appena alzata la saracinesca della
PASTICCERIA SVIZZERA, sita nella principale Via Etnea di fronte a dove oggi
si trova La Rinascente, mio padre pensò bene di allestire, al primo piano
laddove ci furono – piu' avanti - gli uffici e l'amministrazione
dell'azienda, una foresteria per dare alloggio ai tanti pasticceri che, man
mano, chiamò a lavorare a Catania.
Ricordo Oscar Werthmann che aveva baffi
lunghi di 'sta manera...e accompagna le parole con un buffo
gesto...svizzeri, austriaci, tedeschi, ungheresi e ciò a riprova che noi
Caviezel abbiamo il merito di aver portato la pasticceria mittleuropea a
Catania...in Sicilia.”
So che avete portato la crema al burro e la panna...
“ Si è vero...prima del burro esisteva
solo la saimi...come si dice...la sugna, insomma. La panna, poi, era
appannaggio solo dei nobili e l'avevano portata i francesi. Fino ad allora
era prodotta per affioramento e non per centrifuga. Aveva un tenore di
grasso intorno al 28% e non si montava bene. I monsù francesi avevano,
giustamente, cercato di alleggerirla con l'aggiunta di meringa per darle
corpo. Successivamente, la panna fu portata al 35% di grassi e centrifugata.
La centrifuga nacque verso la fine dell'800...”.
E mentre la mia mente annega in un mare di dolce
panna...aggiunge “ Un buon latte pastorizzato a
Catania l'abbiamo portato noi Caviezel. Anzi, negli anni '50, avevamo
installato addirittura una piccola centrale e vendevamo latte e panna anche
ai nostri colleghi in bottiglie da un quarto”. L'utilizzo del termine
colleghi anzichè concorrenti che ritroveremo anche piu' avanti...
.jpg)
Mi dice che l'anima catanesissima, per certi versi, sia
rimasta fortemente svizzera.
“Avevamo comperato un bel
pastorizzatore...la panna arrivava quasi al 4% di grassi. Avevamo dei
fornitori straordinari. Anche qui si sofferma, come dicevo prima, su
collaboratori e fornitori...volendo accomunare tutti nella formula che ha
reso vincente la loro pasticceria a Catania. Ricordo Iugulano che stava alla
Piana. Mio padre, che era rimasto contadino, ogni domenica visitava
vaccherie e stalle dando consigli anche sul colore delle pareti che doveva
essere azzurro per evitare le mosche... l'abbeveratoio disinfettato
costantemente e costruito in modo tale che il bestiame potesse anche pulirsi
gli zoccoli”.
Sull'onda dei Suoi ricordi, cerco di inserire quelli che
mi ha trasmesso il grande scrittore Aldo Motta...non tutti sanno che, a fine
giornata ad esempio, chiusa la saracinesca si svolgeva all'interno della
pasticceria un rituale concertino animato dai lavoranti e i cui suoni
venivano fuori da piatti, forchette, bicchieri. Luca Caviezel si commuove
per la prima volta anche se, subito dopo, non riesce a ricordare la foto del
Catania davanti alla quale campeggiava un mazzo di prezzemolo anziché un
mazzo di fiori considerato di presagio funesto...”.
Sorride a questi ricordi ed anzi, galvanizzato dalle
buone notizie circa la salute di Aldo che Gli trasmetto con gioia, mi fa
partecipe di un progetto in cui vorrebbe coinvolgerLo. Una riedizione di un
libro scritto da piu' di 25 anni e che abbisogna di una rivisitazione.
“E' pezzo da Museo, ormai!” aggiunge. Lui, il Maestro Caviezel –
aggiungo io – ne ha scritti tanti di libri e tutti considerati, a livello
mondiale, Bibbia del settore.
Proseguiamo con i ricordi...

”La Pasticceria Caviezel, nata come sede
unica in Via Etnea, nel tempo si sdoppiò ed aprimmo la cosiddetta succursale
vicino Piazza Università, dove c'era il famoso bagghiu di Tricomi, un
cortile interno dove posizionammo dei tavolini con 4 camerieri in frac.
Infine, fu la volta di Piazza Europa . L' avventura crebbe e si affievolì
contemporaneamente... da 205 dipendenti si passò a 72 ed infine ad 8”.
Cosa accadde?
“La colpa fu dei sindacati, non c'è
dubbio.”
Si avverte che la questione bruci ancora. A partire da
quell'ingratitudine che ha scoperto nelle nuove generazioni dei Suoi
collaboratori tanto che ricorda di un tafferuglio tra la vecchia guardia
(solidale con la famiglia) e la nuova che portò a chiudere la pasticceria
per qualche giorno, nel momento caldo della querelle, per ragioni di ordine
pubblico. Ricorda che Lui i lavoranti li mandava ad imparare, a proprie
spese, all'estero... per formarli e mantenere alto lo standard qualitativo.
Non si spiega proprio quel voltafaccia che procurò immenso dolore alla
sorella Anna Maria e soprattutto al fratello Mario che, unendo ciò alle
traversie della Sua vita, si chiuse in un silenzio dal quale non è mai piu'
uscito fino alla morte.
Luca Caviezel ricorda anche di un collaboratore della
Loro Amministrazione, un tale ragioniere, che financo morì di crepacuore.
Non riesce proprio a capire. Qualche errore certamente, da parte Loro, ci
sarà stato. Il fatto, ad esempio, di far fare sempre la stessa cosa a
ciascuno dei Suoi lavoranti che rispondeva all'esigenza di proporre sempre
gli stessi prodotti, così come amati e richiesti dalla clientela,
probabilmente tarpò le ali ad alcuni di Loro che, dovendo trovare lavoro
altrove, non erano in grado che di proporsi solo per quello che sapevano
fare e non per altro.
Vedo che il tono si fa sofferente per cui riporto la
discussione sul passato piu' remoto rispetto a quello dove ci stiamo
soffermando.
Abbiamo ricordato Suo padre...mi parli di Lei, ora!
“Nella mia famiglia si parlava il
romancio, come Le dicevo. La mia prima lingua estera fu il SICILIANO...non
l'italiano, è vero? Abitavamo in Via Roccaromana dove mio padre desiderava
che frequentassimo i ragazzi dda strata, che imparassimo ad ittari petre...Noi
Caviezel abbiamo voluto integrarci con la gente di qui mentre gli altri
svizzeri si sono sempre mantenuti distanti e non solo con i catanesi...anche
con i connazionali. Poi, dopo il siciliano imparammo... l'italiano.
Ultimate le scuole superiori a Catania,
io ed i miei fratelli, Stefano e Mario, partimmo per la Svizzera dove –
secondo i nostri progetti - avremmo dovuto proseguire gli studi nelle scuole
tecniche.
Allo sbarco degli alleati in Sicilia, nel
luglio del '43, eravamo già lì e per ben 3/4 anni non sapemmo nulla dei
nostri genitori e del resto della famiglia rimasta a Catania. Una volta, per
la verità riuscì a comunicare attraverso una radio a Berna. Io parlai ma non
seppi mai se mie notizie erano arrivate a destinazione e, comunque, non
seppi niente di chi era rimasto e in quali condizioni. Con i miei fratelli
dovemmo interrompere gli studi e metterci a lavorare. Io cominciai in una
fabbrica di marmellate. Furono anni difficili. Ricordo che in pensione, la
domenica, non avevamo nulla da mangiare...periodo terribile. Come per tanti,
comunque. Ma avevamo un futuro davanti...c'era il desiderio di tornare. Qui
era casa nostra! E finalmente, nel '46, potemmo tornare e trovammo il resto
della famiglia. A noi era andata bene!”
 Ma
Lei si considera piu' svizzero o catanese? Ma
Lei si considera piu' svizzero o catanese?
“Ma guardi, professionalmente,
sono catanese marca...elefante! La professione l'ho imparata qui. E'
l'impostazione...ad essere svizzera. Quelli come me tendono sempre a
migliorarsi e a sperimentare. Io sono stato il primo a Catania...in
Sicilia...in Italia...vabbè, lo ammetto, al mondo ad aver creato il
“bilanciamento degli ingredienti”, nel campo della gelateria ed è frutto
degli insegnamenti dei tecnologi alimentari. Frutto degli insegnamenti
americani ma portato qui, applicato e reinterpretato”.
Lei è un bravissimo pianista (“discreto” mi
corregge)...il riuscire a creare melodie, suoni... l'ha aiutata anche
nell'amalgama degli ingredienti?
Guardi, dalla musica alla gelateria, ho
cercato sempre di portare, come dire, ordine...Prima il gelato, ad esempio,
si faceva a muzzo...ad occhio”
Insomma, Lei ha applicato il rigore svizzero in
gelateria...
“Di piu'...ho fatto mio il metodo
dell'americano Arboucle che ha trovato la maniera di esprimere la qualità di
un prodotto in gelateria attraverso le cifre, i numeri. Un fatto
estremamente interessante. In tutti gli altri settori alimentari non esiste
'sta cosa. In pasticceria, un certo Santiago Peres – spagnolo – ha cercato
di trasmetterlo senza riuscirci. Non è facile. Con questo sistema, questo
bilanciamento, abbiamo la possibilità di avere dati certi,
scritti...insomma, 2+2 fa 4 non 22, non è vero? Io posso dare valore di
certezza a quanto faccio”.
Ma questo non toglie spazio alla fantasia...al cuore?
“No, quello è fondamentale! Noi, con
questa teoria, abbiamo una panoramica scritta. La fantasia, l'estro,
l'assorbimento delle influenze ambientali fa tutto il resto. Fa la
differenza, insomma”.
A questo punto, smonta ad una ad una certezze che avevo
ricavato da internet. Gradisco la sincerità del mio interlocutore ma non
nego di aver provato una piccola delusione. Mi ritrovo a sottoporLo ad un
interrogatorio incessante. Domanda e risposta senza soluzione di continuità.
E' Lei l'inventore del cono, gelato da passeggio, nato
proprio per permettere di godere delle bellezze del barocco e, nel
frattempo, gustare le Sue specialità?
“No! E' leggenda...”
Primo colpo al cuore...il mio, naturalmente. E' Lei
l'inventore del gelato con lo stecco...del famoso pinguino?
“No...ma chi gliel'ha dette 'ste cose?
Noi lo facevamo, questo sì, ma usavamo forme che compravamo da Caflish alla
Marina. E se esistevano le forme vuol dire che qualcun altro aveva già
pensato di farlo o no?”
E certo...secondo colpo al cuore. Sempre il mio. E' Lei
l'inventore del famoso Pezzo duro?
“No, fa parte della ricca e barocca
tradizione italiana. Quale Italiana.... SICILIANA. Insieme agli schiumoni,
ai cannoli gelato...”
Colpita ed affondata...certezze che si sgretolano.
Vincono la verità e l'umiltà del mio interlocutore.
“Noi, quello sì, abbiamo portato –
attraverso tutti i lavoranti provenienti da svariati Paesi europei – le
novità che allora, in mancanza di comunicazioni, non sarebbero arrivate. Noi
abbiamo “rubato” dalla cultura parigina e viennese i segreti dell'alta
pasticceria...l'abbiamo rivisitata alla luce della tradizione siciliana.
Questo sì...se questo è inventare...sì... siamo gli inventori.
Ecco, fine della sanguinazione...del mio cuore,
ovviamente!
“Si...la PASTICCERIA SVIZZERA si ascrive
questo...Ma sa che, per un certo periodo, abbiamo dovuto togliere la scritta
dall'insegna? Fu quando Mussolini passò davanti al nostro locale, io Lo
ricordo benissimo. Allora, la Svizzera aveva sottoscritto le sanzioni contro
l'Italia per aver attaccato l'Abissinia e, quindi, iddu pensò bene di farci
togliere la dicitura che riportava alla provenienza geografica”.
Ricordo ancora la carta della Loro
pasticceria e Glielo faccio presente con un pizzico di nostalgia. Si alza e
prende un foglio uguale uguale...sopra c'è scritto Daidone. Mi racconta che
Nuccio Daidone, grande amico Suo ed ottimo pasticcere, l'ha copiata pari
pari quella grafica che, tra l'altro, quella sì (evvivaaaaaaaaaaaaaa) è
opera Sua...con i colori, i richiami alla ceralacca. Inconfondibile!
Maestro...qual è secondo Lei il dolce principe siciliano?
“Il cannolo di ricotta, non c'è dubbio. Non quello alla cioccolata...quello
alla ricotta.”
Il mio viso si veste di un sorriso complice...
E lo dice a me?????
Ritrovo le mie corde, perse strada facendo immersa in
visioni di panne, creme, gelati... Il Vostro era il luogo preferito
dall'aristocrazia, dai grandi proprietari terrieri, dagli industriali...la
dirimpettaia BIRRARIA (si,proprio birraria con la A da birra...così si
chiamava ai tempi) LORENTI era il luogo dove si ritrovava l'intellighentia
cittadina che aveva possibilità di chiacchierare a quei tavolini di cui Voi,
invece, eravaTe sprovvisti... almeno nella sede centrale.
Il ceto medio basso transitava e basta, lungo la Via
Etnea, inseguendo le proprie occupazioni... Quale personaggio L'ha colpita
maggiormente?
“Guardi, ricordo benissimo Scelba. Ma
anche Brancati...il futuro Presidente della Repubblica,De Nicola, il poeta
Villaroel che scriveva versi su ogni pezzo di carta che trovava e... tanti
altri”.
Aggiungo io che era l'epoca anche dei famosi arancini di
GIARDINI...
“Sa perchè erano così buoni?” aggiunge
“Perchè Lui era un salumiere e pensò bene di aggiungere, all'interno delle
piramidi di riso, cozzi di salumi residuali, macinandoli...”
Maestro, l'anno prossimo saranno 100 anni
dall'apertura della A.CAVIEZEL PASTICCERIA SVIZZERA, esattamente il 25
dicembre del 2014. Come pensaTe di celebrare questa data?
Cambia un po' espressione e riprende quella pensierosa di
quando parlava dell'ingratitudine di certi lavoranti
“Guardi, noi abbiamo affrontato
vari passaggi nella gestione dell'azienda. Con mio fratello Mario ci
rincuoravamo...passerà...ce ne sono stati di momenti brutti...Si figuri, un
giorno dovevo andare ad un corso a Madrid e dovetti annullare il viaggio
perchè, nel giro di 15 giorni, abbiamo dovuto consegnare i locali a chi è
subentrato. Abbiamo dovuto svendere l'azienda e siamo rimasti a zero. Io
vivo di pensione e mi sta bene ma di festeggiare c'è poco, per la verità.
Noi siamo stati aggrediti dai sindacati senza alcuna possibilità di reagire.
Rivendicazioni su rivendicazioni...Ogni sabato un'assemblea...Alla fine, non
c'era piu' quel piacere al lavoro che ci aveva animati sin dagli esordi.
E sono stati parecchi gli anni difficili... 15/20...non
pochi, è vero?
Abbiamo ricevuto molto, è indubbio, ma
abbiamo dato tanto quanto... se non di piu'. C'è molta amarezza e, pertanto,
non c'è voglia di celebrare un bel niente. Non volevamo arricchirci ed
infatti non ci siamo arricchiti ma Catania non ci ha protetto...nè la città,
nè i politici...nessuno.
Sento spesso parlare di
lavoratori...sacrosanto. Ma chi pensa ai datori di lavoro?
Il lavoro chi lo crea... se non il datore
di lavoro?Mio padre ha cominciato dal nulla...ha creato una bellissima
azienda...ha avuto con i propri collaboratori un rapporto quasi familiare ed
il risultato quale è stato? La nostra azienda, alla fine, non poteva piu'
andare avanti ed è stato un peccato. Nell'immaginario collettivo i Caviezel
sono una famiglia ricchissima...pensi la gente quello che vuole. Non è così!
L'agonia è stata prolungata, poi, con il
mantenere vivo il settore ricevimenti, di cui si occupava mio fratello Reto,
ed infine con l'apertura, insieme a mio figlio, di IGLOO in Via Raffaello
Sanzio, punto vendita aperto nell'80 e chiuso dopo 8 anni... 14 rapine e 2
richieste estortive. Ho rimesso centinaia di milioni e vabbè...
I guai cominciarono con i
sindacati...dovrebbero star fuori dalla politica! Pensi - ad esempio - che
ad certo punto, dovemmo pagare una multa di 6 milioni e sa perchè? Due volte
a settimana, i nostri lavoranti seguivano dei corsi in pasticceria e lo
facevano facoltativamente.
Ciò che elaboravano o veniva buttato
oppure su puttavano a casa...certo non li pagavamo per questo. Erano dei
corsi e per giunta facoltativi. Morale della favola...fu considerato lavoro
non retribuito...non formazione. Da qui la multa che, per quei tempi, erano
soldi!

Sono stati i sindacati a rovinarci e non
solo a noi. Pensi ai Dagnino ed ai Caflish a Palermo, agli Irrera a Messina
per poi finire alla Motta ed alla Alemagna...queste erano aziende che
assumevano, per il periodo natalizio, ben 3000 persone per 4 mesi. No,
secondo i sindacati, dovevano assumere per 14 mesi (compresa tredicesima e
quattordicesima)! Non andava bene così... Ma, insomma, come avrebbero potuto
sostenere queste spese aziende che lavoravano, soprattutto, in quel
periodo?”
Come datore di lavoro non sente di aver commesso errori?
“Chi non ne commette?... ma rivendico la
buonafede. Ho licenziato ma ho anche riassunto. A volte l'atmosfera di
rivendicazione faziosa era talmente pesante che, per poter continuare a
lavorare con un minimo di serenità, ho dovuto licenziare. Ma il rapporto con
i miei lavoranti è sempre stato amichevole tanto che, anche a distanza di
tempo, ci sentiamo. Passo ricette, quando me le chiedono, li aiuto a cercare
lavoro se occorre...Insomma, non penso di essere considerato un despota o
che Loro non conservino un buon ricordo di me sia come persona che come
datore di lavoro”.
Vorrei alleggerire l'atmosfera...mi danno con me stessa
per aver portato l'argomento su questo piano. Mi soccorre il sorriso
sornione di Aldo Motta con la Sua domanda ricorrente.”Ti raccomando,
chiediglielo!” aveva insistito..
Maestro, perchè le pizzette furono aumentate, da un
giorno all'altro, da 25 a 40 lire?
“Chissacciu...su riorda sulu iddu!”
Sorride e mi svela, pressato, il segreto delle famose
pizzette mai piu' eguagliate...
“Vede, se lei chiede ad un panettiere di
fare un dolce lo farà con la Sua mentalità di panettiere. Se ad un
pasticcere chiede di fare il pane, prima o poi ci lassa currere un uovo...è
vero? Noi avevamo dei pasticceri che prestati alla piccanteria...applicarono
la Loro mentalità da pasticceri. Innanzitutto, l'impasto...poi la doppia
lievitazione...tre diversi tipi di formaggio di primissima qualità, anche
svizzero al posto della solita mozzarella”.
Mi ritrovo a volermi chiarire circa le ipotetiche origini
ebree della famiglia Caviezel...
“No, assolutamente. Siamo di Chiesa
evangelica protestante. Chiesa valdese nata, prima della riforma luterana,
nel 1200. Pietro Valdo, un contemporaneo di San Francesco, lasciò la
famiglia ed andò a vivere in Francia per poi tornare nelle valli valdesi, in
Piemonte. Quelle le nostre origini religiose”.
Esiste ancora una comunità svizzera a Catania?
“Certo ma ci sono piu' italiani che
svizzeri. Prima, al limite, c'era qualche tedesco o austriaco...oggi tanti
sono figli di svizzere piu' che di svizzeri. Insomma, la comunità si è
allargata”.
Maestro, mi ricorda che Catania era quella dei Suoi
tempi?
“Ma vede, La deluderò...lo so. Ma io
stavo per la maggior parte del tempo, dietro...in laboratorio. Non facevo
pubbliche relazioni. Forse ha sbagliato il Caviezel da intervistare. Quando
non ero in laboratorio ero in giro per il mondo...sono stato fino in
Giappone. E sempre per lavoro. Com'era Catania? Spensierata. Direi...senza
pinseri...ottimista”.
Lo dice con un sorriso agrodolce...
Oggi, come tutta la Sicilia, rimane polo di attrazione...una terra fuori
dagli schemi. Una nazione a parte ed io mi sento di appartenere,
profondamente, a questa nazione”.
Mai pensato di tornare in Svizzera?
“L'abbiamo pensato, qualche volta, ma il
nostro centro affettivo era qui. E poi non eravamo piu' i contadini che
eravamo partiti da quei luoghi...non avevamo piu' dimistichezza con quel
tipo di vita”.
Suona il telefono, si alza di scatto come se le 90
primavere non avessero intaccato né la mente, come ha dimostrato ampiamente
in 3 ore di quasi soliloquio, né le articolazioni.
“Cu è?” risponde allegro e tale rimane per tutto il tempo
della breve conversazione. Ritorna accanto a me e continua a chiacchierare.
Lei ha figli...com'è che non ha pensato di passare il
testimone per far sì che il patrimonio di esperienza acquisita non andasse
perduto?
“Vede. I miei figli stanno in
Svizzera...fanno altro. Che futuro avrebbero potuto avere qui? Mio figlio
s'imbarcò con me nell'ultima esperienza, quella di IGLOO come Le raccontavo
ma poi...sinni scappau. Non c'erano le condizioni per poter lavorare in
santa pace. Lì, in Svizzera, c'è un'efficienza che, purtroppo, qui da noi
non c'è!”.
E lo dice con rammarico...da catanese per scelta.
“Per quanto riguarda l'eredità
professionale, sappia che scrivo libri e tengo corsi per trasmettere quella
che è la mia arte nel campo della gelateria. Ci sono bravi gelatieri, mi
creda. Devono, però, convincersi che sono Loro i nocchieri della barca...non
i produttori di macchine da gelato o di prodotti lavorati. Ana accumannare
iddi perchè non vada disperso tutto il patrimonio accumulato. In primis, non
bisogna transigere sulle materie prime. Devono essere di eccellenza sia in
termini di qualità che di quantità e bisogna specializzarsi”.
Una curiosità, Maestro...ma Lei che preferenze ha in
fatto di gastronomia e di gelateria?
“Guardi, se è vero che uno è quello che
mangia...La deluderò! Io non sono goloso. Oggi, addirittura, mangio
esclusivamente le cose surgelate di cui è pieno il mio frigo e che mi
prepara me figghia quando scende a Catania. Bevo un litro e mezzo di latte,
quello sì...e amo le uova. Mangiarle ed usarle nelle mie ricette. Ci pensi,
l'uovo è legante...montante...strutturante...emozionante”.
Sembra di assistere ad una dichiarazione d'amore in piena
regola...
”Oggi viene usato poco, sostituito da
schifezze ed è un vero peccato! Dico io...mittiti l'ovo e putiti togghiere
tuttu u restu. Anche il gelato, nato dall'acqua e dallo zucchero, ha fatto
il suo salto di qualità quando ci si abbiò l'uovo”
E qui mi parla e si dilunga sul sito che cura per dare un
freno alla brutta piega che sta prendendo il mondo del gelato.
“ Oggi viviamo di mediocrità e
standardizzazione...c'è poco spazio per quell'eccellenza che prima la faceva
da padrona!”
Mi scandisce chiaramente l'indirizzo
G E L A T I E R I
P E R I L G E L A T O. COM e m'invita a visitarlo. Ha ancora uno scopo
nella vita, il grande Luca Caviezel, quello di tutelare e salvaguardare il
ricco patrimonio siciliano che spazia dagli schiumoni ai pezzi duri passando
per i cannoli gelato. Mi chiedo...e dovevamo aspettare uno svizzero per
questo? Eppure così è e mi sento di ringraziarlo di cuore!
In tema di ringraziamenti, il Maestro Caviezel sente di
voler doverosamente ringraziare l'ex Sindaco di Catania, Senatore Enzo
Bianco. Non ricorda esattamente l'anno ma, di certo c'era ancora la
lira...sarà stato l'89. Nel Suo lungo peregrinare in giro per l'Europa,
Caviezel aveva notato come, dappertutto, ci fossero scuole del gelato tranne
a Catania che ne era la patria.
Decise di sottoporre la questione al Primo Cittadino che,
entusiasta dell'idea, Gli aveva accordato fiducia e...fondi. Ben 300 milioni
di lire. Bene, da allora, Catania ha una sua SCUOLA DEL GELATO che, nata
presso i salesiani di Via Teatro Greco, si è definitivamente trasferita -
godendo di ottima salute - presso l'Istituto San Filippo Neri di Via
Vincenzo Giuffrida, con un numero annuo di allievi che si aggira sulle venti
unità.
Una vita lunga...che bilancio è il Suo?
“Ho fatto quello che ho voluto, secondo
gli insegnamenti di mio padre. Sono sempre stato portato nel dare piuttosto
che nel ricevere. Anche per i corsi che ho tenuto, e tengo, ho chiesto
quello che mi sembrava e mi sembra giusto...una piccola parte di quello che
altri pretendono.
Non ho saputo arricchirmi. Non ho voluto
arricchirmi. Mio padre ci ha insegnato che ognuno di noi ha un compito, che
deve fare qualcosa per gli altri. Questo è stato il faro della mia vita. Non
sono scontento, onestamente. Certamente una cosa di cui mi rammarico è il
poco tempo dedicato alla famiglia. Io lavoravo anche la domenica. Non ho mai
accompagnato sull'Etna mio figlio a sciare, ad esempio, e questo mi spiace.
Il lavoro... mi apparteneva!
Verso le 12.30 chiudo l'agenda con gli appunti presi...
”Già sinni va...mi chieda qualche altra
cosa, no?” Lo accontento...i cosiddetti
beneinformati pronunciano il Vostro cognome CAFIZEL...hanno ragione?
“No! La pronuncia corretta è proprio
CAVIEZEL e sa che significa? Ca, come a Venezia, sta per Casa. Il nostro
cognome significa Quelli della casa di Viezel laddove è questo il termine
con cui si indica un albero, un ciliegio selvatico, che ha dimora tra i
nostri amati monti....come Caflish significa Quelli della casa di Flish...Canova
Quelli della casa nuova...Casùt, quelli della casa di sotto e così via.
Mi ricordo di un dubbio che vorrei
chiarirmi anche perchè la fonte dalla quale ho attinto si è dimostrata
inattendibile. In questo ed in tanto altro.
Fu il pasticcere Amato, lo stesso della
famiglia coinvolta nel caso del “bambino incendiato”, ad inventare la Torta
Savoia in occasione della visita della famiglia reale a Catania?
“Ma no!!!!!Fu un tedesco a crearla, Oscar
Werthmann, e lo fece sì in occasione della visita dei reali ma a... Palermo.
Che c'entra Catania? Solo dopo, Oscar, venne qui a lavorare – come primo
pasticcere da noi – e a Catania morì. Fu Lui a creare quel capolavoro di
pasticceria che consiste in 3/4 strati di Pan di Spagna molto sottile con su
spalmata la gianduia, in quantità sempre maggiore.
Niente, con l'acquolina in bocca, sento che è tempo di
andare e, stavolta, sistemo l'agenda ed il registratore in borsa.
Prima di lasciare la casa, Gli trasferisco innanzitutto
gli innumerevoli “Grazie di cuore” di cui sono ambasciatrice...uno per tutti
quello del mio fraterno amico Alessio Bonaccorsi che, trasferitosi – decenni
fa - in Emilia Romagna dopo la laurea, ci tiene a farGli sapere che i
ricordi della Sua giovinezza sono legati a doppio nodo ai Caviezel ed,
infine, chiedo di poter avere alcuni rametti di una pianta grassa che è
stata testimone muta della nostra chiacchierata. Acconsente con piacere.
La pianterò a ricordo di questo incontro tra chi ha avuto
voglia di raccontare e chi di ascoltare.
Attecchirà lo sento e la chiamerò... Memoria.
Si...Memoria, quel patrimonio collettivo, unico ed imprescindibile da
tutelare, conservare e trasmettere.
La vigorosa stretta di mano, che fa calare il sipario
sulla bellissima mattinata, si traduce in un impalpabile..sentito e
reciproco GRAZIE!!!!
http://blog.siciliansecrets.it/2014/08/29/il-lavoro-mi-apparteneva-parola-di-luca-caviezel/
.jpg)
La Sicilia 28.1.2014
Il maestro pasticcere Lucas Caviezel, svizzero di
nascita e portabandiera della pasticceria siciliana, ha ricevuto ieri a
Palazzo degli Elefanti la cittadinanza onoraria di Catania, la prima
assegnata dal sindaco Bianco dal suo insediamento. «Attribuire a Caviezel la cittadinanza onoraria - ha detto Bianco - è uno dei momenti
più importanti della sindacatura. E' con vero gratitudine che la assegno
a un uomo che ha saputo con impegno straordinario incentivare la
tradizione della pasticceria e della gelateria in particolare e che,
ancora oggi non più giovanissimo, trasmette i suoi saperi ai più giovani
offrendo loro una preziosa opportunità». Nato e cresciuto in Svizzera,
sin dal secondo dopoguerra il maestro Caviezel ha saputo rilanciare in
particolare la gelateria. «Per il lustro che Lucas Caviezel ha saputo
dare a Catania in questi decenni, l'Amministrazione comunale ritiene di
dovergli conferire, in segno di stima e apprezzamento, la cittadinanza
onoraria del Comune», si legge nella pergamena. Caviezel - ieri
accompagnato dal presidente dell'associazione di categoria Ducezio,
Salvatore Farina, e dai pasticceri che ne fanno parte - ha ringraziato
il sindaco e ha ricordato come sin da ragazzino abbia sempre cercato di
essere catanese fra i catanesi: «Da questa città ho ricevuto molto di
più di quanto io abbia dato». insediamento. «Attribuire a Caviezel la cittadinanza onoraria - ha detto Bianco - è uno dei momenti
più importanti della sindacatura. E' con vero gratitudine che la assegno
a un uomo che ha saputo con impegno straordinario incentivare la
tradizione della pasticceria e della gelateria in particolare e che,
ancora oggi non più giovanissimo, trasmette i suoi saperi ai più giovani
offrendo loro una preziosa opportunità». Nato e cresciuto in Svizzera,
sin dal secondo dopoguerra il maestro Caviezel ha saputo rilanciare in
particolare la gelateria. «Per il lustro che Lucas Caviezel ha saputo
dare a Catania in questi decenni, l'Amministrazione comunale ritiene di
dovergli conferire, in segno di stima e apprezzamento, la cittadinanza
onoraria del Comune», si legge nella pergamena. Caviezel - ieri
accompagnato dal presidente dell'associazione di categoria Ducezio,
Salvatore Farina, e dai pasticceri che ne fanno parte - ha ringraziato
il sindaco e ha ricordato come sin da ragazzino abbia sempre cercato di
essere catanese fra i catanesi: «Da questa città ho ricevuto molto di
più di quanto io abbia dato».
Mi sento catanese fra i
catanesi
Caviezel è sinonimo di Pasticceria Svizzera, quindi
dare la cittadinanza onoraria a Luca Caviezel è quasi un atto dovuto
perché quel nome richiama automaticamente il fascino dei cento metri
d'oro della via Etnea.
I Caviezel fanno parte di quel gruppo di imprenditori
svizzeri (tra cui anche i Caflish) che nel secolo scorso scelsero di
lavorare e vivere a Catania, ed erano così tanti e di alto censo che a
Catania c'era anche una Scuola svizzera dove studiavano i loro figli.
Tra l'altro Caviezel e Caflish avevano i loro negozi in via Etnea a
distanza di non più di dieci metri: Caflish
 che vendeva articoli
casalinghi era sulla sinistra a salire, prima della farmacia Spadaro
Ventura, della Sala Roma, della Birreria Lorenti e della Rosticceria
Giardini, mentre Caviezel era sulla destra, poco prima dell'albergo
Central Corona che aveva all'ingresso due leoni di marmo. che vendeva articoli
casalinghi era sulla sinistra a salire, prima della farmacia Spadaro
Ventura, della Sala Roma, della Birreria Lorenti e della Rosticceria
Giardini, mentre Caviezel era sulla destra, poco prima dell'albergo
Central Corona che aveva all'ingresso due leoni di marmo.
Sopra Caviezel vi era la sede Rai di Catania con il
caporedattore Mario Giusti, l'uomo che inventò il Teatro Stabile di
Catania (assieme al notaio Tanino Musumeci) e che alla Rai di Catania
organizzava le trasmissioni di successo di Turi Ferro e di suo padre
Guglielmo, in primis "Tutta la città ne parla" con Turi che scriveva «al
fratello Bastiano da Catania che più va e più bella addiventa». I testi
erano di Piero Corigliano, Gerardo Farkas e di Filosì, i primi due erano
giornalisti di vertice de "La Sicilia".
A vent'anni da collaboratore sportivo di Radio
Sicilia frequentavo la sede di Catania dove registravo con il vecchio
Nagra delle interviste che Totò Pistone "puliva" con le sue forbicine
sul nastro nastro. A un certo orario arrivava al secondo piano il
profumo degli arancini di Giardini e allora mandavano un ragazzo, oppure
Bik che faceva il batterista, ma anche il tuttofare a prenderne un
vassoio. Se c'erano ospiti invece quel ragazzo andava alla Pasticceria
Svizzera a prendere pasticcini e bignè.
In genere la gioventù dorata degli anni '50 e fino
agli anni '80 si dava appuntamento da Caviezel all'ora dell'aperitivo,
ed era il momento di fissare i programmi della serata, o andare al
cinema, oppure a qualche festa da ballo in casa, di studiare non se ne
parlava. Un settimanale dell'epoca molto diffuso pubblicò un ampio
servizio fotografico sui «giovani leoni» catanesi da Caviezel e ci fu un
mezzo scandato perché in foto apparivano anche personaggi in vista delle
professioni cittadine. Caviezel è uno dei nomi che ha resistito più a
lungo in via Etnea, ebbe anche per un breve periodo una "succursale"
vicino piazza Duomo.
Da tempo in via Etnea non ci sono più insegne
Caviezel, da quando i negozi di successo sono traslocati al Viale. Ed è
una tristezza.
Tony Zermo - La Sicilia, 28 Gennaio 2014
|


Brasile, detto anche bar dei professori, altro
non era che un "buco,
 sempre rumoroso e animato dai conversare di
poeti e novellieri in fieri. Gli assidui furono in maggior parte
giornalisti agli inizi (Vito Mar Nícolosi, Ferdinando Caioli,
Giacomo Etna), pittori alle prime armi (Fichera, Rimini, Gandolfo),
nonché docenti di scuole medie senza cattedra... Padroni del bar, i
coniugi Imbronciano: curiosa coppia, con un bambino di pochi mesi
che la signora allattava, seduta alla cassa, mentre il marito
attendeva ai bicchieri, al caffé, alle risciacquature. sempre rumoroso e animato dai conversare di
poeti e novellieri in fieri. Gli assidui furono in maggior parte
giornalisti agli inizi (Vito Mar Nícolosi, Ferdinando Caioli,
Giacomo Etna), pittori alle prime armi (Fichera, Rimini, Gandolfo),
nonché docenti di scuole medie senza cattedra... Padroni del bar, i
coniugi Imbronciano: curiosa coppia, con un bambino di pochi mesi
che la signora allattava, seduta alla cassa, mentre il marito
attendeva ai bicchieri, al caffé, alle risciacquature.
Turgida di guance, di braccia, di poppe, la
proprietaria, in quel bailamme di letterarie diatribe sentiva
nobilitata la sua stessa mansione di nutrice in vetrina. Con le
pareti a piastrelle, come l'ingresso di un albergo diurno, il
Brasile s'era fatto un nome quasi nazionale. Vergane, Sarfatti,
Saponaro, di passaggio per Catania, venivano li a cercare gli amici,
e vi si soffermavano, attratti dalle fantasie di Amante, dalle
mutrie di Brancati, dall'umorismo del giovane Patti. Troneggiava il
professor Michele Cosenza, un vero mare magnum dello scibile... ".

 Al
Gambrinus diedero prestigio i soci del Circolo Artistico,
soprattutto i redattori di Siciliana, la bella rivista catanese, cui
collaborarono Roberto Rimeni, Natale Scalía, Giuseppe Patané e altri
dell'intelligbentia nostrana. Al
Gambrinus diedero prestigio i soci del Circolo Artistico,
soprattutto i redattori di Siciliana, la bella rivista catanese, cui
collaborarono Roberto Rimeni, Natale Scalía, Giuseppe Patané e altri
dell'intelligbentia nostrana.
Da ricordare anche il
Baciami subito che era un locale
notturno, preferito dal barone Beritelli, dal maestro di scherma
Carletti, dal professor Cassarà, latinista di grandi risorse.
Lo frequentarono pure alcuni giornalisti assai
noti, come Bettaniní, Garano e Corvaia.
Col trascorrere degli anni, i Caffé, che avevano
fatto storia a Catania scomparvero tutti, uno dopo l'altro.
L'ultimo guizzo dell'ultimo rampollo blasonato si
ebbe nel giugno del '37, allorché Peppino Lorenti inaugurava il suo
grande ritrovo al Giardino Bellini.
Fu l'estrema radura di sereno gaudio prima della
tempesta, il luogo ideale dove "tra lo sfarzo delle luci, il fresco
della sera, il profumo dei fiori, la delizia dei suoni dell'ottima
orchestra, il gran pubblico catanese trascorse indimenticabili
serate sotto il palpito delle stelle e il fascino romantico della
notte". Ma, con l'avvento del 1940, l'oscurità della
notte aveva già perso il suo fascino.


si trovava in Via Etnea dove attualmente c'è la
Rinascente, poco dopo la farmacia di Spadaro Ventura e il cinema Sala Roma
andando verso la Villa e la statua di Garibaldi. C'era un flusso continuo di
clientela attratta dai suoi arancini, al sugo con piselli e al burro, famosi
anche fuori città. La folla era tanta che i commessi non potevano
controllare tutto e accadeva che i ragazzi ne approfittassero. Nei giorni di
pioggia entravano portando al braccio l'ombrello dentro cui facevano
scivolare gli arancini: ne pagavano uno o due consumati al banco e se ne
portavano via una mezza dozzina dentro l'ombrello.
Di fronte c'era la Pasticceria Svizzera dei Caviezel,
Luca e Retho, e sopra la sede Rai dove Mario Giusti, Guglielmo e Turi Ferro,
Gerardo Farkas, Piero Corigliano, Totò Pistone, la pianista Dora Musumeci, a
volte anche il maestro Pregadio, il batterista Bic e compagnia cantante
lavoravano a «Tutta la città ne parla» e al «Ficodindia». Il direttore della
sede Rai di Catania era il signor Carrera promosso per avere salvaguardato
gli impianti durante i bombardamenti e l'invasione anglo-americana.
Casualmente Carrera era vicino di casa della prof. Falcidia e fu tra i primi
ad accorrere quando venne assassinata. Ma questa è roba abbastanza recente.
Mentre regista e attori imbastivano il programma arrivava
dalla finestra l'odore degli arancini ancora caldi. Così qualcuno provvedeva
immantinente a ordinare due grandi guantiere di arancini, metà «a sucu a
carni» e metà al burro, e quando dopo un quarto d'ora arrivava il garzone
con gli arancini belli caldi si sospendeva il lavoro per evitare che si
raffreddassero: e mi invitavano a mangiarne qualcuno perché da giovincello
collaboravo allo Sport del Gazzettino di Sicilia e quindi avevo libertà
d'accesso.

In meno di cento metri c'era la «pancia» della città, che
andava dal mercato di via Gambino poi sparita per lo sventramento del San
Berillo, alla rosticceria Giardini, a Caviezel, alla salumeria Dagnino.
All'angolo di Via Etnea con Via Umberto c'erano (e ci sono ancora) le
rinomate pasticcerie Savia e Spinella che si fanno concorrenza, ma vanno
benissimo tutte e due e non hanno proprio motivo di lamentarsi. Poco più
avanti in Via Etnea c'è sempre Mantegna che fa un grande lavoro di cucina
proponendo piatti molto gustosi e anche raffinati per una clientela chic.
Ma il grosso della città, il popolo, si riforniva in via
Gambino, la strada stretta che partiva da Piazza Stesicoro e sfociava in
Piazza Spirito Santo. Tra Piazza Stesicoro e via Gambino c'erano due
salumerie importanti che si fronteggiavano, una era dei miei genitori e
l'altra della famiglia Impellizzeri. Quando scrissi il primo articolo sulla
pagina sportiva de «La Sicilia» il fatto fu segnalato dal redattore del
settimanale satirico «Lei è lario» che poi andò da mio padre per essere
ringraziato con qualche chilo di salsiccia. Era il 1953.
Proseguendo da Piazza Stesicoro, detta «Porta di Aci»,
verso Piazza Spirito Santo lungo Via Gambino c'era di tutto, un negozio di
verdura che faceva angolo con via Paternò, poi una rivendita di balate di
ghiaccio perché all'epoca i frigoriferi erano un lusso, seguivano una
rivendita di tabacchi, il macellaio, il pescivendolo, il panettiere. Certo
per il pesce era meglio la pescheria, ma la zona di via Gambino era
«completa» di negozi e poi era vicinissima a Via Etnea e agli arancini di
Giardini. Erano preparati con riso cotto allo zafferano, ripieni di carne di
vitello al ragù o alla glace con l'aggiunta di interiori di pollo, burro e
formaggio fresco, fritti nella sugna o nell'olio di oliva, in formato
classico a pera o a sfera. Fino al 1940 costavano mezza lira. La bottega di
Via Etnea stretta e lunga fu inaugurata nel 1921 e chiuse i battenti il 26
dicembre 1958. E ancora oggi, a distanza di più di 50 anni, se ne parla
con nostalgia.
Tony Zermo - 22/12/2012


Vitaliano Brancati, nel suo Diario romano, in data 1950
racconta - e il suo racconto ci permettiamo d'integrare con nostri ricordi
giovanili - che dal `44 al `46, al caffè Italia di Catania, allora situato
dove via Etnea si biforca con l'inizio di via Caronda, proprio alle spalle
del monumento a Garibaldi, erano soliti riunirsi, quasi tutti i giorni e,
per lo più, nella tarda mattinata, alcune persone di rare qualità. Noi,
allora giovanotti, un paio di quelle persone che trascorrevano qualche ora
al giorno discutendo di letteratura e politica, sedute attorno a un
tavolinetto dietro la vetrina d'esposizione del lato sud del locale, le
conoscevamo benissimo o perché erano stati nostri professori o perché lo
erano ancora. Oltre al Brancati e a qualche altro personaggio saltuario, il
gruppetto era quasi sempre composto di Francesco Guglielmino, Stefano
Bottari e Arcangelo Blandini.
Il Guglielmino, professore di letteratura greca
all'Università e autore di un volumetto di buone poesie in siciliano dal
titolo Ciuri di strata (1922), era allora considerato a Catania una specie
di istituzione culturale. Da giovane aveva avuto la ventura di conoscere
Giovanni Verga e di essere stato vicino a Federico De Roberto, sicché era
diventato un vivente anello di congiunzione tra il glorioso e quasi mitico
Ottocento letterario catanese e la generazione, per lo più mediocre e
provinciale, che s'era affacciata alla letteratura negli anni che avevano
immediatamente preceduto e seguito la prima guerra mondiale. Brillante,
faceto, signorile, il Guglielmino batteva allora la settantina (era nato nel
vicino paese di Acicatena nel 1873) ed era totalmente pelato e più sordo
d'una campana. Portava i baffi con le punte all'insù, l'inseparabile bastone
appeso al gomito, il cappello verdognolo con la falda piegata per metà su un
lato, i pantaloni grigio-scuri a sottilissime righine bianche e la giacca,
nera, con le tasche sempre gonfie di giornali. In apparenza modesto e alla
mano con tutti, in realtà completamente compreso del suo ruolo, il
professore Guglielmino era universalmente stimato e molto ricercato,
specialmente dai giovani. Dava però un certo fastidio quella sua senile
sordità che lo costringeva, tutte le volte in cui qualcuno gli rivolgeva la
parola, a tirar fuori dal taschino il cornetto acustico e a puntarlo in
direzione di chi parlava. Rispondeva, poi, con la sua caratteristica voce
chioccia, gridando e quasi facendo voltare la gente. Di lui raccontavano che
un pomeriggio, nell'aula magna dell'Università, mentre un cattedratico di
passaggio stava tenendo una dotta conferenza, s'era d'un tratto alzato e
aveva gridato in perfetto siciliano (a modo suo sottovoce) ad un vecchio
collega seduto in prima fila, suscitando l'ilarità generale e bloccando in
gola la parola all'allibito oratore: «Sùsiti, Turi, e amunì nni. Ssu pazzu
sta dicennu `n-saccu di minchiati! »

C'era, poi, il professore Bottari, messinese e titolare
all'Università della cattedra di Storia dell'arte medievale e moderna. Era
pienotto, scuro di pelle e un po' trascurato nell'abbigliamento. Veniva,
qualche volta, a far lezioni con la barba di tre giorni e, se gli capitava,
anche col bavero della giacca, o con la fascia del cappello, unti di chissà
che. Aveva poi una vocina molto flebile, da grillo parlante, che non alzava
mai di tono per nessun motivo, sicché, quando parlava dalla cattedra o
buttava giù le domande agli esami, si dovevano fare i classici salti mortali
per capire quel che diceva.
Se ne stava, inoltre, talmente assorto nei suoi
pensieri di raffinato storico dell'arte che, per non lasciarsene scappare
nemmeno uno, spesso si fermava, per strada, per prendere appunti su
occasionali pezzetti di carta. Anche di lui si raccontava che una volta, con
un suo assistente, avevano tranquillamente parlato di Bellini per più di un
chilometro: l'uno, però, si riferiva all'omonimo musicista catanese, mentre
l'altro credeva che si trattasse
 del famoso pittore del Quattrocento
veneziano Giovanni Bellini. del famoso pittore del Quattrocento
veneziano Giovanni Bellini.
Il più vivace del gruppetto, dopo il Guglielmino
giustificato dalla sordità, era il Brancati. S'avviava, allora, verso i
quarant'anni ed aveva raggiunto, come scrittore, una certa rinomanza anche a
livello nazionale per aver pubblicato, nel `41, il suo libro più divertente:
Don Giovanni in Sicilia.
Per darsi le arie, spesso portava pure lui il bastone e
aveva un vispo visino da furetto. Fisicamente, però, era sottile e delicato
come un grissino. Nonostante la forte carica di gallismo che sapeva
infondere ai suoi personaggi, così esile e sparuto com'era, una donna
sessualmente un po' su di giri se lo sarebbe succhiato d'un fiato come un
uovo fresco.
Molto intelligente e dalla battuta caustica e facile, il
Brancati, ogni tanto, si divertiva a punzecchiare Giuseppe Villaroel (un
poeta ingiustamente dimenticato dai critici e dagli antologisti del primo
Cinquantennio del `900), per i suoi trascorsi fascisti. Il Villaroel, allora
prudentemente profugo a Catania perché a Milano, in quegli anni ancora caldi
dell'immediato dopoguerra, soffiava aria brutta per uno che era stato
autorevole critico letterario del mussoliniano Il popolo d'Italia, non se la
prendeva per niente. Scherzando anche lui, faceva subito adombrare il
Brancati ricordandogli quel mannello di giovanili operette un po' troppo
impegnate col caduto regime che gli avevano permesso di arrivare, troppo
presto e troppo facilmente, dov'era arrivato. Anche se ora gli faceva più
comodo ritenerle delicta iuventutis e opera di uno sconsiderato ragazzaccio
che aveva impunemente approfittato della sua firma.A1 fine di evitare quelle
scherzose schermaglie che, in fondo, lo infastidivano un poco, il Villaroel
preferiva venirsi a sedere, ogni tanto, con noi ragazzi nel vicino caffè
Savia. Gioviale e senza troppi peli sulla lingua, si divertiva a
chiacchierare con noi di donne e di letteratura, raccontandoci episodi seri
e spassosi capitatigli nella sua lunga carriera di letterato che, nonostante
avesse sempre parlato bene di tutti, s'era procurato, specialmente a Milano,
solo antipatie e inimicizie. In quella città di arrivisti e di avventurieri,
ci diceva talvolta per sfogarsi, con la scusa dell'Antifascismo e della
Resist enza, un grosso nugolo di marpioni d'ogni risma e colore, s'era
ficcato di prepotenza nelle case editrici e nei giornali per fare il buono e
il cattivo tempo non certo per l'arte e la cultura, ma per i loro personali
interessi di partito o di cassetta. enza, un grosso nugolo di marpioni d'ogni risma e colore, s'era
ficcato di prepotenza nelle case editrici e nei giornali per fare il buono e
il cattivo tempo non certo per l'arte e la cultura, ma per i loro personali
interessi di partito o di cassetta.
Dei quattro amici del caffè Italia, tutti più o meno
insudiciati di fascismo anche se solo molto superficialmente e per motivi di
carriera (qualche maligno diceva, infatti, che andavano ad esporsi tutti i
giorni in vetrina, dietro le bottiglie dei liquori e la frutta di pasta
reale, per rifarsi in pubblico una nuova verginità politica), Arcangelo
Blandini era l'unico totalmente pulito. Nato a Catania il 31 ottobre 1899
(vi morì poi il 1 ° gennaio 1974), proprio negli anni più fulgidi del
ventennio nero, pur di non essere obbligato a prendere la tessera del
partito fascista, aveva preferito lasciare Roma e ritirarsi a vivere in
disparte: nella solitudine della sua vecchia casa catanese e presso gli
agrumeti che possedeva nelle vicinanze di Palagonia. Alto, segaligno,
semplice nel vestire e di modi affabili, aveva un aspetto quasi sempre
triste e corrucciato - anche il suo sorriso era stentato e amaro - e non
gradiva né mettersi in mostra né parlare, o far parlare, di sé. Poco loquace
e riservatissimo, in quelle private riunioni di amici non si spingeva mai
avanti e solo di rado prendeva in mano le redini della conversazione.
Preferiva restarsene nel suo cantuccio, intento ad ascoltare, con molta
attenzione e con qualche impercettibile risolino, quel che dicevano gli
altri.
Quando era costretto a dire la sua, lo faceva quasi a
malincuore e in un tono così sommesso da mandare in bestia il povero
professore Guglielmino. Il quale, nonostante si piegasse tutto verso di lui
col cornetto acustico appiccicato all'orecchio sinistro e aperto al massimo
volume, non riusciva ad afferrare quasi niente.
I rari interventi del Blandini erano sempre assai precisi
e pertinenti. Uomo di varia e profonda cultura e, per giunta, abituato a
trascorrere quasi tutto il suo tempo in compagnia dei suoi libri e dei suoi
pensieri, quel che diceva lo aveva così a lungo rimuginato e meditato da
farlo diventare cosa propria e originale. Aveva pure, qualche volta, ma
molto di rado e subito repressi, improvvisi scatti di stizza, caratteristici
di quei soggetti che, per innata timidezza o per modestia più voluta che
reale, pazientemente sopportano tutti i luoghi comuni e le sciocchezze che
vengono detti in loro presenza e che ad un certo punto, non potendone più,
reagiscono in modo sproporzionato.
Dopo il definitivo rientro da Roma, dove era stato
redattore, sino al `37, del settimanale letterario romano Quadrivio, fondato
e diretto dal siciliano Telesio Interlandi, autore del libro razzista Contra
Judeos, e di dove aveva pubblicato due striminziti libretti di poesie, il
Blandini lasciò l'isola una sola volta per un viaggio a Parigi. Rimase
celibe e trascorse tutta la vita in quasi monastica clausura, solo con i
suoi pensieri e più leggendo e studiando che scrivendo. Non disdegnava,
tuttavia, la presenza di qualche gatto randagio, venuto ad invadere il suo
incolto giardinetto, né quella di qualche amico, per lo più giovane, che
andava a trovarlo per una chiacchieratina culturale o per sottoporre qualche
scritto al suo giudizio.
Salvatore Puglisi “CATANIA DEI SOGNI” Cavallotto
Edizioni - www.cataniaperte.it

 IL
BAR ELENA ALL' INGRESSO DELLA
PESCHERIA IL
BAR ELENA ALL' INGRESSO DELLA
PESCHERIA
In piazza Duomo i primi cinque
numeri civici
sono quelli del
palazzo dei Chierici.
Il numero centrale, il 3,è
l'ingresso dell'edificio che oggi è
sede degli assessorati al bilancio e
ai tributi e dei relativi
uffici;degli altri quattro, l'1 e il
2 ospitano un'agenzia del Banco di
Sicilia, il 4 e il 5 un'agenzia del
Banco di Roma.
Fino al primo decennio del
Novecento, il n.5,dopo il quale si
apre il passaggio d'ingresso alla
Pescheria, apparteneva al bar
Elena,un pubblico locale oggi
dimenticato e,in verità, poco
celebrato anche allora.
In questa fotografia (scattata da
Giuseppe Signorello nel 1908) il bar
espone un abbondante e vario
assortimento di bottiglieria,
verosimilmente vini pregiati e
liquori. Non erano molti, in quei
tempi, i bar del centro
cittadino:nel volume Catania
Illustrata di Sebastiano
Salomone,pubblicato proprio in
quell'anno stesso, di altri bar e
caffè cittadini, oltre a questo, ne
erano enumerati in totale altri 21,
alcuni dei quali anche con attività
di dolceria, pasticceria e
sorbetteria;non ne sopravvive più
alcuno.
(Foto e testo dal libro "Vecchie
foto di Catania "di Salvatore
Nicolosi)
Rispetto alla pubblicazione di
Nicolosi, oggi gli esercizi
commerciali ospitati a palazzo dei
Chierici sono diversi !Da notare
numerosi interessanti dettagli in
questa foto: il più evidente è il
bugnato che ricopriva il Palazzo dei
Chierici e la fontana dell'Amenano
senza lo scavo attuale dove scorre
l'acqua


In memoria del grande pasticciere Bonvegna
La vita è fatta spesso di incontri e avvenimenti
casuali, ma al tempo stesso ciò che ci accade è frutto del lavoro e
dell’esperienza senza cui non saremmo ciò che siamo. La storia di
Concetto Bonvegna e Nunzio Verona titolari dell’ omonima pasticceria
sita in via Asiago 60 è quella di due pasticceri ricchi di
esperienza e talento che si incontrano casualmente e danno vita a
una delle realtà commerciali più longeve ed apprezzate della città
etnea.
Concetto Bonvegna impasta zucchero e farina per
la prima volta a dieci anni, quando è apprendista nella storica
pasticceria Laudani di via Playa, di fronte al mulino Maione. A
quindici anni lo troviamo presso il bar del dopolavoro della Posta
centrale in via Etnea a preparare deliziosi manicaretti mentre ormai
maggiorenne collabora con i fratelli Maimone presso l’indimenticato
Bar Centrale di via Etnea, angolo piazza Stesicoro, dove completa Ia
propria formazione professionale e incontra un altro straordinario
professionista che sarà suo socio.
Nunzio Verona, pasticcere dall’età di quattordici
anni,ha una grande esperienza maturata in città, e oltre lo stretto:
ha appreso iI mestiere presso svariati laboratori e prestigiosi
locali come l’Antica pasticceria Melardi di piazza Spirito santo, il
Jolly Hotel di piazza Trento, iI Central Palace di via Etnea ma ha
anche lavorato al Lido di Venezia presso il noto bar e gelateria
“Cristallo” alternando per quattro stagioni iI lavoro estivo in
Veneto con quello invernale presso iI Bar Centrale dei Maimone.
È dunque al Bar Centrale che i due si conoscono,
si apprezzano e decidono di iniziare insieme una nuova avventura
professionale aprendo un loro laboratorio in via Asiago 60. La
clientela non tarda ad arrivare, grazie alla professionalità dei due
professionisti e alla qualità dei prodotti artigianali. I titolari
sono però consapevoli del fatto che il successo di quest’ attività
si deve anche a uno staff competente e dedito, tra cui va annoverato
il sig. Giuseppe Rizzo, uno straordinario professionista e fedele
collaboratore da trentacinque anni. Il locale riceve recensioni
lusinghiere dai clienti affezionati e dagli avventori di passaggio
che apprezzano I’altissima qualità delle preparazioni: chi se ne
intende sa che è la pasticceria Verona e Bonvegna ad avere ideato
tanti anni fa il Savarin con crema pasticcera e frutta fresca che
ancora oggi sembra riscuotere successo, insieme alla torta al limone
o alle fragoline di bosco e a tante altre specialità. Alle trazioni
tipiche siciliane, infatti, la pasticceria accosta prodotti classici
della pasticceria italiana e internazionale, come la Millefoglie, la
Saint Honoré e profiterole.
Oggi i due titolari sono affiancati dai
rispettivi figlioli,Giuseppe Verona e Rosario e Giovanni Bonvegna
che seguono le orme dei genitori nella produzione pasticcera e nella
gestione impeccabile del punto vendita e delle numerosissime
prenotazioni che il laboratorio riceve quotidianamente.
https://www.shoppingdeluxe.it/partner/le-migliori-pasticcerie-siciliane/pasticceria-verona-bonvegna-catania/


HERY BAR
Amarcord...ottobre
1975...davanti all'HERYBAR di via Etnea 19, Catania. Io sono
all'interno del bar, il primo vestito di blu mentre bevo, mio padre,
il proprietario, è appoggiato allo stipite destro accanto ad alcuni
clienti seduti a fianco, il terzo da destra è l'attore Saretto
Spadaro. In oltre è da notare, a sinistra, la vetrinetta
pubblicitaria del fotografo CAV. Saro D'Agata, papà del compianto
Gianni D'Agata, che mostra alcune foto dell'attore Saro Bonaventura.
All'epoca la via Etnea non era chiusa al traffico e sui marciapiedi
non si mettevano i tavolini. (Piero Privitera, Gianni Sineri,
Giuseppe D'agata, Teresa D'agata)
Turi Giordano

Menza nel 1955

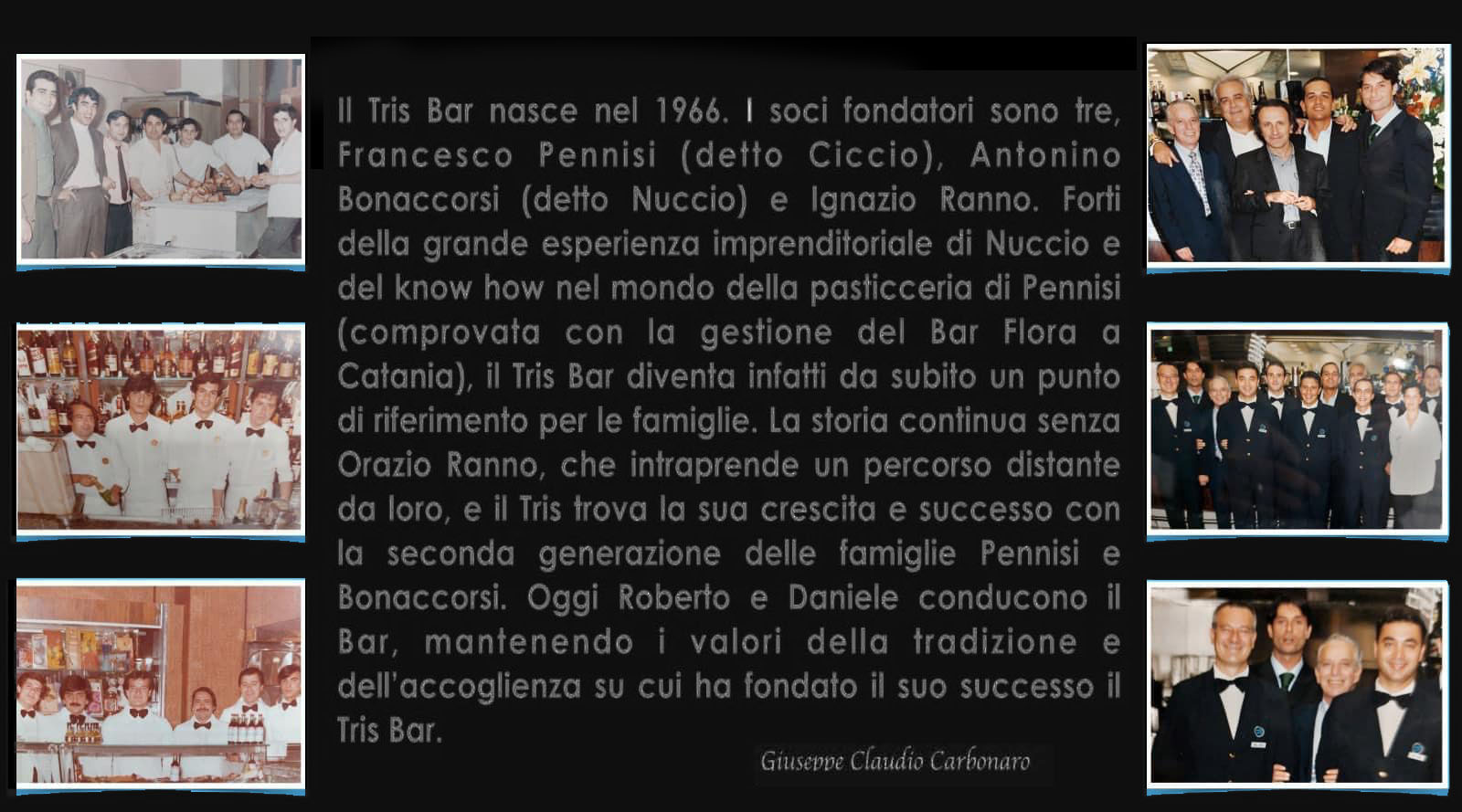
grazie alla pagina Facebook Volontari di Picanello
FUORI CITTA'


Urna a Viagrande

Il Paradiso dell'Etna
|
LA RIVIERA |
 |
 |
IL BELLAVISTA AD ACIREALE

ACICASTELLO

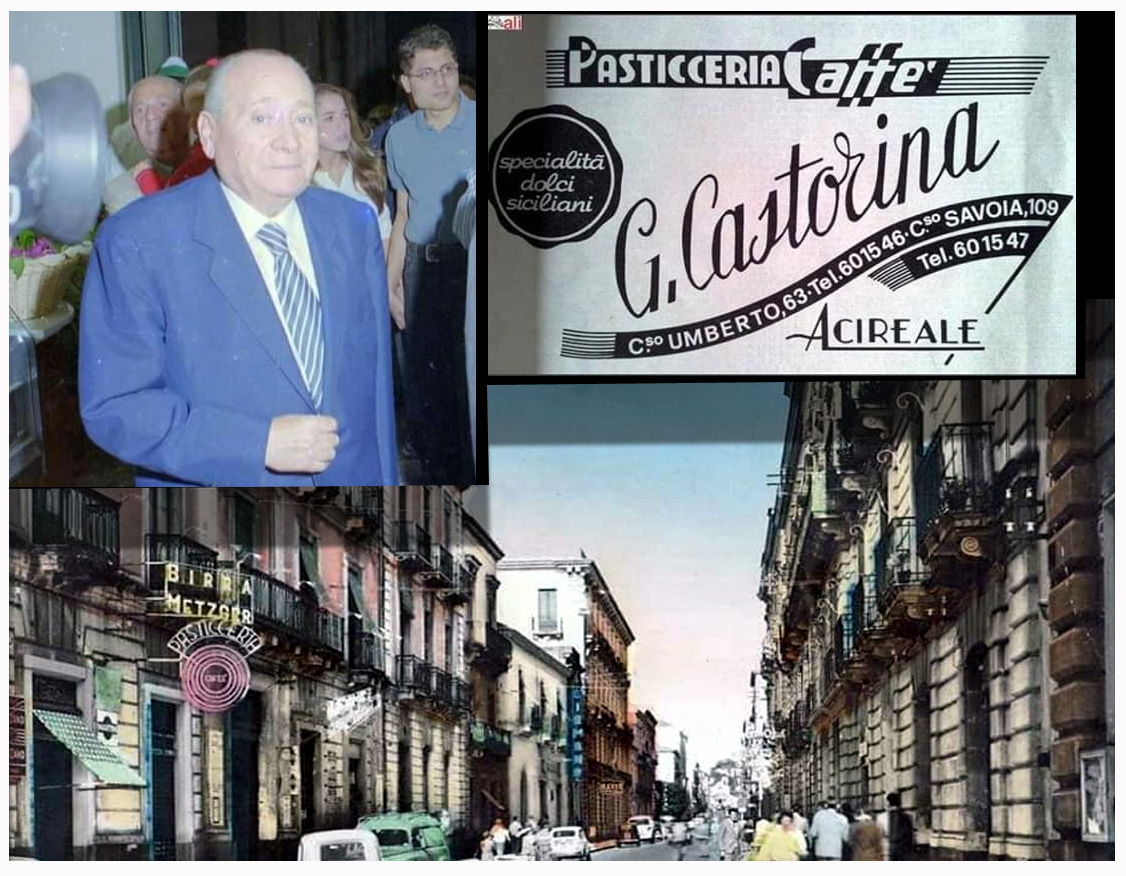
|

|

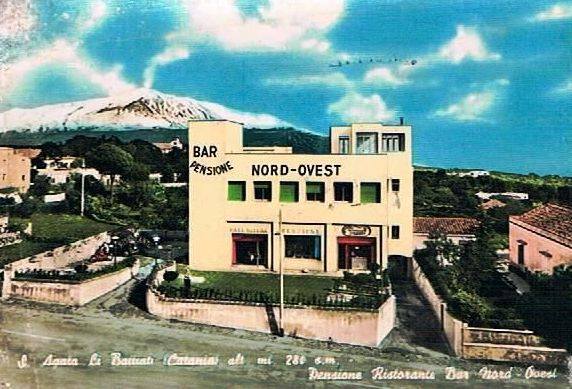
 PROCOPIO,
L'INVENTORE DEL GELATO. Durante
il Medioevo, in Occidente, le raffinatezze legate al gelato scomparvero
momentaneamente. PROCOPIO,
L'INVENTORE DEL GELATO. Durante
il Medioevo, in Occidente, le raffinatezze legate al gelato scomparvero
momentaneamente.
Non
così in Oriente. Fu proprio lì che venne realizzata la decisiva
scoperta del sistema per congelare i succhi di frutta ponendoli in
recipienti circondati di ghiaccio tritato. Gli Arabi svolsero un ruolo
assai importante. In Sicilia erano soliti mescolare la neve dell'Etna ai
succhi di frutta. Non a caso la parola sorbetto sembra tragga origine
dall’arabo scherbet (dolce neve) oppure dall’etimo, sempre arabo,
sharber (sorbire), da cui passando attraverso la lingua turca, sarebbe
stato coniato il termine chorbet, ossia sorbetto.
Alla
fine del ’300 stava risorgendo, dalle nebbie del Medioevo, l’arte
del vivere e del mangiar bene, e il consumo dei sorbetti continuava in
tono minore, anche se le direttive di austerità del papa e dell’imperatore
venivano sempre più disattese.
 Nel
lontano 1660 un certo Francesco Procopio De Coltelli lasciò la natia
Acitrezza per conquistare Parigi, Non partì con un carico di lupini, ma
con uno speciale utensile che serviva a fabbricare sorbetti e granite.
Forte della tradizione in materia, importata secoli prima in Sicilia dai
lungimirati musulmani, Procopio capi che la specialità nostrana poteva
avere successo anche in altre parti del inondo. E così inventò la sua
ricetta vincente: lo zucchero al posto del miele (come nell'uso arabo) e
il Nel
lontano 1660 un certo Francesco Procopio De Coltelli lasciò la natia
Acitrezza per conquistare Parigi, Non partì con un carico di lupini, ma
con uno speciale utensile che serviva a fabbricare sorbetti e granite.
Forte della tradizione in materia, importata secoli prima in Sicilia dai
lungimirati musulmani, Procopio capi che la specialità nostrana poteva
avere successo anche in altre parti del inondo. E così inventò la sua
ricetta vincente: lo zucchero al posto del miele (come nell'uso arabo) e
il sale mescolato al ghiaccio nelle giuste proporzioni per aumentarne la
durata.
sale mescolato al ghiaccio nelle giuste proporzioni per aumentarne la
durata.
Ma
non fu vita facile per il pescatore mancato. Passarono molti anni prima
che Procopio potesse mettere a punto un sorbetto doc, e ad ogni
tentativo fallito faceva ritorno nella sua Acitrezza e scoraggiato
prendeva il largo, oltre i Faraglioni. Ma in quel fatidico 1660 riuscil
finalmente ad aprire il suo primo caffè-gelateria nella capitale
transalpina, addirittura con la benedizione del sovrano Luigi XIV, il
mitico Re Sole, il quale era rimasto deliziato dal gusto "rnediterraneo"
dei suoi sorbetti. La sua fama si propagò velocemente, al punto che
dovette ampliare il suo locale e trasferirsi alla rue de l'Ancienne
Cornédie Francaise, aprendo il famoso Cafè Procope. Il gelataio
trezzoto divenne così Francois Procope De Couteaux, fu invitato alla
corte di Versailles per ricevere dal re un ambito riconoscimento:
"le Iettere patenti", una sorta di concessione esclusiva per
produrre le cosiddette "acque gelate" (l'odierna granita), e
poi gelati di frutta, "fiori d'anice e di cannella" e gelati
al succo di limone e d'arance.
Un
secolo più tardi sarebbe nato anche il celebre "Cafè Napolitainse"
del partenopeo Tortoni.
E
le vicende di questi due bar italiani si sarebbero incrociate più
volte, luoghi che testimoniano grandi eventi storici e culturali, che
lasceranno il segno in Europa.
Il
Café Procope diventerà il ritrovo ideale di illuministi di grande
fama, quali Voltaire, Rosseau, D'Alembert, Diderot; si dice che alcuni
di loro abbiano lasciato manoscritti, tutt'oggi consultabili a chi abbia
voglia di visitare questo locale, nel cuore del quartiere latino di
Parigi. Non solo. Negli anni della rivoluzione francese il bar sarà
frequentato dai capi del movimento giacobino, dai vari Roberspierre,
Danton, Marat e Saintjust; qualche storico francese sostiene che sia
stato anche teatro di omicidi durante gli anni del terrore. E invece,
trent'anni dopo, nel vicino Cafè Tortoni, si davano appuntamento il
sommo Gioacchino Rossini e un giovane siciliano, di Catania, che aveva
appena composto un'opera che avrebbe scosso definitivamente il
melodramma europeo. Il dramma musicale in questione è "I
Puritani", e l'artista è quel tale Vincenzo Bellini, giovane di
belle speranze che suscitava l'ammirazione del grande autore di
"Barbiere di Siviglia". Rossini preferiva le paste napoletane
del "Tortoni", mentre Vincenzino avrebbe sicuramente gustato
una granita di limone nel "Procope", fondato da quel
conterraneo venuto da Acitrezza.

La
rosticceria Stella
Le
tradizioni gastronomiche non si mantengono nel tempo. Alcune cambiano,
altre rischiano di perdersi. Ad esempio le scacce del modicano-ragusano,
un prodotto di rosticceria povero ma di altissima qualità e gusto,
rischia di perdersi nell’omologazione indotta da modelli di consumo
importati.
Pensate che nel corso della mia ultima visita a Ragusa Ibla, due anni e
mezzo addietro, la famosa bottega che produceva scacce continua ancora a
farle, ma nell’insegna c’è scritto “focacce”!
Credo
invece che occorra salvaguardare la denominazione originale e farne un
presidio gastronomico e per questo mi rivolgo agli amici di quella zona.
Anche
a Catania, nel campo della rosticceria, si sono conservate le tradizioni
delle scacciate e delle crispelle, ma non quella della pizza.
Non
riesco più a trovare la pizza come la mangiavo negli anni cinquanta,
vicino a casa mia, nei locali di una nota rosticceria. Venendo da piazza
Cappellini, adesso piazza Falcone, ti lasciavi sulla sinistra il palazzo
Fischetti, e alla destra il Crocifisso della buona morte, un nome non
propriamente beneaugurante per la mia parrocchia.
Nella
piazza v’era un grande mercato all’aperto che proseguiva per l’attuale
via De Curtis dove si trovava il cinema Mirone, mitica sede del
Cineforum negli anni ottanta. All’incrocio venivi circondato dai profumi
e dagli effluvi dello strutto fritto provenienti da tre o quattro
rosticcerie che si trovavano all’incrocio fra l’attuale via De Curtis,
che proseguiva nella via Di Prima (dove iniziava la zona proibita di
quelle che allora venivano definite le case chiuse) e la via Monsignor
Ventimiglia.
Entrando nella rosticceria trovavi subito alla tua sinistra tre enormi
caldaie dove friggeva in continuazione lo strutto in cui cuocevano
arancini, crispelle, pizze, sfincioni. I tre fratelli che la gestivano,
tondi grassi e rubicondi, badavano alle caldaie: il maggiore, più alto e
più rotondo, a quella più grande, il secondo, lievemente più basso ma
con rotondità proporzionalmente uguale a quella del maggiore, alla
caldaia intermedia. Il più piccolo d’età, che era anche il più minuto,
perché sembrava che la loro mamma nel generarli avesse perso
progressivamente potenza creatrice, era addetto alle crispelle che
produceva a getto continuo e a velocità supersonica, mescolando con
straordinaria abilità l’impasto con la ricotta o con l’acciuga e
versando il tutto nello strutto. Sì, perché lo strutto era d’obbligo,
anche in famiglia. Si preparava d’inverno con il grasso di maiale:
spesso si compravano le cotiche ( “a cutini”) che si cuocevano a parte
con un sottile strato di grasso, lasciandone la maggior parte da
sciogliere in padella per la preparazione dello strutto. “A saimi” il
nome catanese per lo strutto, si conservava per le preparazioni
alimentari, ma veniva usato in famiglia anche per i massaggi sulla
schiena dolente. Ciò che restava della preparazione, piccoli pezzetti
croccanti di grasso, le cosiddette “frittule”, (a Bologna chiamati
“ciccioli”) venivano anch’essi conservati per usi alimentari.
Dunque entrando in rosticceria si chiedeva la pizza alla catanese e se
non era pronta il più piccolo dei fratelli te la preparava all’istante.
Il
gastronomo educato
http://www.cataniapubblica.tv/cucina-arriva-il-gastronomo-educato-e-vi-mette-tutti-a-tavola-oggi-pizza-alla-catanese/

LA FRIGGITORIA STELLA
La storia della rinomata Friggitoria
è un po' la storia della stessa famiglia STELLA, sino ad oggi
sono quattro le generazioni che si tramandano da padre in figlio.
Nasce a Catania nella centralissima Via
Ventimiglia intorno al 1890, In una tormentata vicenda ambientata nella
Sicilia ottocentesca .
I
fondatori Natale e Andrea STELLA.
Giovani fratelli e piccoli
imprenditori agricoli delle campagne della zona tra Augusta e Lentini
(Sr), si dedicavano per tradizione familiare alle coltivazioni tipiche
della zona e all'allevamento di pregiate razze bovine.
I tempi difficili non permettevano a
due giovani imprenditori di espandersi ma loro, caparbi, pensarono bene
di migrare verso la grande città per poter vendere direttamente i
prodotti della loro terra.
Dopo enormi sacrifici e dopo raccolto
un bel gruzzoletto di denaro, partirono in calesse alla volta di
Catania.
(
E' bene ricordare che il viaggio da
Augusta a Catania era lungo ben tre giorni di marcia estenuante con non
pochi rischi, tra l'altro di essere aggrediti e derubati dalle bande di
ladroni che allora scorrazzavano per i sentieri stradali).
Nonostante la lontananza, i pericoli e
le notti passate all'agghiaccio o alle stazioni di posta come la mitica
stazione cosiddetta di "zia lisa" i fratelli Stella
giunsero a Catania e pressero subito contatti con dei conoscenti.
Visitarono parecchie botteghe ove poter impiantare la loro futura
azienda.
Catania allora si estendeva da Nord
-Sud compresa dal porto a poco piu' sù del Corso Sicilia (allora
inesistente) e da Est -Ovest dalla via della Concordia (strada delle
ottanta palme) alla Stazione (piazza Giovanni XXIII).
Per i più giovani va detto che già San
Giovanni li cuti era considerato un luogo di villeggiatura fuori città.
Ma torniamo ai STELLA, le botteghe
fatte visitare ai due fratelli non erano piaciute e stavano per lasciare
la città percorrendo dalla ex sciara del corso Sicilia verso il porto,
la stretta via Ventimiglia, quando si fermarono ad un chioschetto per
dissetarsi, si accorgevano che poco piu' avanti al numero civico 66 64
stavano traslocando.
Chieste informazioni e capito che il
proprietario era lì presente, senza destare troppo l'interessamento, da
classici siciliani di quei tempi cercarono di carpire informazioni sulle
botteghe.
Visitarono, i locali e i loro sguardi
si incrociarono e si parlavano, senza fiatare, sorridendo ma senza
fornire al proprietario alcuna sodisfazione trasmettevano tra loro la sodisfazione
di aver trovato i locali della futura azienda.
Dopo una lunga ed estenuante trattativa
sull'affitto, i lavori da fare, le cauzioni, il proprietario cedette
sotto il martellamento delle proposte prima di Andrea e poi di Natale.
Una volta accordati, il momento del pagamento il proprietario chiese di
andare presso la banca dei fratelli per ricevere le cauzioni, rispose
Andrea << la nostra banca siamo noi -
Natale pigghia i sordi >>
aggiunse Natale << pozz ire o' bagno>>,
sospettoso il proprietario disse << ma unni l'hai e sord'>>
risposero assieme << unn' o' sul e l'occhi nun arrivun>>.
Natale si allontanò in bagno e da una
tasca cucita appositamente nelle mutande srotolò un mazzo di soldi che
consegnò al proprietario delle botteghe, il quale alla vista di tutti
quei soldi annui meravigliato.
I due fratelli partirono per ritornare
ad Augusta dove li antendevano oltre che i propri genitori già anziani
anche le loro fidanzate, due sorelle, Maria e Giuseppina Ferraguto, due
bellissime donne di figure esili e poco assomiglianti alle classiche
donne siciliane infatti entrambi erano bionde con occhi azzurri e
carnaggione chiara.
Arrivarono a casa di notte, i genitori
fremevano di conoscere l'esito del loro viaggio, ma i due fratelli non
vollero parlare se non prima venissero convocate anche la famiglia delle
loro fidanzate, cosi mandarono un garzone di stalla a chiamare la
famiglia Ferraguto la quale risiedeva in una fattoria poco distante.
Immaginate la scena si sedettero tutti
attorno un grosso tavolo di legno, gli Stella posero a disposizione di
tutti al centro del tavolo pane, formaggio e vino e subito dopo i due
fratelli presero a spiegare i loro piani per il futuro, produrre salumi,
conserve e formaggi di buona qualità e venderli a Catania, la piazza non
è facile ed è necessario che entrambi si stabiliscono a Catania, mentre
che le rispettive famiglie Stella e Ferraguto penseranno alle fattorie,
ma c'è un problema ..... le donne, le fidanzate, i due fratelli non
sarebbero partiti senza di loro e non avrebbero potuto affrontare
nemmeno le spese di due matrimoni. Le discussioni, le perplessità dei
genitori delle due fanciulle non ebbero scampo innanzi
all'intraprendenza dei due fratelli. Giunsero a Catania dopo circa un
mese con al seguito due carri di mobilia e quant'altro per impiantare
una casa e due carri di lecornie di ogni tipo, salami, formaggi,
ricotta, tuma etc.etc.
Il successo non tardò a presentarsi
dopo qualche mese le migliori salumerie e macellerie si rifornivano dai
Stella. Riuscirono a sposarsi poco tempo dopo. Gli affari prosperavano e
i fratelli Stella miravano ad ingrandirsi ma principalmente di prendere
i catanesi "per la gola" , che come è noto hanno sempre avuto il "palato
fine". In Particolare i catanesi amavano la cucina "salata" e
estremamente lavorata con lavorazioni tipiche un po' arabe, greche.
Quindi pensarono che si sarebbe potuto provare ad installare una "rusticcheria,
scacciateria ma sopratutto non sarebbero dovuti mancare gli arancini.
Enormi arancini di riso imbottito di
ragù di carne e tuma fresca di pecora.
Dopo poco meno di un'anno nasceva la
FRIGGITORIA STELLA.
Nel frattempo nelle rispettive famiglie
che abitavano sopra gli stessi locali della salumerie e della
friggitoria In famiglia si susseguirono nuovi arrivi: Da Natale e Maria
nacquerò Giuseppe, Antonino, Francesca e Andrea, mentre che da Andrea e
Giuseppina nacquerò Natale e Giuseppe. Il tempo e la speranza avevano
baciato queste due famiglie, ma la fortuna non volle assisterli per
lungo tempo e poco dopo morì il piccolo Natale seguirono in tragici
eventi e malattie le dipartite di uno dei fratelli Stella e una delle
sorelle Ferraguto, cosi come voleva la allora tradizione siciliana,
qualche tempo dopo i cognati si unirono in matrimonio e unirono le due
famiglie in una.
Ma poco tempo dopo anche i due neo
sposi lasciarono il mondo terreno.
I figli non erano da meno nelle
capacità imprenditoriali e continuarono per la strada segnata da i loro
genitori, acquistando poco tempo anche un panificio.-
I stella divvennero i proprtietari di
quasi tutta la parte meridionale della via ventiomiglia con botteghe di
macelleria, salumeria, panificio e friggitoria.
La guerra, le invasioni prima tedesca,
poi degli alleati le carestie, le crisi e la poverta generalizzata colpi
tutti e i STELLA non furono risparmiati, ma nemmeno decapitatio solo
l'alto senso di sacrifico dell'intera famiglia fece in modo di passare
quei brutti momenti.
La friggitoria STELLA conobbe il suo
massimo splendora da gli anni 50 sino alla fine degli anni 70.
Le produzioni degli STELLA si
importavano persino negli Stati Uniti d'America, partecipavano a tutte
le fiere nazionali e internazionali promuovendo i prodotti tipici
siciliani e portando un po' di Sicilia agli emigranti.
Tra la Friggitoria, Salumeria e
panificio ed inoltre nelle capagne Augustane lavoravano decine di
persone assicurando il massimo della genuinità dei prodotti.
http://friggitoriastellact.jimdo.com/stella-oggi/ (le foto
provengono dal sito ufficiale della friggitoria Stella)
|

I MONSU’
Fino a tutto il 1500 l’Italia fu il punto di
riferimento per la gastronomia europea: i banchetti interminabili, con
carni e condimenti ricchissimi, tempi di cottura notevoli, erano
d’esempio per la nobiltà e per le corti d’Europa, per la gradiosità, la
genialità e l’opulenza delle rappresentazioni dei piatti.
Con Luigi XIV, la Francia diventò una potenza
dominante, la cultura e la lingua francese si diffusero ovunque e con
essa tutte le regole fissate dalla grandiosa cucina francese del
seicento e che finì per emergere in tutti i paesi da lui dominati e dove
la religione non creava limitazioni, parliamo della corte di Spagna e
del REGNO borbonico delle due Sicilie.
Maria Carolina d’Austria, sposa di Ferdinando I di
Borbone è stata una figura primaria e inconsapevole per la storia e la
tradizione della cucina italiana e in particolare per la cucina
siciliana. Infatti, a seguito del matrimonio con Ferdinando, Carolina
introdusse con insistenza i cuochi francesi, in quanto simbolo di
eleganza alla corte del re borbonico, dando grande importanza alla
figura del Monsù nelle case di tutti i nobili del regno; nello specifico
la nobiltà siciliana del ‘700, che consumava piatti francesi preparati
dal proprio cuoco francese.
Monsù fu l' appellativo, derivante dal francese
“Monsieur” ovvero Signore.
Chiamati talvolta con il loro nome di battesimo ma
con il cognome della famiglia presso cui lavoravano, alcuni di loro
diventarono così famosi da essere trattati alla stregua di grandi
artisti in quanto il titolo di Monsù era motivo di orgoglio che si
tramandava da padre in figlio.
“…il titolo di Monsù si dava ai cuochi di casata“
diceva Alberto Denti di Piraino, e cioè a quanti avevano il privilegio
di servire in case patrizie. Gli altri, al lavoro magari presso gente
ricchissima, ma non titolata, erano cuochi di paglietta e venivano
considerati “gente da non frequentare“.
Il Monsù era colui che dava il tocco di eleganza ed
originalità alle pietanze, signore e capo della cucina, e che si
contraddistingueva dagli apprendisti. Non c’era aristocratico nel Regno
delle due Sicilie che non avesse nella propria cucina un cuoco francese.
Era tanta la smania di sfoggiare un Monsù che
quest’ultimi venivano contesi dalla stessa nobiltà dell’epoca, perfino a
costo di duelli, e sono stati questi grandi cuochi che consolidarono,
fra 700 e 800, la grande cucina baronale, descritta da scrittori come
Tomasi di Lampedusa ne “Il Gattopardo” o De Roberto ne “I Vicerè“.
A Palermo in tutti i palazzi della nobiltà c’era
sempre il “quarto del Monsù”: in pratica un appartamento a disposizione
dello stesso che lo usava per se e a suo piacimento.
E’ chiaro che i signori siciliani, spur gustando con
piacere nei grandi pranzi ufficiali, i delicati sapori francesi, negli
altri giorni chiedevano ai loro Monsù di creare cibi più robusti e dai
sapori più decisi.
E così i Monsù, cucinavano pietanze rielaborandole
con l’arte di chi sa bene come utilizzare le materie prime, usando le
spezie per far risaltare al massimo sapori e odori e utilizzando quanto
la terra di Sicilia produceva.
I Monsù seppero creare piatti che consumiamo ancora
oggi: il gateaux di patate che in sicilia diventa gatò, all’aglassato,
ai timballi esternamente croccanti e ripieni di carne e formaggi, ai
polli farciti di riso o i beccafico, cacciagione cucinata ripiena di
fegatini e interiora varie,fino alla reinvezione della caponata in
agrodolce, agli involtini alla palermitana e il falsomagro che come
leggerete più avanti ricorda lontamente un piatto in origine decisamente
più leggero.
Diedero origine alle vecchie tradizioni alimentari
siciliane, grazie ai prodotti che questa magnifica isola produceva e
grazie alla cacciagione e al pescato che non mancava mai.
Nacquero da piatti della vecchia cucina siciliana
come i timballi, le melanzane alla parmigiana cotte sopra e sotto, cioè
con la brace che copriva il tegame e il pesce coricato, spunti che gli
stessi Monsù utilizzarono in seguito per creare e ampliare parte della
nuova gastronomia, trasformando quelli che erano piatti semplici in
sontuose preparazioni.
Alcuni di questi piatti verranno “imitati”, cambiando
la carne o la cacciagione con prodotti più economici: fra tutti le sarde
a beccafico o le melanzane o i peperoni ripieni di riso o la caponata di
melanzane (invece che di capone).
Saranno loro a creare nuove ricette per rendere
mangiabile la carne dura e fibrosa (retaggio della macellazione di
vecchi bovini). Fra questi era famosa la carne vaccina una farcitura di
tenere verdure e odori, chiamata gentilmente in francese farcie de
maigre, popolarmente divenuta farsumagru, falso magro, anche se riempito
di ogni sorta di ben di Dio e molto diverso dal delicato piatto da cui
aveva preso le origini. Loro la semplice modesta pasta con la ricotta ma
profumata di cannella, il cacio all'argentiere, caciocavallo riscaldato
in padella con un po' d'origano, sono golosità che se hanno soddisfatto
i grandi nobili siciliani.
Straordinariamente è proprio in Sicilia che i Monsù
con la loro arte culinaria, riuscirono ad influenzare gran parte della
cucina popolare siciliana, sfruttando tutte quelle ricette della
tradizione e superando la barriera esistente fra cucina ricca (per i
nobili) e cucina povera, dando il via a quella cucina popolare che più
che mai è presente in tutta la regione.
Furono loro che realizzarono per i loro signori una
serie di piatti che la grande tradizione isolana greca, romana, araba,
ebrea, normanna e spagnola aveva saputo conservare.
Gli originali Monsù, rigorosamente francesi,
istruirono i volgari “cuochi di paglietta” , dando vita ad una scuola
che originariamente avrà basi francesi ma che poi diventerà grazie a
altri grandi personaggi, rigorosamente italiana.
Ho pensato di raccontarvi questa storia a mio avviso
molto interessante, per far comprendere oltre alle “origini della cucina
siciliana” anche quanto lo stesso filo conduttore unisca paesi diversi.
La cucina è un’arte indiscussa e come tale appassiona. Artista e arte
che non sono meno di chi per genialità e bravura dipinge un bellissimo
quadro. Anche i Monsù lo facevano con dedizione, rigore e qualche volta
alterigia.
Di fatto però è un’arte effimera, perché allora come
adesso chissà perché, non ne rimane mai traccia… (ma forse sappiamo
perchè)
Armando Di Dio Martello, da Facebook “La storia della
cucina tradizionale siciliana”
https://www.facebook.com/hashtag/_la_storia_della_cucina_tradizionale_siciliana
|

C.R. de Saint-Non, che trascorse in Sicilia sei mesi, scrisse nel Voyage
pittoresque ou descripion des royaumes de Naples et de Sicilie, Paris 1751: “Noi
trovammo i nostri baroni palermitani passare voluttuosamente la vita in molle e
dolce ozio mangiando a due palmenti il pr dotto delle loro terre che essi non
visitano».
I
nobili ostentavano magnificenza per sorprendere i loro pari ed abbagliare il
popolo, che con dispregio chiamavano "popolino", esibendo il loro status non
solo materiale ma anche culturale. Per la nobiltà il lusso non era spreco un
obbligo sociale. L'aristocrazia siciliana è stata una casta impenetrabile, solo
quanto le ricchezze volavano e rimaneva il prestigioso nome si apriva ai nuovi
ricchi. I Florio che, da bottegai in meno di due generazioni divennero una
potenza economica europea, entrarono a gamba tesa nell'aristocrazia palermitana.
Ignazio Florio Jr. sposò Franca Jacona Notabartolo San Giuliano, Giulia Florio
sposó il principe Pietro Lanza Branciforte di Trabia e Butera. Vincenzo Florio
Jr ha sposato Anita Alliata di Montereale.
I
Monsù (monsieur), cuochi della nobiltà e del clero, erano tenuti in grande
considerazione dai loro committenti che gli davano del rispettoso Voi e alla
fine del pranzo li chiamavano per complimentarsi della bravura. Come i grandi
artisti non si concedevano al primo chiamo, dopo ripetuti chiami si presentavano
con inchino e un accenno a sorriso.
Ogni Monsú aveva un suo piatto esclusivo di cui teneva segreta la ricetta. Nel
palazzo avevano un alloggio riservato: quartu (l'appartamento) ru monsu. Erano
contesi dalla nobiltà a suon di quattrini, lo stipendio di Giuseppino (il
siciliano Giuseppe Lazzaro), monsù personale di Maria Carolina, era di 37
ducati. La raffinata Maria Carolina d'Austria influenzò i gusti
dell'aristocrazia siciliana che faceva di tutto per imitare i reali. Come il
cuoco secretum del principe del Rinascimento, seguivano i loro signori nelle
varie residenze e persino nei lussuosi alberghi europei dove cucinavano per
loro. Nelle cucine baronali, con i monsù sono arrivati nuovi piatti e tanti
vocaboli francesi: regoûts, patès, sufflès, glasse, maccheroni en croûte, pasta
brisé. I monsù, spesso scontrandosi con la cucina siciliana, seppero adottare e
arricchire il modello francese con i nostri aromi. i nostri prodotti ed i nostri
gusti. Qualche volta entravano in contrasto con la padrona come ricorda Renata Pucci di Benisichi in “Scusate la polvere”:
«Ma la lingua
si scioglieva in difesa del proprio operato, per discutere sulle regole di
cottura o l'amalgama delle dosi o la quantità del sale. Cessava il rapporto di
dipendenza e si apriva una disputa d'accademia: "Non si è mai sentito dire di
una pasta con le sarde con salsa di pomodoro", diceva altera mia zia, con un
piccolo ghigno di scherno. "Ma ci vogliamo mettere a fare la pasta con le sarde
come il popolino palermitano? Questa ci voleva!" "Voscenza mi permette, ma la
principessa Giuseppina la ordinava sempre cosi!" "Mi meraviglio per la
principessa" reagiva mia zia, giá battendo in ritirata».
Basile riporta quanto gli è stato riferito da Anna
Tasca Lanza: "Gli arrosti si poggiavano su un tovagliolo bianco di
Fiandra, rimboccato ai quattro angoli sul piatto di portata, la cima
dell'osso era nascosta da un cappello da chef in miniatura; i fritti
misti su una base di carta bianca, artisticamente sfrangiata lungo i
bordi, l'unica pietanza che si poggiava direttamente sul piatto di
portata era la pasta asciutta. I sughi e le salse venivano serviti a
parte, nelle salsiere d'argento o di maíolica. Da noi lo "spillungo" il
"fagotto", la "raviera" erano i nomi di questi piatti
di portata .
Il monsù Urna in casa Pennisi di Floristella ad
Acireale, preparava i complicati ramacchè che sono una variante dei
francesi ramaquins. Urna aprirà nel 1885 un ristorante a Viagrande (Ct)
dove si possono gustare le dorate pizze siciliane frítte, farcite con
tuma, acciughe e pepe. Il prestigioso "titolo di monsù" era riservato ai
cuochi dei nobili. I ricchi borghesi che ostentavano lusso e ricchezze
avevano solo i cuochi di paglietta". U n
grande cuoco di paglietta è stato Alfredo Senisi, cuoco secretum di
Ignazio Florio, che seguiva il signore nei suoi viaggi in Italia e
all'estero. n
grande cuoco di paglietta è stato Alfredo Senisi, cuoco secretum di
Ignazio Florio, che seguiva il signore nei suoi viaggi in Italia e
all'estero.
Sono stati i Monsù a creare nel 1700 la cucina baronale che si caratterizzava
non solo per la raffinatezza ed il gusto ma anche per l'elegante presentazione.
La loro arte si realizzava nella preparazione dei grandi pranzi. La scenografia
dei buffet era una splendida opera d'arte e di gola:
«Al disotto dei candelabri,
al disotto delle alzate a cinque ripiani che elevavano verso il soffitto lontano
le piramidi dei "dolci di
riposto" mai consumati, si stendeva la monotona
opulenza delle tables à thé dei grandi balli: coralline le aragoste lessate
vive, cerei e gommosi gli chaud-froids di vitello, di tinta acciaio le spigole
immense nelle soffici salse, i tacchini che il calore dei forni aveva dorato, i
pasticci di fegato grasso rosei sotto le corazze di gelatina, le beccaccie
disossate reclini su tumuli di crostini ambrati, decorati delle loro stesse
viscere triturate, le galantine color d'aurora, dieci altre crudeli, colorate
delizie. Alle estremità della tavola due monumentali zuppiere d'argento
contenevano il consommé ambra bruciata e limpido.”
(G. Tomasi di Lampedusa, II Gattopardo)
Il
monsù del Principe palermitano Fulco di Verdura era stato son solo a Parigi ma
anche a Londra, Verdura scrive: «Sapeva benissimo condizionare steak and kidney,
pie, yorkshire pudding ed altre specialità nordiche. Però durante il lungo
viaggio da Dover a Palermo questi piatti avevano subito metamorfosi linguistica,
sicchè il mince pie era diventato mezzosposo e lo strawberry fool, strabbifuoddi».
Antonino Alaimo monsù del principe della Cattolica per le gite fuori porta del
suo principe preparava la pizza rustica con la francese pasta brisè farcita con
ricotta, mortadella, caciocavallo,
pangrattato e prezzemolo.
Il prestigioso titolo di Monsù era riservato ai cuochi dei nobili. I ricchi
borghesi che ostentavano lusso e ricchezze avevano solo i cuochi di paglietta.
Un grande cuoco di paglietta è stato Alfredo Senisi, cuoco secretum di Ignazio
Florio che seguiva il suo signore nei suoi viaggi in Italia e all'estero.
________
Fonte: SPIGOLATURE STORICHE
SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 - gentile concessione del Prof. Schilirò per mimmorapisarda.it
|

|
 "Ti
faresti monaco?" gli domandò il principe, per chiasso. "Ci
staresti sempre, al convento?" "Sì," rispose egli, per
non dargliela vinta. "Ti
faresti monaco?" gli domandò il principe, per chiasso. "Ci
staresti sempre, al convento?" "Sì," rispose egli, per
non dargliela vinta.
"È bello stare a San Nicola!..." I monaci infatti facevano
l'arte di Michelasso: mangiare, bere e andare a spasso. Levatisi, la
mattina, scendevano a dire ciascuno la sua messa, giù nella chiesa,
spesso a porte chiuse, per non esser disturbati dai fedeli; poi se ne
andavano in camera, a prendere qualcosa, in attesa del pranzo, a cui
lavoravano, nelle cucine spaziose come una caserma, non meno di otto
cuochi, oltre gli sguatteri. Ogni giorno i cuochi ricevevano da Nicolosi
quattro carichi di carbone di quercia, per tenere i fornelli sempre
accesi, e solo per la frittura il Cellerario di cucina consegnava loro,
ogni giorno, quattro vesciche di strutto, di due rotoli ciascuna, e due
cafissi d'olio: roba che in casa del principe bastava per sei mesi. I
calderoni e le graticole erano tanto grandi che ci si poteva bollire
tutta una coscia di vitella e arrostire un pesce spada sano sano; sulla
grattugia, due sguatteri, agguantata ciascuno mezza ruota di formaggio,
stavano un'ora a spiallarvela; il ceppo era un tronco di quercia che due
uomini non arrivavano ad abbracciare, ed ogni settimana un falegname,
che riceveva quattro tarì e mezzo barile di vino per questo servizio,
doveva segarne due dita, perché si riduceva inservibile, dal tanto
trituzzare.
In città, la cucina dei Benedettini era passata in
proverbio; il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, le
arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i
crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare; e
pei gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i Padri avevano
chiamato apposta da Napoli don Tino, il giovane del caffè di Benvenuto.
Di tutta quella roba se ne faceva poi tanta, che ne mandavano in regalo
alle famiglie dei Padri e dei novizi, e i camerieri, rivendendo gli
avanzi, ci ripigliavano giornalmente quando quattro e quando sei tarì
ciascuno. Essi rifacevano le camere ai monaci, portavano le loro
ambasciate in città, li accompagnavano al Coro reggendo loro le
cocolle, e li servivano in camera se le LL. PP. si sentivano male, o si
seccavano di scendere al refettorio.
Lì il servizio toccava ai
fratelli: a mezzogiorno, quando tutti erano raccolti nell'immenso salone
dalla vòlta dipinta a fresco, rischiarato da ventiquattro finestre
grandi come portoni, il Lettore settimanario saliva sul pulpito e alla
prima forchettata di maccheroni, dopo il Benedicite, si metteva a
biascicare. Il giro della lettura cominciava dai più piccoli novizi
fino ai monaci più vecchi, per ordine d'età; ma una volta arrivato ai
Padri di fresca nomina , ricominciava per evitare quel fastidio ai
grandi, i quali se ne stavano comodamente seduti dinanzi alle tavole
disposte lungo i muri, sopra una specie di largo marciapiedi; l'Abate,
nel centro del gran ferro di cavallo, aveva una tavola per sé. I
fratelli portavano intanto attorno i piatti, a otto per volta, sopra
un'asse chiamata "portiera" che reggevano a spalla. , ricominciava per evitare quel fastidio ai
grandi, i quali se ne stavano comodamente seduti dinanzi alle tavole
disposte lungo i muri, sopra una specie di largo marciapiedi; l'Abate,
nel centro del gran ferro di cavallo, aveva una tavola per sé. I
fratelli portavano intanto attorno i piatti, a otto per volta, sopra
un'asse chiamata "portiera" che reggevano a spalla.
Distinguevansi i pranzi e i pranzetti, questi composti di cinque
portate, quelli di sette, nelle solennità; e mentre dalle mense
levavasi un confuso rumore fatto dell'acciottolio delle stoviglie e del
gorgoglio delle bevande mesciute e del tintinnio delle argenterie, il
Lettore biascicava, dall'alto del pulpito, la Regola di San Benedetto:
"... 34° comandamento: non esser superbo; 35°: non dedito al
vino; 36°: non gran mangiatore; 37°: non dormiglione; 38°: non
pigro..." La Regola, veramente, andava letta in latino; ma al
principino e agli altri novizi, aspettando che la potessero comprendere
in quella lingua, la spiegavano nella traduzione italiana, una volta il
mese.
 San
Benedetto, al capitolo della Misura dei cibi, aveva ordinato che per la
refezione d'ogni giorno dovessero bastare due vivande cotte e una libbra
di pane; "se hanno poi da cenare, il Cellerario serbi la terza
parte di detta libbra per darla loro a cena"; ma questa era una
delle tante "antichità" - come le chiamava fra' Carmelo -
della Regola. San
Benedetto, al capitolo della Misura dei cibi, aveva ordinato che per la
refezione d'ogni giorno dovessero bastare due vivande cotte e una libbra
di pane; "se hanno poi da cenare, il Cellerario serbi la terza
parte di detta libbra per darla loro a cena"; ma questa era una
delle tante "antichità" - come le chiamava fra' Carmelo -
della Regola.
Potevano forse le Loro Paternità mangiare pane duro? E la
sera il pane era della seconda infornata, caldo fumante come quello
della mattina. La Regola diceva pure: "Ognuno poi s'astenga dal
mangiare carne d'animali quadrupedi, eccetto gli deboli et
infermi"; ma tutti i giorni compravano mezza vitella, oltre il
pollame, le salsicce, i salami e il resto; e in quelli di magro il capo
cuoco incettava, appena sbarcato, e prima ancora che arrivasse alla
pescheria, il miglior pesce.
Molte altre "antichità" c'erano
veramente nella Regola: San Benedetto non distingueva Padri nobili e
fratelli plebei, voleva che tutti facessero qualche lavoro manuale,
comminava penitenze, scomuniche ed anche battiture ai monaci ed ai
novizi che non adempissero il dover loro, diceva insomma un'altra
quantità di coglionerie, come le chiamava più precisamente don Blasco.
Articolo vino, il fondatore dell'Ordine prescriveva che un'emina al
giorno dovesse bastare; "ma quelli ai quali Iddio dà la grazia di
astenersene, sappiano d'averne a ricevere propria e particolare
mercede". Le cantine di San Nicola erano però ben provvedute e
meglio reputate, e se i monaci trincavano largamente, avevano ragione,
perché il vino delle vigne del Cavaliere, di Bordonaro, della tenuta di
San Basile, era capace di risuscitare i morti.
Padre Currera,
segnatamente, una delle più valenti forchette, si levava di tavola ogni
giorno mezzo cotto, e quando tornava in camera, dimenando il pancione
gravido, con gli occhietti lucenti dietro gli occhiali d'oro posati sul
naso fiorito, dava altri baci al fiasco che teneva giorno e notte sotto
il letto, al posto del pitale. Gli altri monaci, subito dopo tavola, se
ne uscivano dal convento, si sparpagliavano pel quartiere popolato di
famiglie, ciascuna delle quali aveva il suo Padre protettore.
Padre Gerbini, la cui camera era piena di ventagli e d'ombrellini che le
signore gli davano ad accomodare, cominciava il giro delle sue visite;
Padre Galvagno se ne andava dalla baronessa Lisi, Padre Broggi dalla
Caldara, altri da altre signore ed amiche. Tornavano all'ave, per
entrare in chiesa, ma quelli che venivano un poco più tardi, o a cui
doleva il capo, se ne salivano direttamente in camera; e non già per
dormire, ché la sera, fino a tre ore di notte, quando si serravano i
portoni, c'erano visite di parenti e d'amici, si teneva conversazione,
molti Padri facevano la loro partita.
da
"I Vicerè", di Federico De Roberto
|

La cucina
|

Il Refettorio grande |
La cucina ha una forma poligonale con il punto di
cottura, al centro, facilmente raggiungibile da ogni angolo della sala.
Un vano “passa vivande” (foto in alto) la collega al refettorio con una
distribuzione degli spazi decisamente funzionale e innovativa. Proprio
sotto la cucina, le cantine custodivano ottimo, immancabile buon vino.
Luoghi dove esistono pochissimi simboli religiosi sostituiti da sfarzi
di ogni genere. In pratica un Hotel a 5 stelle dei tempi passati.
Comunque un gioiello.
VEDI IL SET FOTOGRAFICO DEI BENEDETTINI


Per il venerdì si seguiva lo schema dettato dalle regole di San.
Benedetto, che era così articolato: la cena delle occasioni particolari
iniziava con lo “scacciu”, mandorle, noci, nocciole da schiacciare al
momento, seguito sempre da una minestra di verdure e legumi. Ad essa
seguiva sempre un piatto a base di riso “Timbale o timballo” un
involucro di riso sapientemente farcito con aggrassato di carne. Il
secondo a base di pesce “tonnina” detto “Terza cosa”, e per i venerdì
fuori dalla Quaresima era prevista una “Quarta cosa”, generalmente un
piatto di sostanza a base di carne, come il celebrato falsomagro detto
bruciuluni o rollè. Fra il secondo di pesce e quello di carne veniva
servito il cosiddetto “Cunottu” una sorta di autentico stratagemma che
serviva a togliere il sapore del pesce e predisporre il palato al gusto
della “carne”. A chiudere la cena, poi, ci pensavano oltre a montagne di
cannoli, cassate e spumoni, le sfinge di pasta bognè (nient’altro che
delle bignole farcite con crema di mele e sciroppo di miele e arance).

L’autunno richiedeva ai monaci benedettini di seguire con solerzia le
ultime pratiche agrarie nelle varie tenute terriere, prima del grande
freddo e del letargo dei campi. In quei giorni si estraevano le forme di
pepato, caciocavallo e pecorino. Andando per le cucine del monastero dei
benedettini a Catania, potevano trovarsi ammonticchiate sacchi di iuta
pieni di lenticchie, fave e castagne, preziosa dispensa per i pasti
serali delle brutte stagioni.
In attesa della preziosissima risorsa dell’olio, orgoglio e sapienza
monastica, il mosto riposava nelle cantine. Questo è il periodo per
preparare le conserve di verdure ed i salumi. I frati spesso erano bravi
erboristi e cultori delle provviste di bosco raccoglievano funghi e
castagne, provvidenziale aggiunta per il refettorio in questo periodo.

L’antipasto, pietanza abbastanza elaborata da collegare al tornagusto
della cucina baronale, era molto vario. Fra i tanti vengono segnalati:
le sfogliatine con i fegatini, baccalà ripieno di mandorle, cutumè di
riso o ricotta, frittate di ricotta e mentuccia, polpette dal volume
inusitato, tocchi di caciocavallo.
 |
 |
 |
 |
|
Spiedini di
provola e caciocavallo.
Dosi per 4 persone, tempo di
preparazione: 15 minuti circa.
Ingredienti: Caciocavallo
stagionato: 400 gr Uova: 1 Pangrattato: q.b. Olio Extra
Vergine di Oliva: ¾ di bicchiere Sale q.b. Latte q.b.
Farina: quanta se ne prende
Preparazione: Tagliare il
caciocavallo stagionato e la provola a fette alte più o meno
2 centimetri e poi a cubetti tutti uguali. Bagnare i
cubetti nel latte, poi nella farina, quindi nell’uovo
sbattuto con un pizzico di sale e infine nel pangrattato.
Infilarli su 4 spiedini di legno e friggerli in abbondante
olio bollente.

I cutumè, tipici del catanese,
sono piccoli bignet fritti, farciti variamente e ricoperti
di zucchero, ed i cutumè, altri bignet, che hanno come
principale caratteristica la ricotta dell'impasto.
Ingredienti che peraltro troviamo in moltissimi dolci
siciliani: dalla cassata al cannolo, dalle "Sfinci di San
Giuseppe" alla cassata al forno. Ma da dove deriva il nome
cutumè? Ecco ancora un classico esempio della nostra antica
tradizione, che affonda le sue radici nel mondo ellenico: il
termine infatti viene da xùtos, ossia mucchietto,
fagottino.Bignet Ingredienti per 6 persone: 300 gr di
ricotta di pecora 3 uova intere 230 gr di farina OO Cannella
quanto basta Olio d'oliva extravergine 100 gr di miele.
Esecuzione: Passate la ricotta
a setaccio, aggiungete le uova, quindi la farina mescolando
continuamente fino a quando l'impasto risulterà consistente.
Dopo averlo lavorato, fatelo riposare per 3 ore circa. Fate
bollire in una padella a bordi alti abbondante olio, quindi
appiattite il composto, con un dito procurategli un buco al
centro e tuffatelo nella padella; quando sarà imbiondito
ritiratelo, disponetelo su un piatto di portata, conditelo
con il miele che nel frattempo avevate riscaldato e
spolverate con la cannella.
|
Pane fritto con
le uova
Ingredienti: 500g di pane
raffermo con tanta mollica,all'incirca 6 uova,olio per
friggere,sale,e facoltativo parmigiano
Preparazione: in una padella
mettete l'olio sopra e lo fate diventare caldo,prendete il
pane e lo tagliate a fette non troppo sottili,prendete un
contenitori e sbatteteci le uova se si vuole con il
parmigiano e un pizzico di sale,dopo prendete un'altro
contenitore e lo riempite d'acqua,prendete la fetta di pane
la inzuppate un po' nell'acqua non troppo il tempo che si
ammorbidisce giusto un po' non si deve rompere o essere
troppo inzuppato d'acqua,dopo invece passatelo nell'uovo e
giratelo stile cotolette e poi li friggete, mangiateli caldi
e non strafate con le porzioni perche' saziano molto.

Gateau di ricotta
ingredienti: 1
kg di ricotta di pecora 4 uova 200 gr di zucchero 1/4 di
fiala di vanillina 1 scorza di limone grattugiata 150 gr di
cioccolato fondente
Fare scolare almeno un giorno la
ricotta. Passarla la ricotta nel passa-verdura.
Incorporare lo zucchero, la
vanillina, il limone grattugiato, i tuorli e cioccolato
tagliato a pezzi
Montare a neve gli albumi e
aggingerli al composto e mescolare il tutto.
Imburrare la teglia e versare il
composto in maniera uniforme
Informare a 240° a forno
ventilato, appena prende colore mettere il forno statitico a
18o°
Lasciare raffreddare e poi
disporla nel piatto di portata

Scacciu o passatiempu in
dialetto siciliano è la frutta con guscio legnoso come noci
(nuci), noccioline (nuciddi), mandorle (miennuli), ceci
tostati (calia), semi di zucca seccati e tostati (simienza),
carrubbe o anche frutta secca come fichi, prugne, ecc.
|
Pagnotta ripiena
di ravioli di ceci
Gli ingredienti sono per 8/9
pagnotte. Sciogliere il lievito con 100 g d'acqua e un
cucchiaino di zucchero. Impastare il lievito con la farina,
4 cucchiai d'olio, il sale e circa 2 litri di acqua "morta"
(lasciata riposare per depositare l'eventuale calcare), non
aggiungendola tutta subito, ma poca per volta, controllando
la consistenza dell'impasto che deve risultare elastico.
Impastare bene e mettere a lievitare divisa in 8/9 pagnotte
per un'ora circa, cioè fino a quando la pasta raddoppierà di
volume. Trascorso il tempo, impastare brevemente ogni
pagnotta e, per aiutare la lievitazione, fare con il
coltello due doppi tagli incrociati. Lasciare il pane a
lievitare per un'ora circa, poi infornarlo nel forno a legna
coperto da carta stagnola per 20 minuti circa, togliere la
stagnola e proseguire la cottura per altri 15 minuti. Nelle
giornate molto umide, potrebbe essere necessario lasciare il
pane nel forno aperto per una decina di minuti ancora,
sottosopra. Volendo, aggiungere all'impasto una o due patate
lessate e schiacciate, diminuendo la quantità di acqua.

Filetto di baccalà in crosta di
mandorle con purea di scarola
Ingredienti per 4 persone Per il
baccalà 320 gr Baccalà, 1 albume, Acqua, 80 gr Mandorle
grattugiate, Olio extra vergine di oliva
Per la purea di scarola 1 kg
Scarola, 1 Cipolla, 1 spicchio Aglio, 1 Patata lessata, Olio
extra vergine di oliva, Sale, 40 gr olive di Gaeta
Procedimento: Il baccalà:
Ammollare il baccalà in acqua fredda per 24/48 ore. Togliere
dall’acqua ed eliminare la pelle. Tagliare il baccalà in 4
porzioni da 80 gr e rosolare in padella da ambo i lati per 1
minuto. Lasciare raffreddare e spennellare le superfici del
baccalà con l’albume sbattuto insieme a poca acqua. Passare
il pesce nelle mandorle grattugiate, premendo affinchè
aderiscano bene e avvolgano il pesce. Terminare la cottura
rosolando nuovamente il baccalà in padella con un filo di
olio per 5 minuti , girando per fare dorare entrambi i lati.
La purea di scarola: Pulire la
scarola, eliminando le foglie esterne più dure. Lessare in
acqua bollente salata per 5 minuti e scolare bene. In una
padella fare imbiondire la cipolla tritata insieme ad aglio
e peperoncino, aggiungere la scarola e la patata lessa
tagliata a pezzetti. Cuocere per 5 minuti e frullare il
tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.
Il piatto: Adagiare la purea di
scarola sul fondo del piatto da portata e disporvi sopra il
baccalà in crosta di mandorle. Decorare con qualche oliva
nera .
|
Sfogliatelle
di fegatini
ngredienti ricetta
(per 4 persone): 1 carota, 300 g di fegatini di pollo, 1
foglia di alloro, 1/2 scalogno, 3 cucchiai di sherry, 40 g
di burro, 8 vol-au-vent medi surgelati, sale, pepe,
carote, 1 fegatini di pollo, 300 g alloro, 1 foglia
scalogno, 0,5 sherry, 3; cucchiai burro, 40 g;
vol-au-vent, 8
Preparazione ricetta Mondate le
carote e lo scalogno e tritate entrambi
grossolanamente.Lavate con cura i fegatini (eliminando
eventuali parti sporche di fiele) e tagliateli a tocchetti.
Scaldate metà del burro nella
pentola a pressione, unite il trito di verdure, la foglia di
alloro e fate insaporire cuocendo a fiamma bassa per 5
minuti circa. Aggiungete i fegatini e bagnateli con lo
sherry. Mescolate per 3/4 minuti, poi, quando il liquore
sarà completamente evaporato, salate, pepate, aggiungete
qualche cucchiaio di acqua calda e chiudete la pentola con
il suo coperchio.Cuocete per 3 minuti contando il tempo a
partire dal sibilo.
Al termine, scaricate
completamente il vapore, aprite la pentola eliminate la
foglia di alloro, salate se necessario e aggiungete il burro
rimasto.
Con il composto riempite i
vol-au-vent e disponeteli sopra una teglia ricoperta con un
foglio di carta d'alluminio.
Infornate per 5 minuti nel forno
già caldo a 150° C e servite.

Olive condite.
500 g di olive
verdi in salamoia, 4 spicchi d'aglio, 1 cuore di sedano, 1
mazzetto di prezzemolo, 2 carote, 1/2 bicchiere d'aceto,
olio extra vergine d'oliva, origano, pepe.
Lavate e asciugate le olive,
poi battetele leggermente con il batticarne per aprirle, ma
senza rompere il nocciolo.
Dopo averle snocciolate tutte,
ponetele in un'insalatiera e conditele con l'aceto, l'aglio
e il prezzemolo tritati, il pepe e origano a piacere.
Aggiungete abbondante olio
extravergine d'oliva e mescolate con cura.
Riducete a rondelle le carote
pelate e il sedano in foglie, poi unite tutto alle olive.
Rigirate ripetutamente, affinché
gli ingredienti si distribuiscano bene e lasciate insaporire
per almeno 24 ore, prima di servire.
|

La prima pietanza dei rigidi mesi invernali era
sempre una minestra di legumi (lenticchie o fave) con aggiunta di pasta
(reginelle o rimanenze di pasta di semola).
A completare un filo d'olio extravergine, un trito
di finocchietto selvatico, bastavano così due tocchi a trasformare la
minestra in un ricordo indelebile.
Timbale di riso secondo le cassuerole di modelo
con oncie quattro di carne aggrassata. Il riso non poteva mancare sulle
tavole dei benedettini, oltre alle celebrate e mastodontiche arancine
dalla forma inusitata, compariva, spesso, come timballetto di carne
aggrassata.
|

 Reginette
con lenticchie, lardo e finocchietto.
Gr. 300 di spaghettini
spezzati, gr. 300 di lenticchie, 2 cipolle piccole, 1 costa
di sedano, 1 carota, 1 spicchio d’aglio,
gr. 200 di pomodoro pelato, gr. 50 di lardo, 1 ciuffo di
finocchietto di montagna, olio extravergine di oliva, sale,
pepe.
Ponete sul fuoco le lenticchie in circa
2 litri di acqua appena salata, aggiungete 1 cipolla
affettata, , mezza costa di sedano a pezzetti e la carota
tagliata a rondelle. Lasciate cuocere a fuoco basso per
circa 40 minuti. Quando le lenticchie saranno cotte
scolatele e mettete da parte l’acqua di cottura. Preparate
un battuto con il lardo, l’altra cipolla, la mezza costa di
sedano, lo spicchio d’aglio e il finocchietto lavato e
tritato.
Mettetelo a rosolare per circa 5 minuti,
in una pentola, con 4 cucchiai di olio; poi, aggiungete i
pomodori pelati e le lenticchie e lasciate insaporire il
tutto per alcuni minuti.
Aggiungete quindi l’acqua di cottura
delle lenticchie nella misura di circa 1 litro e mezzo e
portate a bollore. Buttate giù, a questo punto, gli
spaghettini spezzettati e portateli a cottura.
Trasferite la minestra nella zuppiera e
servite calda.
Timballo di riso ripieno di carne
grassata.
Il "timballo di riso" è un tipico primo piatto
natalizio della Sicilia orientale. Gli ingredienti sono:600
grammi di riso vallone, una gallina con le uova nonnate,
300 grammi di polpette di carne di vitello trita,
200 grammi di tuma, 150 grammi di pecorino col pepe
stagionato grattugiato, sei uova fresche, 150 grammi
di caciocavallo di provola fresco, 150 grammi di cotenna
di maiale, 200 grammi di salsiccia di maiale, quattro
pomodori pelati, 50 grammi di estratto di pomodoro,
due cipolle medie, due gambi di sedano, un trito
di aglio e prezzemolo, 50 grammi di mollica di pane,
50 grammi di pan grattato, una spruzzata di latte,
burro o strutto, olio d'oliva, sale e pepe.
Una prima fase della ricetta prevede la
preparazione del brodo di gallina insaporito con la cipolla,
poco pomodoro, prezzemolo e sedano e le polpette
precedentemente preparate impastando la carne di vitello - o
di manzo - trita con uova, formaggio pecorino grattugiato,
prezzemolo e aglio tritato, mollica di pane ammorbidita nel
latte, sale e pepe. Quando la gallina è ben cotta, la si
toglie dal brodo, la si priva di pelle ed ossa e la si
divide in pezzettini che poi si conservano insieme alle
polpette lessate. Si filtra il brodo e lo si riporta in
ebollizione aggiungendo il sale. Qui si cuocerà il riso al
dente. A cottura ultimata, occorre mantecare il riso denso
con il pecorino grattugiato. Umettare una teglia con burro e
pan grattato e stendere il primo strato di riso che deve
esser alto due centimetri.
Su esso occorre stendere pezzetti di
gallina, popettine, le uova nonnate lesse e fettine di tuma.
Si aggiunge un secondo strato di riso e poi si le
polpettine, salsiccia e pezzi di caciocavallo di provola; se
si vuole, prima della seconda fascia di ripieno si può
stendere un velo di ragù. Si ricopre il tutto con un
ulteriore strato di riso che sarà a sua volta coperto con la
"conza", una salsa di uova battute, pecorino grattugiato,
sale e pepe. La pietanza va infornata e la cottura sarà
ultimata quando il piatto avrà ottenuto una crosta dorata e
compatta.

Fra i
tanti secondi a base di pesce mangiati in convento viene segnalato lo Sfoglio di
erbette con tonnina. Foglia di erbetta, cipolla in agrodolce, e tonno detto “Surru”,
dal gusto dolce, come risulta nei registri “ Straordinari”.


Dadi
di tonno con erbe cipolla e alloro,
adagiati
su un leggero amnto di pasta bresina. Di seguito una ricetta
analogoa: 4 tranci di tonno freschissimo 3 rametti di
rosmarino , alloro, 8 foglie di salvia fresca 1
rametto di timo
3 cucchiai di pangrattato
1 spicchio di aglio 3 cucchiai di olio extravergine
d'oliva sale e pepe q.b.
Lavate e asciugate molto bene le
erbe aromatiche, pulite l'aglio e tritate finemente tutto
con un coltello o un mixer. Unite il trito aromatico al pan
grattato (se si vuol preparare un tonno più speziato e
particolare sostituite il pangrattato con semi di sesamo o
nocciole finemente tritate) aggiungete sale e pepe,
mescolate bene poi passate nella panure il tonno (da
entrambi i lati) premendo bene per far aderire il composto
al pesce.
In una capiente padella fate
scaldare l'olio, aggiungete il tonno e fatelo cuocere 3
minuti per lato a fuoco moderato per evitare che la panure
si bruci e diventi amara. Bastano pochi minuti per cuocere
il tonno che dovrà risultare rosa all'interno.. se cotto
troppo la carne del tonno sarà troppo asciutta.
Servite il tonno con
insalata mista, pomodori o verdure di stagione.
Fra il secondo di pesce e quello di carne veniva servito il
cosiddetto
“Cunottu” (conforto)
una sorta di autentico stratagemma che
serviva a togliere il sapore del pesce e predisporre il
palato al gusto della “carne”.

(vietata nei venerdì di Quaresima")
Quello che colpisce di questo celebrato piatto, così come
rallegra, e seduce è l'aggressività. Non è un corteggiamento romantico quello
ingaggiato dalla cucina siciliana. Via con il primo assalto ai sensi: un manto
di carne avvolge un ripieno di capuliato (tritato: rigorosamente misto di carne
di maiale e vitello) nel quale accennano la loro presenza, sedani, carote e uova
sode, il tutto inebriato da buon vino cotto, rossissimo strattu di pomodoro, e
del buon basilico fresco.
Diventa un sapore che strappa la nostra attenzione da
tutto quanto il resto; diventa un intreccio di profumi che racconta un pezzo di
mondo e di storia dell’isola. Il falsomagro siciliano è dunque il barocco del
gusto, quello che dà l'impronta alle tante splendide città del sud: poi ci sono
i cassettoni, le statue, le volte.


Falsomagro di vitello con uova di
quaglia.
800 gr di fesa di manzo aperta a libro 200 gr di
mortadella 100 gr di macinato di manzo 1 salsiccia di maiale
60 gr di grana grattugiato 1 uovo fresco 100 gr di piselli
lessati 150 gr di scamorza affumicata a fettine 4 uova di
quaglia sode 1 spicchio d'aglio 1/2 cipolla bianca 100 g. di
pistacchi, estratto di pomodoro, 1 bicchiere di vino bianco
olio q.b. burro q.b. sale q.b.
In una ciotola mescolate il macinato di
manzo con la salsiccia privata del budello, il grana, l'uovo
fresco e i piselli e un pizzico di sale. Stendete sul piano
da lavoro la fesa di manzo e farcitela con uno strato di
mortadella e con le fettine di scamorza affumicata. Spalmate
la farcia preparata sopra alle carni e inserite quindi al
centro anche le 4 uova di quaglia sode sgusciate premendole
leggermente verso il basso. Richiudere la carne avvolgendela
su se stessa e legando l'arrosto con dello spago da cucina.
In una padella capiente preparare un
soffritto di aglio e cipolla con un paio di cucchiai di olio
e rosolate l'arrosto su tutti i lati. Aggiustate di sale e
sfumate con il vino, poi aggiungete l'estratto di pomodoro e
un bicchiere di acqua calda. Continuate la cottura per circa
80-90 minuti aggiungendo altra acqua se necessario.
Fate intiepidire leggemente l'arrosto
prima di tagliarlo, affettatelo e servitelo con il suo
sughetto cospargendolo con i pistacchi
Tortino di patate
(ricetta analoga):
Sbucciate le patate, lavatele, tagliatele a tocchetti e
cuocetele al vapore per circa 15 minuti. Schiacciatele
attraverso uno schiacciapatate e trasferite la purea in una
ciotola.
Unite il burro a fiocchetti e lo
zucchero e mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo.
Sbucciate le mele, eliminate il torsolo e tagliatele a
fettine sottili. Separate i tuorli dagli albumi e unite i
primi all’impasto.
Montate a neve gli albumi con un pizzico
di sale e mescolate con movimenti dal basso verso l’alto.
Versate l’impasto in una teglia rettangolare rivestita con
carta da forno in modo da ottenere uno spessore di circa 2
centimetri e cuocetela torta in forno preriscal

I
monaci del convento sono riusciti, sapientemente, a conservare e tramandare
un’impressionante molteplicità di ricette. Il rituale religioso ha da sempre
influenzato le abitudini alimentari della città. Così uova, mandorle, zucchero,
e crema di latte hanno dato vita allo spumone di mandorle detta “cubbaita”,
dolce del periodo baronale siciliano. Esso veniva sempre servito alla fine dei
pasti, rigorosamente accompagnato dalla liffia, una struggente crema di
cioccolato.


Semifreddo
alle mandorle con crema di cioccolato
Ingredienti (12 porzioni): base - 130 g
di farina - 4 uova - 90 g di zucchero di mele farcia - 250 g
di ricotta - 200 g di Philadelphia yo - 20 g di
farina di mandorle - 30 gocce di dolcificante liquido
copertura - 200 g di cioccolato fondente senza zucchero (io
utilizzo chocolight fondente Venchi) - 3 o 4 porzioni di
burro di cacao Venchi - mandorle intere e a fettine per
decorare q.b.
Preparazione: Per preparare la base,
separare i tuorli dagli albumi. Montare gli albumi con lo
zucchero di mele (1) e, quando saranno spumosi, aggiungere
la farina setacciandola per evitare di fare grumi (2).
Montare gli albumi con un pizzico di sale (3) e incorporarli
al composto di tuorli e farina con movimenti dal basso verso
l'alto per non smontare gli albumi (4). Versare il composto
nella teglia e livellarlo (5). Io ho utilizzato la teglia In
Forma di Pavonidea che ha il fondo in ceramica e la parte
superiore in silicone. Dopo la cottura la parte in silicone
si smonta e il dolce è già su un piatto da portata.
Infornare a 180° per 15 minuti circa, fino a quando la
superficie sarà ben dorata. A questo punto, montare la
ricotta con la philadelphia yo e con le gocce di
dolcificante fino a ottenere un composto cremoso (6).
Aggiungere a questo la farina di mandorle e amalgamare bene
(7). Quando la base si sarà raffreddata, spalmare e
livellare la crema sulla base (8). Metterla in frigo in
attesa della copertura.
Per la copertura di cioccolato,
utilizzare un fondente al 70%, possibilmente senza zuccheri
aggiunti e fonderlo insieme a 3-4 porzioni di burro di cacao
Venchi (9). Più burro userete e più morbida sarà la
copertura, ma non preoccupatevi di esagerare perché il burro
di cacao non contiene colesterolo! Una volta sciolto il
cioccolato (10) al microonde alla minima potenza e
mescolando di tanto in tanto, spalmarlo sulla superficie
della torta e decorare con le mandorle intere e a fettine
(11). Quando il cioccolato si sarà solidificato, sarà
possibile togliere la parte in silicone della teglia (12) e
servire.
Bignole fritte condite con giuleppo:
sciroppo di mele e fiori di arancio (i benedettini
impararono l’arte del giuleppo dalla medicina araba)
Mescolare la farina, il sale e l'arrow
root; aggiungere la birra e far riposare la pastella in
frigo per 30 minuti. Tagliare le mele a rondelle spesse,
passarle nella farina, poi nella pastella e metterle a
friggere in una padella con dell'olio bollente. Servire i
bignè di mele caldi, con dello zucchero a velo.

La ricostruzione del
menù benedettino è stato reso possibile grazie al documento
dell'Istituto Alberghiero Karol Woytyla.
http://www.ipssar.eu/joomla/images/stories/doc_2009-10/approfondimenti_menu.pdf
|
|

|
La
donna che diede origine ai Biscotti della Monaca
di
Giuseppe Lazzaro Danzuso
(La
Sicilia, 8.1.2008)
Quando
Mara Messina morì, il 14 di agosto del 1907, il cordoglio si sparse per
le strade di Catania rapido come l’inconfondibile profumo dei suoi
biscotti all’anice, ancor oggi rinomati in tutta la Sicilia. E fu con un’affettuosa
gratitudine che i catanesi si recarono a rendere l’ultimo omaggio alla
donna che aveva saputo portar fuori dal convento, quasi come Prometeo con
il fuoco, il segreto di dolci semplici e gustosi. Un sentimento conservato
quasi intatto fino a oggi che ricorre il centenario della scomparsa della Monaca dei viscotta d’a
monica. Sì, perché fu proprio
Mara Messina, nella Catania degli ultimi decenni dell’Ottocento, a
metter su con la nipote Rosaria Di Mauro, che avrebbe poi sposato Giovanni
Arena, una piccola rivendita di biscotti in via Mancini, proprio dietro la
Piazza dell’Università, dove ancor oggi si trova un punto vendita della ditta. profumo dei suoi
biscotti all’anice, ancor oggi rinomati in tutta la Sicilia. E fu con un’affettuosa
gratitudine che i catanesi si recarono a rendere l’ultimo omaggio alla
donna che aveva saputo portar fuori dal convento, quasi come Prometeo con
il fuoco, il segreto di dolci semplici e gustosi. Un sentimento conservato
quasi intatto fino a oggi che ricorre il centenario della scomparsa della Monaca dei viscotta d’a
monica. Sì, perché fu proprio
Mara Messina, nella Catania degli ultimi decenni dell’Ottocento, a
metter su con la nipote Rosaria Di Mauro, che avrebbe poi sposato Giovanni
Arena, una piccola rivendita di biscotti in via Mancini, proprio dietro la
Piazza dell’Università, dove ancor oggi si trova un punto vendita della ditta.
Da allora i viscotta d’a monica sono i biscotti dei catanesi per
antonomasia. Se volessimo esagerare potremmo dire che i cromosomi del
cittadino marca liotru hanno forma di esse, un color mielato scuro e... un forte odore d’anice.
La ricetta dei viscotta rimane però ancor oggi segretissima: la famiglia
Arena non ne vuol sapere di rivelarla. Ma si può ipotizzare che siano a base di
farina, strutto e semi d’anice, visto che dolci simili, di cui è nota
la ricetta, vengono preparati anche a Cefalù e sulle montagne di Pistoia. Di certo c’è che sono
inconfondibili: per il profumo, la forma a esse, per il crocchiare quando
vengono addentati.
E perché, come le ciliege, non ci si stanca mai di mangiarne (qualcuno
sostiene addirittura siano digestivi). Quel che comunque ci preme non è
parlare dei viscotta d’a monica, è tentare di ricostruire la vicenda umana della Monaca
stessa: Maria Messina, meglio nota come Mara.
Un’operazione non certo semplice, a distanza di tanto tempo e con fonti
estremamente ridotte. Sappiamo che Mara nacque nel 1847, anche se sono
ignoti giorno e mese, non segnati sulla sua tomba, nel cimitero di
Catania. E proprio in quell’anno lo scrittore e illustratore inglese
Edward Lear, celebre per i suoi limerick e il nonsense, durante il suo
viaggio in lungo e in largo per il Regno di Napoli realizzò un disegno -
a penna, inchiostro e gouache - che ci rimanda un’immagine di Catania
incorniciata di nere lave e fichidindia e con il classico sfondo del
vulcano. Ma quel che colpisce, paragonandola a recenti immagini
fotografiche scattate dalla stessa posizione scelta dal britannico per
inquadrare il paesaggio, è quanto piccola fosse allora la città: appena
un borgo, all’ombra del cupolone della cattedrale.
 Bisogna aggiungere poi che quello era un periodo non solo di grandi
fermenti politici, ma anche di grande fervore religioso per la città ai
piedi dell’Etna: nello stesso anno sarebbero nate anche Giuseppina Faro,
nobildonna meglio nota come Beata Peppina, nella vicina Pedara, e, in
Piemonte quella madre Maddalena Morano, che qui si sarebbe spenta in odore
di santità.
Bisogna aggiungere poi che quello era un periodo non solo di grandi
fermenti politici, ma anche di grande fervore religioso per la città ai
piedi dell’Etna: nello stesso anno sarebbero nate anche Giuseppina Faro,
nobildonna meglio nota come Beata Peppina, nella vicina Pedara, e, in
Piemonte quella madre Maddalena Morano, che qui si sarebbe spenta in odore
di santità.
Fu in questa Catania minuscola che cercava di far convivere sentimento
religioso e Garibaldi - come descritto da quello straordinario affresco
del periodo che è "I Viceré" di De Roberto - che Mara crebbe,
con un destino segnato dalla mancata primogenitura. Infatti, per evitare
di frazionare il patrimonio di famiglia in onerose doti, anche lei fu mandata, come si usava allora, in convento.
Per la precisione in quello di Santa Chiara, in via Garibaldi, che aveva
la facoltà di conferire l’abito religioso a chi decideva d’ispirarsi
alla Regola dell’allora terz’ordine Francescano. Dopo un periodo di
formazione e di approfondimento spirituale e culturale - ma, come vedremo,
anche di lavoro - nei conventi, queste giovani donne si impegnavano a
vivere la vocazione anche all’esterno dell’edificio religioso,
rientrando in famiglia e diventando "monache di casa" o
bizzocche (non tragga in inganno il termine, oggi sinonimo di bacchettone,
baciapile: un tempo indicava appunto il terziario francescano).
Mara, dunque, entrò giovanissima in convento, a imparare l’arte della
spiziali. Infatti, come ricorda Antonio Uccello nel suo "Pani e dolci
di Sicilia", "...Gran parte nell’arte dolciaria veniva svolta
dai monasteri, che fin dal medioevo detenevano gli strumenti e il
privilegio della panificazione". Erano i conventi, prima del 1860, le
dolcerie delle città siciliane. E, per le feste comandate, sfornavano ’nguanteri
di squisite specialità da distribuire a nobiltà e clero. E anche a
qualche ricco borghese.
Ecco perché le più apprezzate monache erano le cosiddette spiziali.
Coadiuvate dalle zitidduzzi di la badia, converse non legate da voti, che
per sfuggire alla fame erano state affidate dai genitori ai conventi, dove sin da
piccolissime venivano addestrate all’arte della pasticceria. Un uso
tramandatosi fino al secolo appena trascorso a leggere il recente
"Mandorle amare", della scrittrice americana Mary Taylor Simeti,
dedicata all’ericina Maria Grammatico, dolciera nota in tutto il mondo e
che apprese le ricette nell’Istituto San Carlo, dove venne condotta da
bambina.
Ma torniamo a Mara Messina e al suo noviziato, anche da spiziali, nel
convento di Santa Chiara. Sull’argomento non abbiamo che poche e
frammentarie notizie che ci vengono dalla famiglia, che possiamo però tentare di inquadrare
nella storia di quel periodo.
Quando, nel 1860, cominciò la vendita dei beni ecclesiastici da parte
dello Stato - e le suore senza rendite furono costrette a lasciare i
conventi, facendo crescere in maniera esponenziale il numero delle "monache di casa" - Mara
aveva soltanto tredici anni, e, con ogni probabilità, era da poco entrata
a Santa Chiara, che continuava a essere il "posto dei dolci" a
Catania. E’ certo che nel convento si producessero, oltre ai biscotti a
forma di esse, gli ’nzuddi - in italiano suonerebbe come "vincenzini"
-, così chiamati poiché furono le suore Vincenziane a produrre per prime
questi biscotti secchi profumati con scorza di arancia e anice e decorati
con mandorle. Un’altra delle ricette "esportate" da Mara.
’Nzuddi e viscotta d’a monica rientravano nella categoria dei dolci
"di riposto" o "di credenza", ossia la biscotteria
secca. Ma nella Catania della fine dell’Ottocento, anche per la notevole richiesta seguita a un certo benessere economico, i
produttori cominciarono a fornire dolci sempre più elaborati. Uno dei più rinomati "confettieri" etnei del periodo era
Rosario Amato, che inviava ai propri clienti, antesignani dei moderni
depliant pubblicitari, fogli vergati a mano con descrizione e prezzo delle
specialità: frutte candite, frutte alla Martorana assortiti - con
varianti pasta reale cotta e pasta di mandorle imitazioni frutti - rame di
Napoli, mustaccioli alla napolitana, sussamele alla Sapienza, e,
naturalmente, cassate.
Gli affari andavano talmente bene per chi si lanciava nel ramo dolciario
che tutti a Catania erano alla ricerca dei ricettari dei cosi duci di la
batia, come li definì nella poesia omonima, il poeta palermitano Giovanni Meli. Così Rosaria,
ventenne nipote di Mara - che, morti i genitori, viveva in casa della
sorella maggiore, sposata a un Di Mauro -, cominciò a cutturiari, a
cuocersi a fuoco lento, la z’a monica. Voleva cercare di convincerla a
far concorrenza a Rosario Amato sfruttando le ricette imparate in convento. Ci furono, probabilmente, parecchie
resistenze da parte della zia, che non doveva godere di una buona salute.
A questa deduzione si giunge osservando con attenzione una d elle due
immagini rimasteci della Monaca. La prima è un bel ritratto a olio
eseguito un anno prima della sua morte che ce la rimanda florida e
composta, in posa ieratica con un messale in mano. L’altra è la foto
della Monaca dei viscotta d’a monica esposta nel negozio Arena di via
Mancini. Ed è analizzando al computer quest’immagine che si scopre come
la folta chioma della z’a monica sia in realtà un ritocco: i capelli
furono aggiunti a carboncino. La povera Mara, che non era certo una
bellezza, era insomma anche calva. Cosa, a sentire i medici, abbastanza
comune in quell’epoca in cui imperversavano tifo e infezioni intestinali
che, in assenza di antibiotici, finivano sempre per cronicizzarsi. elle due
immagini rimasteci della Monaca. La prima è un bel ritratto a olio
eseguito un anno prima della sua morte che ce la rimanda florida e
composta, in posa ieratica con un messale in mano. L’altra è la foto
della Monaca dei viscotta d’a monica esposta nel negozio Arena di via
Mancini. Ed è analizzando al computer quest’immagine che si scopre come
la folta chioma della z’a monica sia in realtà un ritocco: i capelli
furono aggiunti a carboncino. La povera Mara, che non era certo una
bellezza, era insomma anche calva. Cosa, a sentire i medici, abbastanza
comune in quell’epoca in cui imperversavano tifo e infezioni intestinali
che, in assenza di antibiotici, finivano sempre per cronicizzarsi.
Nonostante fosse provata nel fisico, però, Mara infine - anche perché la
nipote era diventata un’insopportabile virrina, un succhiello capace di
trapanare il cervello ripetendo sempre la stessa richiesta - cedette. E
oltre a rivelare a Rosaria il segreto della preparazione di viscotta d’a
monica, ’nzuddi, piparelli eccetera, la aiutò per molti anni, rimanendo
però sempre dietro le quinte. Così, quando dal forno di via Mancini
cominciava a spandersi per le strade del centro l’odore paradisiaco dei
viscotta d’a monica, i catanesi accorrevano con i soldi in mano. Anche
perché avevano scoperto che, pestati nel mortaio, ridotti in polvere e
mutati in pappa, quei biscotti assolvevano in maniera eccellente alla
funzione di far crescere belli e sani i bambini e a irrobustire anziani e
ammalati. Quando poi ci sono di mezzo bimbi e vecchietti, vien facile informarsi della salute, stringere rapporti che
diventano di familiarità, d’affetto. E, anche se la z’a monica
rimaneva sempre celata a preparar biscotti, senza rapporto con il
pubblico, di lei non si poteva non parlare.
 Così, il giorno prima del ferragosto del 1907, la scomparsa di Mara
Messina colpì la città, già stordita dall’afa. Quando la notizia
prese a circolare, le bocche si torcevano in quelle caratteristiche smorfie di dispiacere che i catanesi
riservano ai lutti più pesanti. A portarsi via Mara, all’età di
sessant’anni - ma allora si invecchiava decisamente prima - fu
probabilmente l’ennesima infezione intestinale, aggravata dall’afa
terribile di quei giorni. Morì, dunque. Ma il suo ricordo è, ancor oggi,
vivo nei catanesi. Qualcuno tra i più anziani giura persino di aver
conosciuto personalmente la Monaca, ma in realtà parla di Rosaria Arena,
agguerrita antesignana delle donne imprenditrici etnee, morta nel 1943 all’età
di 82 anni. Così, il giorno prima del ferragosto del 1907, la scomparsa di Mara
Messina colpì la città, già stordita dall’afa. Quando la notizia
prese a circolare, le bocche si torcevano in quelle caratteristiche smorfie di dispiacere che i catanesi
riservano ai lutti più pesanti. A portarsi via Mara, all’età di
sessant’anni - ma allora si invecchiava decisamente prima - fu
probabilmente l’ennesima infezione intestinale, aggravata dall’afa
terribile di quei giorni. Morì, dunque. Ma il suo ricordo è, ancor oggi,
vivo nei catanesi. Qualcuno tra i più anziani giura persino di aver
conosciuto personalmente la Monaca, ma in realtà parla di Rosaria Arena,
agguerrita antesignana delle donne imprenditrici etnee, morta nel 1943 all’età
di 82 anni.
Per concludere: si parla, in questi giorni, di tre busti da dedicare ai
catanesi illustri nei viali della Villa Bellini. Beh, perché non
considerare anche la candidatura di questa "monaca di casa" entrata grazie ai suoi biscotti,
nella memoria collettiva dei catanesi? Gli altri biscotti delle monache
Popiglio, sulle montagne pistoiesi, si prepara un biscotto che ha per
ingredienti solo farina di grano, zucchero, acqua, semi di anice e
bicarbonato di ammonio. Ma non hanno la forma a esse dei viscotta d’a
monica catanesi. Pur avendo il medesimo colore hanno forma di fette di
pane spesse circa un centimetro. E venivano un tempo preparate nei
conventi della zona.
Spiega chi oggi li produce che il vero segreto per preparare questi
biscotti sta nei quantitativi degli ingredienti e nelle modalità di
esecuzione e cottura.
Altri viscotta d’a monica siciliani sono i "Biscotti della Monaca
Catalfamo", che Vincenza Collotti Genchi, una signora della buona
borghesia di Cefalù, ricevette nella seconda metà dell’Ottocento dalla
suddetta religiosa e trascrisse nel suo ricettario. Poi messo in rete, su
Internet, da un suo pronipote. Per realizzare i biscotti, scrive la
signora, occorrono un rotolo farina majorca, due once e mezza zuccaro
fino, due once meno una quarta sajme, due once e mezza levito cimino
quanto vuoi.
"Rosaria Di Mauro Arena era un masculazzu". Così la pronipote,
Teta Arena, definisce la bisnonna Rosaria, che avviò l’impresa di
famiglia negli ultimi decenni dell’Ottocento nel forno di via Mancini. E
dal ritratto fotografico - risalente con ogni probabilità al periodo tra
le due guerre mondiali - risulta evidente il piglio deciso della donna. Di
una bellezza austera, non molto alta ma sempre eretta, con occhiali
rotondi che accentuavano la severità dello sguardo, gli abiti sempre
scuri, i candidi capelli tirati all’indietro, sembrava una religiosa.
Così trascorsi diversi anni dalla morte di Mara Messina, molti finirono
con il credere che la Monaca dei viscotta d’a monica fosse Rosaria. E
lei non fece mai nulla per chiarire l’equivoco.
Teta Arena, che manda avanti l’azienda di famiglia con il fratello Gipi,
conosce la bisnonna soltanto attraverso i racconti del nonno Giuseppe, l’ultimogenito,
che portava lo stesso nome del primo figlio, morto in tenera età. Da quei
ricordi emerge il ritratto di una donna forte, una carabinera a cavaddu,
un monarca assoluto che mantenne serrate le redini della famiglia anche
prima di rimanere vedova, poco dopo aver partorito, a 50 anni (un record
per quei tempi), l’ultimo dei sei figli.

Rosaria Di Mauro maritata Arena era religiosissima ma con grande senso
degli affari, in periodi in cui il lavoro e ancor più l’impresa erano
prerogative esclusivamente maschili, aveva preteso di registrare a proprio nome l’azienda nella
Camera di Commercio di Catania, probabilmente l’unica intestata a una
donna, in quel periodo. Era una donna capace di comandare a bacchetta sia
i figli (compreso Ignazio, Monsignore della Collegiata, morto sei anni
prima della madre) sia i dipendenti: le venti lavoranti che, tutte attorno
a un enorme tavolo, confezionavano a mano i biscotti a esse inanellando
canzoni e proverbi popolari.
Per donna Rosaria, poi, i fornitori avevano un grande rispetto, a
cominciare dal fido carrettiere che, partendo da Nicolosi, riforniva
periodicamente l’azienda di ginestra secca per alimentare il forno a
pietra. O da coloro i quali portavano i semi d’anice, prodotti allora
nel Nisseno.
C’era un’unica persona di cui Rosaria si fidava: la sorella
Concettina, che l’aiutava a mandare avanti l’impresa. Un’altra
Concettina, la nuora Concetta, era invece al suo fianco quando morì, a 82 anni, il 13 maggio del 1943 a
Cantello,
un paesino del Varesotto al confine con la Svizzera, in cui gli Arena
erano sfollati.
E lì, sotto le Alpi, riposa ancora.
 |
|

IL TIMBALLO
DEL GATTOPARDO
In Sicilia il timballo sembra avere radici nel patè di maccheroni. Il domenicano
francese Labat Jean- Baptiste, giunto in Sicilia nel 1711 invitato da un nobile
siciliano, nel suo Vojage en Espagne et Italie, Amsterdam 1731 scrive: “Non
avevo mai visto un patè di maccheroni, e d'altronde non è un piatto per tutte le
bocche. I maccheroni erano stati cotti in un brodo di latte di mandorle
zuccherato e ambrato, una finissima polvere di cannella, della vera uvetta di
Corinto, dei pistacchi del Levante delle scorze di limoni, i salamini più
delicati, e guarniti con pasta di Genova. Si trattava di un autentico "boccone
di cardinale". Ho trovato questi maccheroni eccellenti, e se ce ne avessero
offerto di simili al convegno non avrei avuto troppa difficoltà a farci
l'abitudine”.

Sono convinto che l'alta cucina, sia proprio quella popolare che con materie
povere e spesso di scarto realizza piatti semplici ma saporiti dove trionfa il
gusto naturale e non il gusto culturale.Gli scrittori siciliani hanno esaltato l'abilità dei Monsù. Gaston era il monsù
di casa Tomasi di Lampedusa, dove era gradita la cucina francese, a lui si deve
il noto timballo di maccheroni: «L'oro brunito dell'involucro, la fragranza di
zucchero e di cannella che emanava non era che il preludio della sensazione di
delizia che si sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta.
Nel timballo è inconsueta la presenza tutta francese del tartufo, chiamato in
Sicilia “tirituffalu”, che si trova nei nostri boschi. I porcari lo regalavano
ai padroni dei terreni dove razzolavano i m aiali che lo mangiavano ma non
entrava in cucina. Il tartufo si trova anche nelle mense dei monaci Benedettini
di Catania.
Una varietà dell'aristocratico timballo era la popolare pasta 'ncasciata farcita
in vario modo e cotta, fino a pochi decenni fa con grande perizia, focu supra e
focu sutta. Il tegame veniva messo sulla
brace (focu sutta) e chiuso con un coperchio pieno di brace (focu supra)
realizzando un ingegnoso forno a cielo aperto.
Anche i
Romani avevano il loro timballo, Apicio ne dà la ricetta, era costituito da
sfoglie di lagana alternate a carne e cotto al forno.
________
Fonte: SPIGOLATURE STORICHE
SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne editrice 2019 - esclusiva
concessione del Prof. Schilirò per mimmorapisarda.it/cucina.htm

I pranzi del Gattopardo
QUI
PER LA RICETTA
Tortina Tomarchio, buona e genuina come fatta in casa
Da 60 anni la Tomarchio di Misterbianco produce la "brioscina
di Catania" per antonomasia. Il segreto? Ingredienti semplici e
lavorazioni artigianali
A Catania c'è chi ancora la definisce "il dolce della
domenica", anche se i più ormai la chiamano semplicemente "la brioscina".
Stiamo parlando della Tortina Tomarchio, un prodotto da forno e un
marchio che in 60 anni di vita sono entrati stabilmente nel cuore e
nelle abitudini quotidiane di una intera provincia, quella di Catania
appunto, anche se gli estimatori fuori dalla Sicilia sono in crescita
esponenziale.
Basti pensare che la Compagnia Dolciaria Tomarchio di
Misterbianco vende annualmente oltre 25 milioni di tortine soltanto nel
catanese, un territorio che tra capoluogo e dintorni non supera i
500mila abitanti. E il successo è tale che si sta allargando anche al
resto dello Stivale. L'azienda prevede infatti di chiudere il 2017 con 3
milioni di merendine distribuite nel Nord Italia.
"E' un prodotto che ci rappresenta - dice
Massimiliano Stanco di Tomarchio – e di cui andiamo orgogliosi. La
nostra gioia più grande è sapere che, proprio grazie a questo dolce, il
marchio Tomachio è diventato sinonimo di qualcosa di genuino e di
qualitativamente alto. E' un risultato che premia la nostra scelta di
rinunciare in toto alla chimica e ai conservanti per puntare invece
sull'eccellenza delle materie prime e sull'artigianalità delle
lavorazioni".
Non a caso l'azienda si è sempre attenuta fedelmente
alla ricetta originale della "brioscina" che, da 60 anni a questa parte,
prevede gli stessi ingredienti, quelli semplici che ogni mamma utilizza
nella cucina di casa per preparare i dolci per tutta la famiglia.
"Anzitutto servono le uova fresche pastorizzate – spiega Stanco – che
noi ci procuriamo solo presso allevamenti selezionati e certificati. Poi
farina di grano tenero, zucchero, sciroppo di zucchero e... tanto
amore".

A proposito di ingredienti, per la preparazione della
Tortina, la ditta Tomarchio utilizza anche olio di girasole e perfino
olio extra vergine d'oliva. "Siamo stati tra i primi in Italia –
sottolinea Stanco - a impiegare l'olio extra vergine nelle merendine.
Abbiamo messo a punto una lavorazione che è in grado di attenuare il
sapore forte tipico dell'oliva, quella sorta di "pizzicore" non a tutti
gradito, ma che al contempo mantiene inalterate tutte le caratteristiche
organolettiche e nutritive dell'olio, compresi i polifenoli che fanno
così bene alla salute".
Un'altra peculiarità della merendina Tomarchio è la
totale assenza di conservanti, coloranti e altri componenti chimici.
"Noi lavoriamo le sole materie prime – continua Stanco - e ci sforziamo
di valorizzarle al massimo esclusivamente attraverso la tecnica
artigianale. Le gocce di impasto scendono nel pirottino che poi viene
messo direttamente in forno. Rispettiamo scrupolosamente i tempi
naturali sia di lievitazione che di raffreddamento dopo la cottura,
senza forzature nè accelerazioni. Infine la Tortina viene chiusa in una
bustina ermetica che ne preserva la freschezza e ne garantisce la durata
nel tempo".
Semplicità, genuinità e salubrità sono insomma i
capisaldi su cui si fonda il successo della "brioscina". E pensare che
la sua ricetta venne ideata quasi per caso, oltre sessant'anni fa, dal
fondatore, il signor Tomarchio in persona, che all'inizio produceva
quasi esclusivamente biscotti siciliani alle mandorle. Per sperimentare
qualcosa di diverso creò un dolce del tipo "Pan di Spagna" e lo mise in
vendita nella sua bottega, dove andò subito a ruba. La fama del nuovo
prodotto conquistò nuovi clienti allargandosi in breve sempre di più:
era nata la tradizione della Tortina Tomarchio.
Una fama peraltro giustificata dalla versatilità
d'utilizzo che caratterizza la soffice brioche. "Non è solo una
merendina da gustare a metà giornata – spiega Stanco -, ma molto di più:
c'è chi la mangia a colazione inzuppata nel latte e chi invece la
preferisce alla sera come "coccola" prima di andare a dormire. E' buona
al naturale, ma si può anche tagliare a metà e farcire con crema di
nocciola o panna. Qui a Catania la accompagnamo spesso con il gelato o
la granita. Si presta insomma a tanti abbinamenti, anche di fantasia,
tutti golosi".
https://www.territori.coop.it/territori/tortina-tomarchio-buona-e-genuina-come-fatta-casa?fbclid=IwAR1P6s79Gmsc9gPtrkgncMJaWtnZarYT3W9wnV6a027X7d-6EIOxBXkbCqc
 |

|
.jpg)
 insediamento. «Attribuire a Caviezel la cittadinanza onoraria - ha detto Bianco - è uno dei momenti
più importanti della sindacatura. E' con vero gratitudine che la assegno
a un uomo che ha saputo con impegno straordinario incentivare la
tradizione della pasticceria e della gelateria in particolare e che,
ancora oggi non più giovanissimo, trasmette i suoi saperi ai più giovani
offrendo loro una preziosa opportunità». Nato e cresciuto in Svizzera,
sin dal secondo dopoguerra il maestro Caviezel ha saputo rilanciare in
particolare la gelateria. «Per il lustro che Lucas Caviezel ha saputo
dare a Catania in questi decenni, l'Amministrazione comunale ritiene di
dovergli conferire, in segno di stima e apprezzamento, la cittadinanza
onoraria del Comune», si legge nella pergamena. Caviezel - ieri
accompagnato dal presidente dell'associazione di categoria Ducezio,
Salvatore Farina, e dai pasticceri che ne fanno parte - ha ringraziato
il sindaco e ha ricordato come sin da ragazzino abbia sempre cercato di
essere catanese fra i catanesi: «Da questa città ho ricevuto molto di
più di quanto io abbia dato».
insediamento. «Attribuire a Caviezel la cittadinanza onoraria - ha detto Bianco - è uno dei momenti
più importanti della sindacatura. E' con vero gratitudine che la assegno
a un uomo che ha saputo con impegno straordinario incentivare la
tradizione della pasticceria e della gelateria in particolare e che,
ancora oggi non più giovanissimo, trasmette i suoi saperi ai più giovani
offrendo loro una preziosa opportunità». Nato e cresciuto in Svizzera,
sin dal secondo dopoguerra il maestro Caviezel ha saputo rilanciare in
particolare la gelateria. «Per il lustro che Lucas Caviezel ha saputo
dare a Catania in questi decenni, l'Amministrazione comunale ritiene di
dovergli conferire, in segno di stima e apprezzamento, la cittadinanza
onoraria del Comune», si legge nella pergamena. Caviezel - ieri
accompagnato dal presidente dell'associazione di categoria Ducezio,
Salvatore Farina, e dai pasticceri che ne fanno parte - ha ringraziato
il sindaco e ha ricordato come sin da ragazzino abbia sempre cercato di
essere catanese fra i catanesi: «Da questa città ho ricevuto molto di
più di quanto io abbia dato». che vendeva articoli
casalinghi era sulla sinistra a salire, prima della farmacia Spadaro
Ventura, della Sala Roma, della Birreria Lorenti e della Rosticceria
Giardini, mentre Caviezel era sulla destra, poco prima dell'albergo
Central Corona che aveva all'ingresso due leoni di marmo.
che vendeva articoli
casalinghi era sulla sinistra a salire, prima della farmacia Spadaro
Ventura, della Sala Roma, della Birreria Lorenti e della Rosticceria
Giardini, mentre Caviezel era sulla destra, poco prima dell'albergo
Central Corona che aveva all'ingresso due leoni di marmo.















 La terza fonte è, infine, quella di
più recente acquisizione, e riguarda la raffinata pasticceria
importata in Sicilia da valenti pasticceri svizzeri, che dall'inizio
del secolo scorso si trasferirono nell'isola. Infatti i dolci
siciliani più conosciuti sono proprio quelli appartenenti alla
pasticceria svizzero-siciliana, che si trova in tutte le principali
città d'Italia. Fra le molte dominazioni che si sono
succedute nell'isola è sicuramente quella araba che ha impresso di
più la propria impronta, perché ha introdotto alcuni elementi,
quali il pistacchio, la cannella e lo zucchero, di cui si fa largo
uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Ma è attraverso la
creatività che la pasticceria siciliana tradizionale si rivela
ricca e variata, anche quando impiega ingredienti semplici e poveri:
la ciaurrina, un antico dolce tradizionale, ha come unico
ingrediente il miele.
La terza fonte è, infine, quella di
più recente acquisizione, e riguarda la raffinata pasticceria
importata in Sicilia da valenti pasticceri svizzeri, che dall'inizio
del secolo scorso si trasferirono nell'isola. Infatti i dolci
siciliani più conosciuti sono proprio quelli appartenenti alla
pasticceria svizzero-siciliana, che si trova in tutte le principali
città d'Italia. Fra le molte dominazioni che si sono
succedute nell'isola è sicuramente quella araba che ha impresso di
più la propria impronta, perché ha introdotto alcuni elementi,
quali il pistacchio, la cannella e lo zucchero, di cui si fa largo
uso nella preparazioni di molti dolci siciliani. Ma è attraverso la
creatività che la pasticceria siciliana tradizionale si rivela
ricca e variata, anche quando impiega ingredienti semplici e poveri:
la ciaurrina, un antico dolce tradizionale, ha come unico
ingrediente il miele.


 Da
quando questo paragone è stato dedicato alla popolare pasta? Nel 1920 in casa
Musco-Pandolfini in via Etnea, si svolse un pranzo che adesso ci appare in tutta
la sua storica prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era
ancora celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe
Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e
Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento.
Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui
Da
quando questo paragone è stato dedicato alla popolare pasta? Nel 1920 in casa
Musco-Pandolfini in via Etnea, si svolse un pranzo che adesso ci appare in tutta
la sua storica prospettiva. Il grande attore e mimo catanese Angelo Musco era
ancora celibe e viveva presso la diletta sorella Anna, sposata con Giuseppe
Pandolfini. La coppia aveva due figli, il celebre caratterista Turi Pandolfini e
Janu, prima teatrante, poi titolare di un notissimo negozio d’abbigliamento.
Janu era sposato con la signora Saridda D’Urso, nel cui appartamento troviamo
riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Janu Pandolfini e i noti commediografi e
giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Quando Donna Saridda
portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la salsa di pomodoro, basilico,
melanzane fritte e ricotta salata grattugiata, dopo le prime religiose
forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che era, Nino Martoglio volle
complimentarsi con l’autrice con queste precise parole: "Signora Saridda,
chista è ‘na vera Norma!". Naturalmente, stante la presenza di tanti e
così autorevoli "gazzettini", la frase immediatamente si riseppe in
tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E dunque Nino
Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci commedie del
teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore di aver
ufficialmente battezzato "alla Norma" la popolare pasta catanese,
anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice
espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un diretto
ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini
appartamento troviamo
riuniti a tavola Angelo Musco, Turi e Janu Pandolfini e i noti commediografi e
giornalisti Nino Martoglio, Pippo Marchese e Peppino Fazio. Quando Donna Saridda
portò a tavola gli appetitosi spaghetti con la salsa di pomodoro, basilico,
melanzane fritte e ricotta salata grattugiata, dopo le prime religiose
forchettate, da quel galante poeta e buongustaio che era, Nino Martoglio volle
complimentarsi con l’autrice con queste precise parole: "Signora Saridda,
chista è ‘na vera Norma!". Naturalmente, stante la presenza di tanti e
così autorevoli "gazzettini", la frase immediatamente si riseppe in
tutta via Etnea, da sempre salotto e curtigghiu dei catanesi. E dunque Nino
Martoglio, indimenticato autore di Centona e delle più vivaci commedie del
teatro siciliano, viene definitivamente accreditato dell’onore di aver
ufficialmente battezzato "alla Norma" la popolare pasta catanese,
anche se, come appare probabile, non fece altro che ripetere una felice
espressione già coniata con straordinaria efficacia dal popolo, per un diretto
ma sentitissimo omaggio all’arte di Vincenzo Bellini






















 i
primi tre di ciascuna delle due categorie, pasticcieri (1.500 euro per il
primo classificato) e apprendisti pasticceri (1.000 euro), ma soprattutto il
valore simbolico di essere valutati da sette maestri. «Tra le finalità della
fondazione c'è quella di tenere unito il gruppo di pasticceri siciliani.
Questa è un'opportunità di offrire una vetrina alla loro abilità, ai nomi
già affermati ma anche ai giovani talenti».
i
primi tre di ciascuna delle due categorie, pasticcieri (1.500 euro per il
primo classificato) e apprendisti pasticceri (1.000 euro), ma soprattutto il
valore simbolico di essere valutati da sette maestri. «Tra le finalità della
fondazione c'è quella di tenere unito il gruppo di pasticceri siciliani.
Questa è un'opportunità di offrire una vetrina alla loro abilità, ai nomi
già affermati ma anche ai giovani talenti».













 Ubicata
nel lato ponente-tramontana del palazzetto Biscari, constava di due
ampi saloni e aveva l'ingresso su piazza S. Nicolella. Gestita dai
fratelli Tscharner
Ubicata
nel lato ponente-tramontana del palazzetto Biscari, constava di due
ampi saloni e aveva l'ingresso su piazza S. Nicolella. Gestita dai
fratelli Tscharner , svizzeri d'origine catanesi d'adozione, la
Birraria era il ritrovo preferito dai giornalisti, ma anche dai
commercianti, negozianti, funzionari della vicina Posta.
, svizzeri d'origine catanesi d'adozione, la
Birraria era il ritrovo preferito dai giornalisti, ma anche dai
commercianti, negozianti, funzionari della vicina Posta.



 Nel
1930 Giuseppe Lorenti, avendo saputo che il gestore Rizzo si
accingeva a lasciare la Birreria svizzera di via Etnea 141-143-145,
la prese in affitto. Il locale, dopo pochi mesi, gli fu offerto in
vendita e Lorenti lo acquistò. Poteva contenere 500 persone sedute a
tavolino, funzionava da ristorante, bar, gelateria e sala da
biliardo.
Nel
1930 Giuseppe Lorenti, avendo saputo che il gestore Rizzo si
accingeva a lasciare la Birreria svizzera di via Etnea 141-143-145,
la prese in affitto. Il locale, dopo pochi mesi, gli fu offerto in
vendita e Lorenti lo acquistò. Poteva contenere 500 persone sedute a
tavolino, funzionava da ristorante, bar, gelateria e sala da
biliardo.

 gli ex
pallanotisti catanesi, quelli che avevano fatto parte della bella gioventù
catanese,
Franco Pintaldi «Taralla», Ciccio Calabretta, Saverio Barbagallo,
Geo Magrì,
i fratelli Armando e Pietro
Cucinotta e tutti gli altri compagni
d'avventura. Poi il figlio del commendatore Ugo, realizzò un suo ristorante,
battezzato Rivoli, che era uno dei più belli di Catania ed ebbe lunghe
stagioni di successo. Il ristorante Lorenti si spostò anche alla Nave, nella
villa appartenente al notaio Pittella sul mare di Ognina. Stavolta non ebbe
gran fortuna, forse perché era troppo di nicchia, tanto che chiuse e poi vi
si insediò il Club della Stampa allora retto da Filippo Galatà, giornalista
ed alto dirigente della Provincia.
gli ex
pallanotisti catanesi, quelli che avevano fatto parte della bella gioventù
catanese,
Franco Pintaldi «Taralla», Ciccio Calabretta, Saverio Barbagallo,
Geo Magrì,
i fratelli Armando e Pietro
Cucinotta e tutti gli altri compagni
d'avventura. Poi il figlio del commendatore Ugo, realizzò un suo ristorante,
battezzato Rivoli, che era uno dei più belli di Catania ed ebbe lunghe
stagioni di successo. Il ristorante Lorenti si spostò anche alla Nave, nella
villa appartenente al notaio Pittella sul mare di Ognina. Stavolta non ebbe
gran fortuna, forse perché era troppo di nicchia, tanto che chiuse e poi vi
si insediò il Club della Stampa allora retto da Filippo Galatà, giornalista
ed alto dirigente della Provincia.









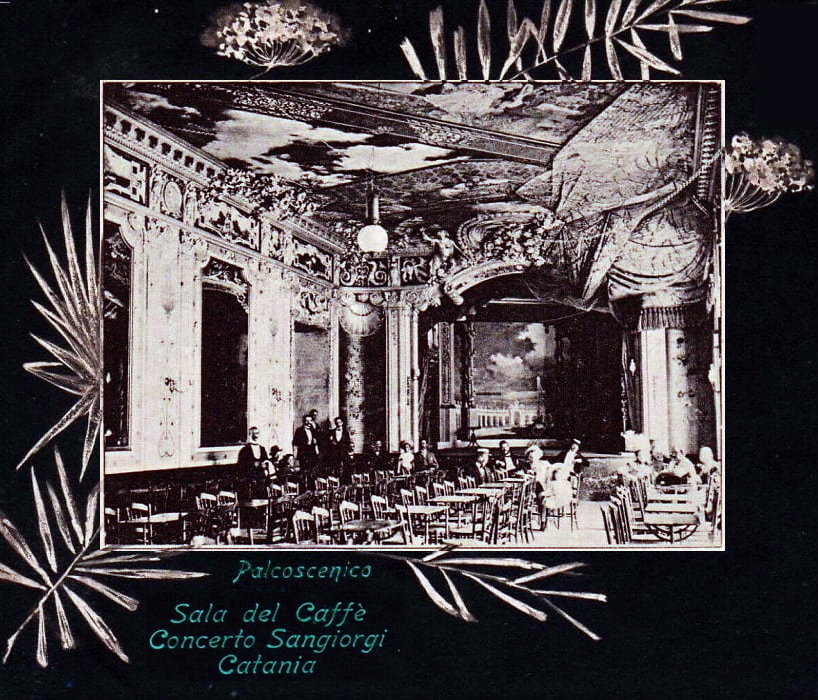
 pizzeria poiché panifici e bar sono attrezzati a soddisfare
i gusti dei propri clienti.....insomma la pizza oggi si trova ovunque e
dovunque!
pizzeria poiché panifici e bar sono attrezzati a soddisfare
i gusti dei propri clienti.....insomma la pizza oggi si trova ovunque e
dovunque!









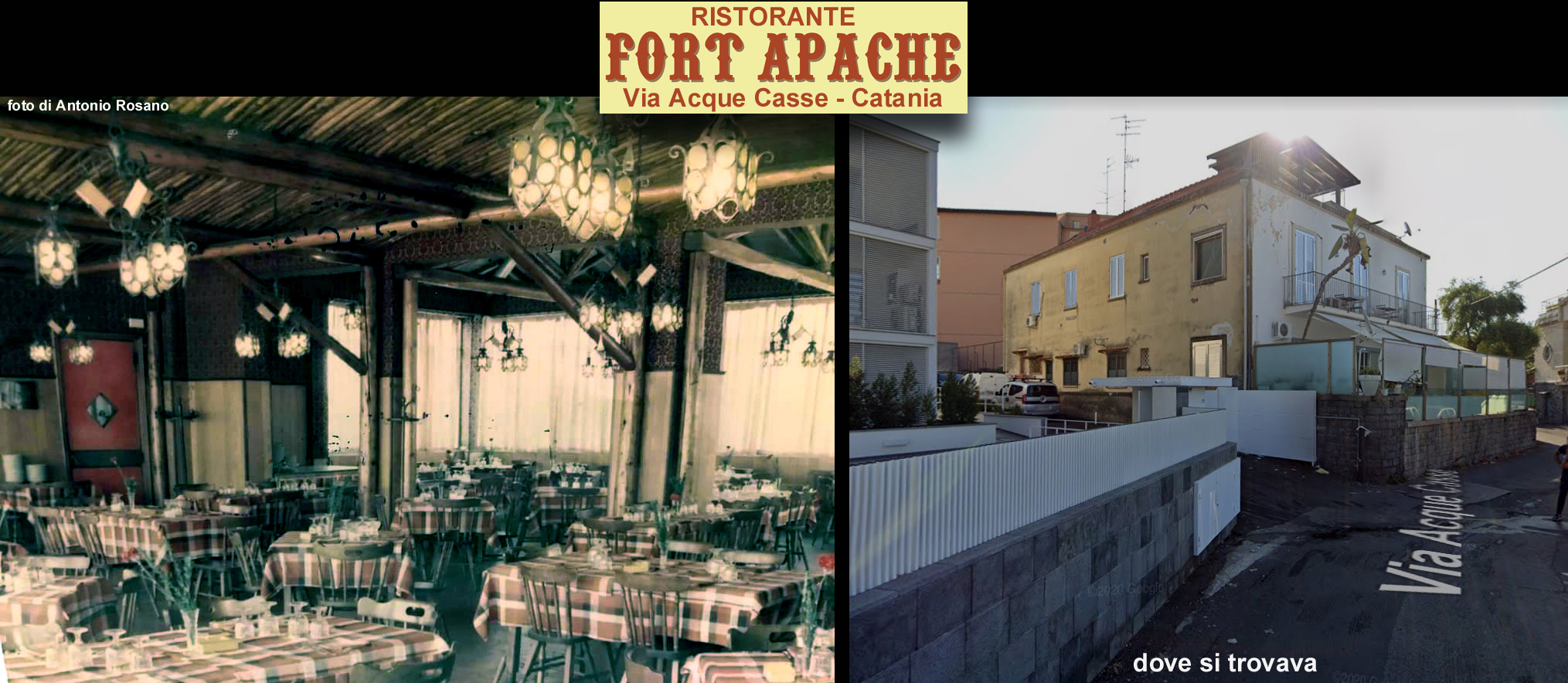






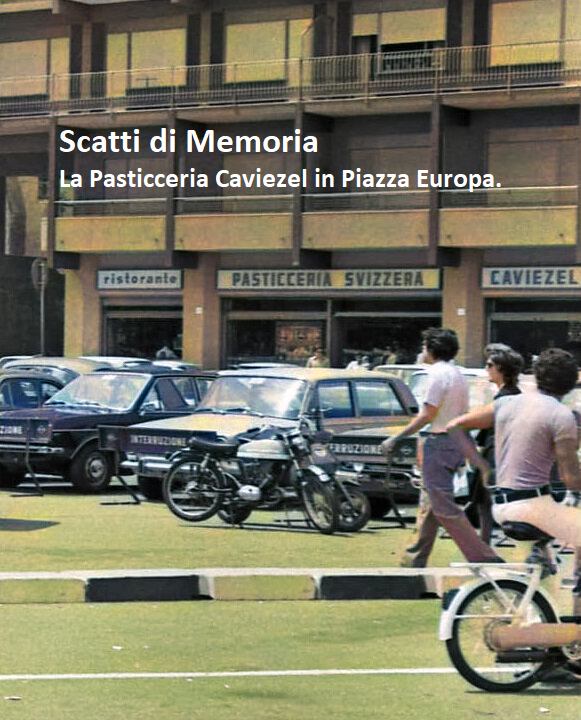
.jpg) si è mai ribellato ed ha sempre
subìto...”Sissignori...vossaberenica” ...lo dice con tono partecipato e
divertito.
si è mai ribellato ed ha sempre
subìto...”Sissignori...vossaberenica” ...lo dice con tono partecipato e
divertito. .jpg)

.jpg)

 Ma
Lei si considera piu' svizzero o catanese?
Ma
Lei si considera piu' svizzero o catanese?





 sempre rumoroso e animato dai conversare di
poeti e novellieri in fieri. Gli assidui furono in maggior parte
giornalisti agli inizi (Vito Mar Nícolosi, Ferdinando Caioli,
Giacomo Etna), pittori alle prime armi (Fichera, Rimini, Gandolfo),
nonché docenti di scuole medie senza cattedra... Padroni del bar, i
coniugi Imbronciano: curiosa coppia, con un bambino di pochi mesi
che la signora allattava, seduta alla cassa, mentre il marito
attendeva ai bicchieri, al caffé, alle risciacquature.
sempre rumoroso e animato dai conversare di
poeti e novellieri in fieri. Gli assidui furono in maggior parte
giornalisti agli inizi (Vito Mar Nícolosi, Ferdinando Caioli,
Giacomo Etna), pittori alle prime armi (Fichera, Rimini, Gandolfo),
nonché docenti di scuole medie senza cattedra... Padroni del bar, i
coniugi Imbronciano: curiosa coppia, con un bambino di pochi mesi
che la signora allattava, seduta alla cassa, mentre il marito
attendeva ai bicchieri, al caffé, alle risciacquature. Al
Gambrinus diedero prestigio i soci del Circolo Artistico,
soprattutto i redattori di Siciliana, la bella rivista catanese, cui
collaborarono Roberto Rimeni, Natale Scalía, Giuseppe Patané e altri
dell'intelligbentia nostrana.
Al
Gambrinus diedero prestigio i soci del Circolo Artistico,
soprattutto i redattori di Siciliana, la bella rivista catanese, cui
collaborarono Roberto Rimeni, Natale Scalía, Giuseppe Patané e altri
dell'intelligbentia nostrana.



 del famoso pittore del Quattrocento
veneziano Giovanni Bellini.
del famoso pittore del Quattrocento
veneziano Giovanni Bellini. enza, un grosso nugolo di marpioni d'ogni risma e colore, s'era
ficcato di prepotenza nelle case editrici e nei giornali per fare il buono e
il cattivo tempo non certo per l'arte e la cultura, ma per i loro personali
interessi di partito o di cassetta.
enza, un grosso nugolo di marpioni d'ogni risma e colore, s'era
ficcato di prepotenza nelle case editrici e nei giornali per fare il buono e
il cattivo tempo non certo per l'arte e la cultura, ma per i loro personali
interessi di partito o di cassetta.
 IL
BAR ELENA ALL' INGRESSO DELLA
PESCHERIA
IL
BAR ELENA ALL' INGRESSO DELLA
PESCHERIA




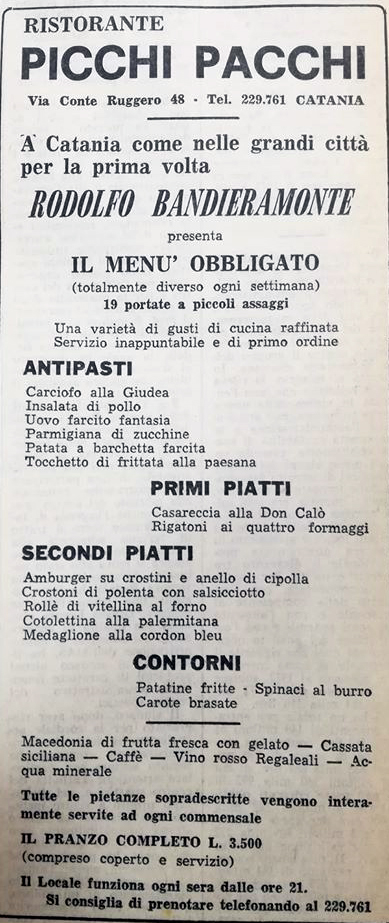




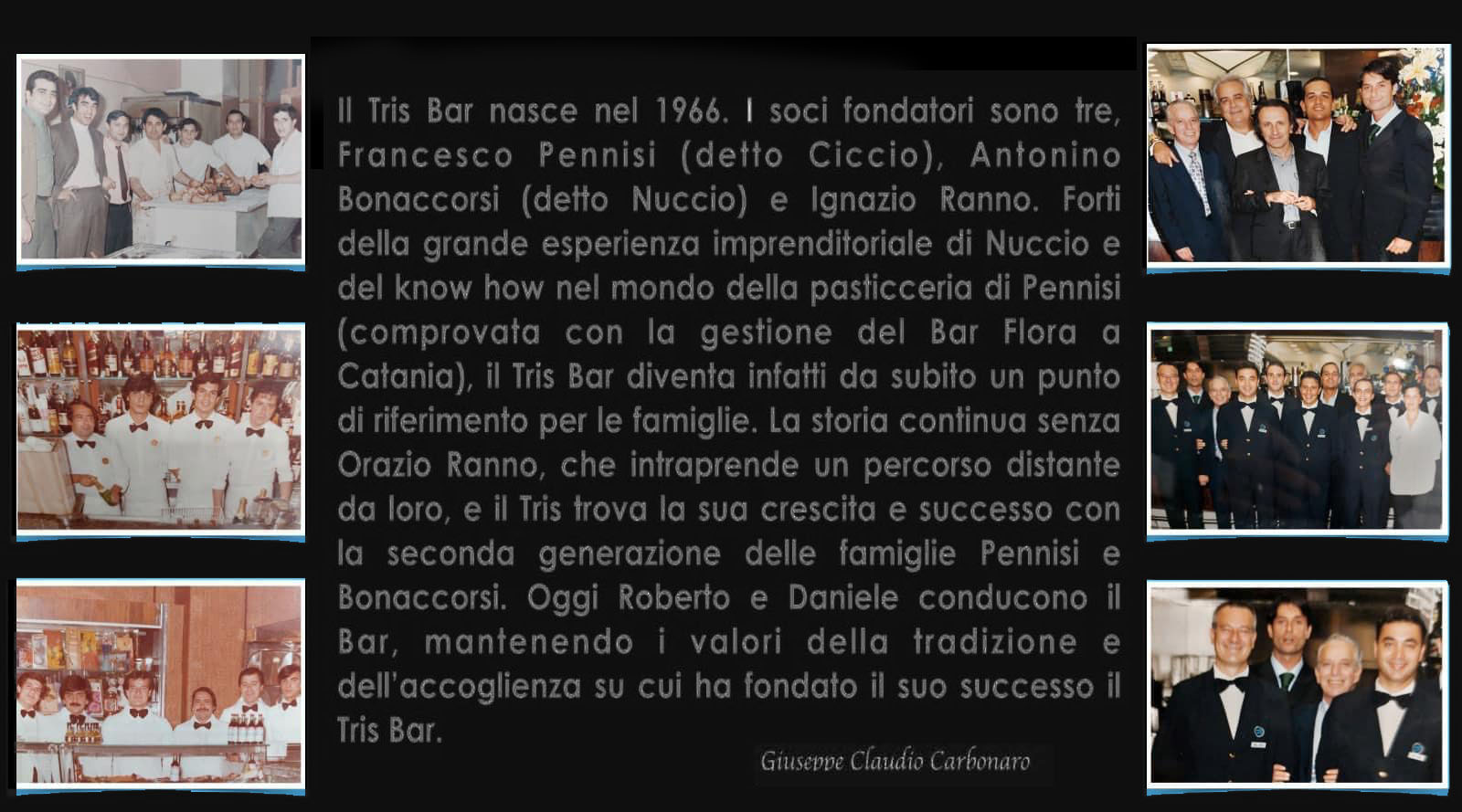








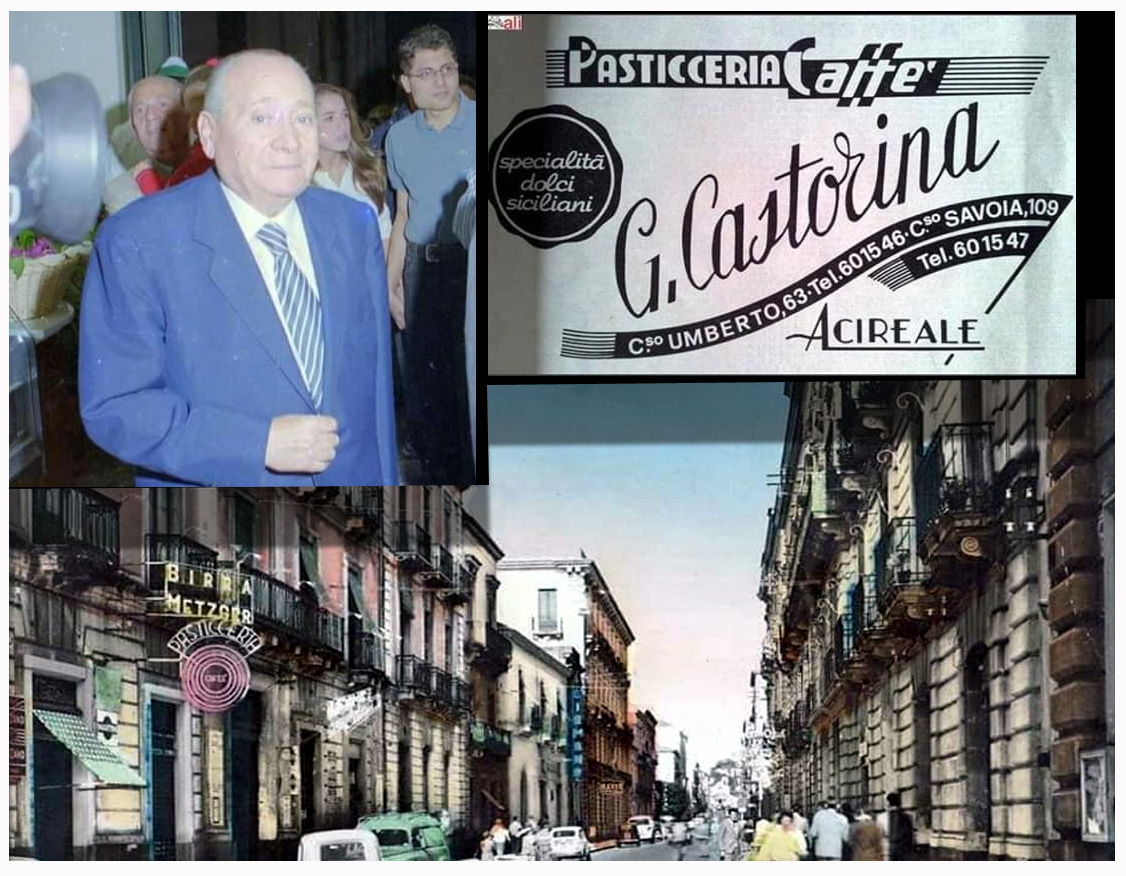


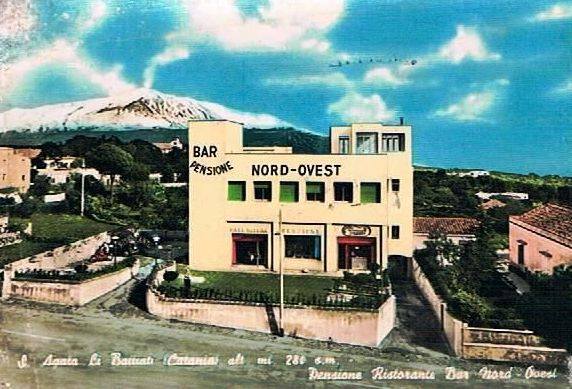

 Nel
lontano 1660 un certo Francesco Procopio De Coltelli lasciò la natia
Acitrezza per conquistare Parigi, Non partì con un carico di lupini, ma
con uno speciale utensile che serviva a fabbricare sorbetti e granite.
Forte della tradizione in materia, importata secoli prima in Sicilia dai
lungimirati musulmani, Procopio capi che la specialità nostrana poteva
avere successo anche in altre parti del inondo. E così inventò la sua
ricetta vincente: lo zucchero al posto del miele (come nell'uso arabo) e
il
Nel
lontano 1660 un certo Francesco Procopio De Coltelli lasciò la natia
Acitrezza per conquistare Parigi, Non partì con un carico di lupini, ma
con uno speciale utensile che serviva a fabbricare sorbetti e granite.
Forte della tradizione in materia, importata secoli prima in Sicilia dai
lungimirati musulmani, Procopio capi che la specialità nostrana poteva
avere successo anche in altre parti del inondo. E così inventò la sua
ricetta vincente: lo zucchero al posto del miele (come nell'uso arabo) e
il sale mescolato al ghiaccio nelle giuste proporzioni per aumentarne la
durata.
sale mescolato al ghiaccio nelle giuste proporzioni per aumentarne la
durata.






 "Ti
faresti monaco?" gli domandò il principe, per chiasso. "Ci
staresti sempre, al convento?" "Sì," rispose egli, per
non dargliela vinta.
"Ti
faresti monaco?" gli domandò il principe, per chiasso. "Ci
staresti sempre, al convento?" "Sì," rispose egli, per
non dargliela vinta. , ricominciava per evitare quel fastidio ai
grandi, i quali se ne stavano comodamente seduti dinanzi alle tavole
disposte lungo i muri, sopra una specie di largo marciapiedi; l'Abate,
nel centro del gran ferro di cavallo, aveva una tavola per sé. I
fratelli portavano intanto attorno i piatti, a otto per volta, sopra
un'asse chiamata "portiera" che reggevano a spalla.
, ricominciava per evitare quel fastidio ai
grandi, i quali se ne stavano comodamente seduti dinanzi alle tavole
disposte lungo i muri, sopra una specie di largo marciapiedi; l'Abate,
nel centro del gran ferro di cavallo, aveva una tavola per sé. I
fratelli portavano intanto attorno i piatti, a otto per volta, sopra
un'asse chiamata "portiera" che reggevano a spalla.





























 profumo dei suoi
biscotti all’anice, ancor oggi rinomati in tutta la Sicilia. E fu con un’affettuosa
gratitudine che i catanesi si recarono a rendere l’ultimo omaggio alla
donna che aveva saputo portar fuori dal convento, quasi come Prometeo con
il fuoco, il segreto di dolci semplici e gustosi. Un sentimento conservato
quasi intatto fino a oggi che ricorre il centenario della scomparsa della Monaca dei viscotta d’a
monica. Sì, perché fu proprio
Mara Messina, nella Catania degli ultimi decenni dell’Ottocento, a
metter su con la nipote Rosaria Di Mauro, che avrebbe poi sposato Giovanni
Arena, una piccola rivendita di biscotti in via Mancini, proprio dietro la
Piazza dell’Università, dove ancor oggi si trova un punto vendita della ditta.
profumo dei suoi
biscotti all’anice, ancor oggi rinomati in tutta la Sicilia. E fu con un’affettuosa
gratitudine che i catanesi si recarono a rendere l’ultimo omaggio alla
donna che aveva saputo portar fuori dal convento, quasi come Prometeo con
il fuoco, il segreto di dolci semplici e gustosi. Un sentimento conservato
quasi intatto fino a oggi che ricorre il centenario della scomparsa della Monaca dei viscotta d’a
monica. Sì, perché fu proprio
Mara Messina, nella Catania degli ultimi decenni dell’Ottocento, a
metter su con la nipote Rosaria Di Mauro, che avrebbe poi sposato Giovanni
Arena, una piccola rivendita di biscotti in via Mancini, proprio dietro la
Piazza dell’Università, dove ancor oggi si trova un punto vendita della ditta. Bisogna aggiungere poi che quello era un periodo non solo di grandi
fermenti politici, ma anche di grande fervore religioso per la città ai
piedi dell’Etna: nello stesso anno sarebbero nate anche Giuseppina Faro,
nobildonna meglio nota come Beata Peppina, nella vicina Pedara, e, in
Piemonte quella madre Maddalena Morano, che qui si sarebbe spenta in odore
di santità.
Bisogna aggiungere poi che quello era un periodo non solo di grandi
fermenti politici, ma anche di grande fervore religioso per la città ai
piedi dell’Etna: nello stesso anno sarebbero nate anche Giuseppina Faro,
nobildonna meglio nota come Beata Peppina, nella vicina Pedara, e, in
Piemonte quella madre Maddalena Morano, che qui si sarebbe spenta in odore
di santità. elle due
immagini rimasteci della Monaca. La prima è un bel ritratto a olio
eseguito un anno prima della sua morte che ce la rimanda florida e
composta, in posa ieratica con un messale in mano. L’altra è la foto
della Monaca dei viscotta d’a monica esposta nel negozio Arena di via
Mancini. Ed è analizzando al computer quest’immagine che si scopre come
la folta chioma della z’a monica sia in realtà un ritocco: i capelli
furono aggiunti a carboncino. La povera Mara, che non era certo una
bellezza, era insomma anche calva. Cosa, a sentire i medici, abbastanza
comune in quell’epoca in cui imperversavano tifo e infezioni intestinali
che, in assenza di antibiotici, finivano sempre per cronicizzarsi.
elle due
immagini rimasteci della Monaca. La prima è un bel ritratto a olio
eseguito un anno prima della sua morte che ce la rimanda florida e
composta, in posa ieratica con un messale in mano. L’altra è la foto
della Monaca dei viscotta d’a monica esposta nel negozio Arena di via
Mancini. Ed è analizzando al computer quest’immagine che si scopre come
la folta chioma della z’a monica sia in realtà un ritocco: i capelli
furono aggiunti a carboncino. La povera Mara, che non era certo una
bellezza, era insomma anche calva. Cosa, a sentire i medici, abbastanza
comune in quell’epoca in cui imperversavano tifo e infezioni intestinali
che, in assenza di antibiotici, finivano sempre per cronicizzarsi.
 Così, il giorno prima del ferragosto del 1907, la scomparsa di Mara
Messina colpì la città, già stordita dall’afa. Quando la notizia
prese a circolare, le bocche si torcevano in quelle caratteristiche smorfie di dispiacere che i catanesi
riservano ai lutti più pesanti. A portarsi via Mara, all’età di
sessant’anni - ma allora si invecchiava decisamente prima - fu
probabilmente l’ennesima infezione intestinale, aggravata dall’afa
terribile di quei giorni. Morì, dunque. Ma il suo ricordo è, ancor oggi,
vivo nei catanesi. Qualcuno tra i più anziani giura persino di aver
conosciuto personalmente la Monaca, ma in realtà parla di Rosaria Arena,
agguerrita antesignana delle donne imprenditrici etnee, morta nel 1943 all’età
di 82 anni.
Così, il giorno prima del ferragosto del 1907, la scomparsa di Mara
Messina colpì la città, già stordita dall’afa. Quando la notizia
prese a circolare, le bocche si torcevano in quelle caratteristiche smorfie di dispiacere che i catanesi
riservano ai lutti più pesanti. A portarsi via Mara, all’età di
sessant’anni - ma allora si invecchiava decisamente prima - fu
probabilmente l’ennesima infezione intestinale, aggravata dall’afa
terribile di quei giorni. Morì, dunque. Ma il suo ricordo è, ancor oggi,
vivo nei catanesi. Qualcuno tra i più anziani giura persino di aver
conosciuto personalmente la Monaca, ma in realtà parla di Rosaria Arena,
agguerrita antesignana delle donne imprenditrici etnee, morta nel 1943 all’età
di 82 anni.
















