|

|
La presenza
di fucuni nelle strade di Catania è antica. Nella Roma imperiale erano
così tanti che Domiziano li dovette eliminare per legge. Marziale
scrisse: “La strada non è più occupata da fumosi focolai, è tornata ad
essere Roma, quella che sino a pochi anni fa non era se non una bottega
fumosa.”
In Sicilia
la cucina povera ma saporita non si trova nei ristoranti ma
rigorosamente nei mercati all'aperto, nei quartieri e negli angoli del
centro storico dove nei cufuni (barbecue) si arrostiscono salsicce,
carne di cavallo, castrato, carciofi, peperoni, cipolle È il trionfo
dell'arrusti e mangia. I cuori di cipolla conditi con olio, aceto e
origano, furono molto apprezzati dal cardinale Karol Woityla quando in
visita a Catania gli furono offerti. Ci sono anche pentoloni in rame con
i bolliti di interiora (a quarumi) che, tagliati a tocchetti su una
lastra di marmo, i passanti mangiano senza aggiunta di alcun condimento,
con le dita.
I catanesi
"devoti tutti" seguono in massa il feretro di S. Agata dal mattino a
notte inoltrata molti non tornano a casa neppure per mangiare. Il comune
all'inizio del secolo scorso provvedeva a mettere per strada i foconi a
disposizione di chi voleva arrostire di tutto. Oggi questa usanza è
commercializzata da privati che nei loro foconi cucinano e friggono di
tutto. Insieme ai foconi (o cofoni) si trovano dei tavoli bbuffetti su
cui è in mostra il cibo.
A bbuffetta
prende il nome dal francese Pierre Buffet, cuoco di Francesco I di
Francia venuto in Italia alla corte del Vescovo Giliberto di Verona,
divenuto famoso per i sontuosi tavoli che imbandiva, chiamati buffet dal
nome del loro ideatore. In Sicilia è un'usanza prettamente maschile che
si rifà ai Romani che dopo gli spettacoli negli anfiteatri si fermavano
a mangiare per strada. I Romani avevano ereditato queste usanze dai
Greci, i quali in angoli appartati dell'Agorà vendevano bolliti e
fritture consumandole in piedi con gli amici o che portavano a casa. Nel
Thermopolion delle città greche di Sicilia era molto in uso consumare
cibi in strada conversando con amici, anche se ora è nobilitato
nell'inglese street food, è antico di 3000 anni.

Nel mercato
storico della Vucciria di Palermo si possono comprare u pani ca meusa
(milza) fritta che può essere schetta (semplice) o maritata, quando è
anche farcita con polmone fritto e ricotta, le crocchettine di patate
dall'espressivo: nome di cazzilli, la rascatura (raschiato dalle padelle
per prendere il sedimento delle fritture), frittule, quarumi (interiori
bolliti), purpu (polpo), u cicireddu (pesciolini infarinati e fritti),
verdure in pastella, sfinciuni simili alla pizza napole- tana, un tempo
preparati dalle monache di San Vito forse per i borboni in esilio a
Palermo, ed altre sfizioserie arricchite dalle cipolle di Comiso. Le
puls di farina di ciciri (ceci) si preparano ancora nella Sicilia
orientale.
Questi
antichi, popolari e festosi fast food divenuti ora ricercati rapipitittu
(antipasti) caldi nelle sofisticate cene siciliane che, consumati in
tavole imbandite, tra forchette e tovaglioli, perdono tutta la loro
festosa gioiosità. L'uso dei rapipitittu è antica. I Romani iniziavano i
loro banchetti con gli antipasti (gustatio): pesci in salsa piccante,
crostacei, uova a bazzotto. Come aperitivo bevevano il mulsum, vino
dolcificato col miele che lavava l'intestino prima del pasto. Cicerone
scriveva a Peto: Non riportare tutte le tue speranze nell'antipasto, io
ho smesso di farlo, perchè mi rovina sempre l'appetito a forza di
sardine sott'olio e salamini lucanis.
Le
prelibatezze da strada sono offerte ai consumatori in untuosi cartocci
di carta da dove vengono prelevati con la forchetta araba costituita dal
pollice. Indice e medio della mano destra.
Nel Corano si
legge che solo l'ingordo arraffa l'alimento con le cinque dita, l'uomo
sobrio ne utilizza solo tre. Anche Ovidio nella Roma imperiale
raccomandava di sporcarsi a tavola solo tre dita. Nell'Ars amandi dà le
regole per stare a tavola: Assumi i cibi appena con la punta delle dita
(mangiando ci vuol grazia), non sporcarti la faccia con le mani bisunte,
non mangiare in anticipo a casa tua ma smetti prima di essere sazia,
mangia un pochino meno di quanto potresti fare, se Paride vedesse Elena
che si abboffa la odierebbe dicendo, che ratto ho mai compiuto?”
Fonte:
SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne
editrice 2019
.jpg) Non
è nebbia sulle strade, ma carne al fuoco. Non
è nebbia sulle strade, ma carne al fuoco.
Secoli di Fast Food da strada.
In Sicilia per mangiare sfizioso non bisogna sedersi ai tavoli dei
ristoranti. Basta andare nei mercati storici o nelle vie dei quartieri
popolari per trovare bocconi unici ed irripetibili.
Le fritture, i cuori di cipolle al forno condite con olio, aceto ed
origano, i bolliti di interiora (a quarumi) che i romani
consumavano nelle tabernae, dopo gli spettacoli negli anfiteatri, ancora
si vendono 'ne buffetti (sui tavoli) (dal francese buffet o dallo
spagnolo bufeta) agli angoli delle strade di Catania.
Quando il Cardinale Karol Wojtyla visitò Catania, tra le tante
specialità gli offrirono i cuori di cipolla che gradì tanto da chiederne
ancora. I romani avevano ereditato dai greci queste abitudini.
Nell'agorà greca si vendevano in un angolo riparato bolliti e fritture
che consumavano , in piedi o portavano a casa. Nel Thermopolion delle
città greche di Sicilia si vendevano arrosti, fritture e bolliti di ogni
genere che si potevano portare a casa o consumare insieme agli amici sul
posto.
Dalle puls che i romani avevano appreso dai greci e questi dai popoli
della Mesopotamia discendono le polente, la siciliana rriminata o
fra scatula, che hanno sfamato la povera gente ed ora sono
diventate un raffinato contorno in molti piatti di carne. Il curioso
nome di patacò viene dato alla polenta di .farina di
chiecchiru
(cicerchia). A Licodia Eubea ancora oggi si tiene l'affollata sagra del
patacò dove tra balli e musica si mangia patacò caldo, fritto, semplice
o con verdure ed aromi.

Le famiglie siciliane possedevano in cucina un simpatico
"elettrodomestico". Era un piccolo mulino a pietra che serviva per
macinare ceci, cicerchia ed altri legumi per le polente ed il farro,
l'orzo ed il grano per il couscus, la cuccia e le focacce. Altri
"elettrodomestici" arredavano le cucine. U murtaru (in marmo o in
bronzo), u capuliaturi (mezzaluna), u spitu (lo spiedo), u
muscaloru (ventaglio), u crivu (setaccio) sono solo alcuni
dei tanti vecchi attrezzi da cucina ora scomparsi che si trovavano a
casa mia. Le puls di farina di ciciri (ceci) si preparano ancora nella
Sicilia orientale. Sono stati gli arabi a realizzare le saporite panelle
palermitane. Sono delle fettine di polenta di ceci condite con
prezzemolo e fritte che i buffittari vendono ancora oggi càvuri
càvuri (caldi caldi) nel mercato storico della Vucciria di Palermo.
I
ceci entrarono di prepotenza nella storia siciliana quando al suono
delle campane della Chiesa del Santo Spirito o del Vespro (Secolo XII)
del lunedì di Pasqua del 1282 il popolo palermitano, presto seguito da
tutti i Siciliani, insorse contro il malgoverno di Carlo d'Angiò che era
stato posto sul trono dal Papa. Dante immortalò l'avvenimento nel VIII
canto del paradiso: "Se mala signoria che sempre accorre/li popoli
soggetti non avesse/mosso Palermo a gridare: mora, mora!".
A tre, secoli di distanza dall'avvenimento, Vincenzo Auria nel 1673:
scriveva "E' antica tradizione, che dura sino ad ora, come nel tempo
dell'eccidio, francese in Palermo, che i palermitani, cercando di
sterminarli tutti, e dubitando di non conoscerli tutti per francesi,
incontrandoli per la città, gli facevano proferire ciciri in lingua cesi
ciò non potevano fare, ma solamente dicevano chichiri, dandosi a
conoscere, erano a morte feriti e trucidati dai siciliani".
La
drammatica rivolta popolare non ha avuto nè una leadership nè un
progetto politico ed è finita tristemente nel nulla. I baroni siciliani,
s.jpg) empre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a
governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio
della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro
di Aragona. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino
al1375. Furono anni di guerre ed ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri
investiti dagli aragonesi. empre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a
governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio
della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro
di Aragona. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino
al1375. Furono anni di guerre ed ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri
investiti dagli aragonesi.
Alla Vucciria si possono comprare a vastedda ca mensa (milza)
fritta che può essere schetta (semplice) o maritata quando è anche
farcita con polmone fritto e ricotta, le crocchettine di Patate
dall'espressivo nome di cazzilli, la rascatura (raschiato dalle
padelle per prendere il sedimento delle fritture),ed altre sfizioserie
arricchite dalle cipolle di Comiso.
Si tratta di antichi, popolari e festosi fast food ora ricercati
antipasti caldi nelle sofisticate cene siciliane che consumati in tavole
imbandite, forchette e tovaglioli perdono tutta la loro festosa
gioiosità. Queste prelibatezze da strada sono offerte ai consumatori in
untuosi cartocci di carta da dove vengono prelevati con la forchetta
araba costituita dal pollice, indice e medio della mano destra. Nel
Corano si legge che solo l'ingordo arraffa l'alimento con le cinque
dita, l'uomo sobrio ne utilizza solo tre. Anche Ovidio nella Roma
imperiale raccomandava di sporcarsi a tavola solo tre dita.
Mentre l'uso del coltello e del cucchiaio si perde nel tempo, la
forchetta nasce a Bisanzio intorno all'anno mille.
In Europa non ebbe fortuna anche perché la chiesa romana considerava
diabolico tutto ciò che veniva dalla scismatica Bisanzio. Nel 955 a
Venezia la forchetta venne per la prima volta utilizzata da una
principessa bizantina andata in sposa al figlio del doge suscitando
scandalo: "tale novità parve un segno di raffinatezza talmente
eccessivo che la dogaressa fu severamente disapprovata dai preti, i
quali invocarono su di lei la collera divina.. Poco tempo dopo fu colta
da una malattia innominabile, e San Bonaventura non esitò a dichiarare
che era stato un castigo di Dio". In Sicilia fino al 1500 l'uso
delle mani ritenuto virile accomunava popolo e nobili. Addirittura i
marinai inglesi fino al 1800 mangiavano virilmente con le mani.
La cucina dei buffittari purtroppo tende a scomparire sostituita
dai vari Mc Donald's e self service dove tutto è all'insegna del mangia
e fuggi, che, se soddisfano le moderne esigenze, sono lontani dalla
cultura, dal territorio, dalla storia siciliana e stanno involgarendo e
globalizzando il gusto dei nostri giovani e non solo.
La globalizzazione ha eliminato il fascino stagionale dei sapori.
Mangiamo ciliege a Natale e arance a ferragosto. Anche la nostra
secolare cucina rischia di cedere ai precotti, ai surgelati, agli
inscatolati, alle pentole a pressione, ai forni a microonde, ai robot.
Sarebbe bello se la tradizione e le inevitabili innovazioni si
sposassero, conserveremmo così la nostra cultura e la nostra storia.
(tratto da "I sapori lontani della cucina siciliana" - di Gino Schilirò
- Lancillotto e Ginevra Editori

U SANGELI
I mercati storici siciliani sono tutti un vociare di
venditori che “vanniunu” la loro merce e di acquirenti che trattano sul
prezzo , in mezzo a tutto questo esiste un'oasi che pare un tempio
antico.
Parliamo del buffetto , la postazione è alimentata
dai fuochi che riscaldano un grosso pentolone “a quarara”, l'odore è
forte e su una lastra di marmo una serie di avventori usando due dita e
curvandosi in avanti ingurgitano questo particolare street food
siciliano.
La “cerimonia” si ripete simile da oltre 2500 anni.
I bolliti di interiora (a quarumi) venivano preparati
nelle tabernae dopo gli spettacoli negli anfiteatri, ancora si vendono
'ne buffetti (sui tavoli, dal francese buffet o dallo spagnolo bufeta)
agli angoli delle strade di Sicilia.
I romani avevano ereditato dai greci queste
abitudini. Nel Thermopolion delle città greche di Sicilia si vendevano
arrosti, fritture e bolliti di ogni genere che si potevano portare a
casa o consumare insieme agli amici sul posto.
Sicuramente il più caratteristico tra gli alimenti
che si preparano in questi chioschi è il sangeli .
‘U sangeli, non è altro che il budello del maiale.
ripieno di sanguinaccio suino composto da 1 lt sangue, 1,5 lt di acqua,
sale e pepe nero, oppure su ordinazione viene fatto con prezzemolo e
aglio, o con il pistacchio, comunque la parte più prelibata è la
matruzza, una parte di budello tutto arricciato.
Il sangue al suo interno viene fatto cuocere immerso
nell’acqua, con l’aggiunta di sale e qualche spezia.
I fenomeni fisici legati alla cottura portano alla
coagulazione della miosina , anche la mioglobina non fissa più
l'ossigeno , dopo la coagulazione di diverse altre proteine, le pareti
cellulari si rompono il sangue diventa grigiastro.
Una volta cotto, il budello presenta l’aspetto di un
grosso salame dal colore biancastro. Tagliato in piccole e rotonde
porzioni, viene servito caldo e senza alcun condimento sopra.
Rigorosamente genuino, così com’è.
Solo in cinque a Catania preparano ancora e vendono
al pubblico il “sangeli” professionalmente ,altri occasionalmente
preparano questa gustosa pietanza.
Si tratta di un piatto molto caldo che va consumato
sul posto, è più piacevole sicuramente mangiarlo in inverno.
Ma recuperare gli ingredienti , rispettare le norme
comunitarie di igiene è sempre più difficile e sarà sempre più raro
avere l'opportunità di assaggiare questa delizia siciliana.
Vedere gelare il sangue bollendolo (sangue-gelo) sarà
sempre più difficile.
Fonti : LUDUM - Science Center Catania - lurlo. News
– Stefania Spampinato.’U Sangeli, il vero cibo da strada catanese a
rischio estinzione ; associazonegapa. Org - Paolo Parisi - Gli antichi
mestieri: il venditore di sangeli

I bolliti di interiora (a quarumi) che i romani
consumavano nelle tabernae dopo gli spettacoli negli anfiteatri, ancora
si vendono 'ne buffetti (sui tavoli, dal francese buffet o dallo
spagnolo bufeta) agli angoli delle strade di Catania.
I romani avevano ereditato dai greci queste
abitudini. Nel Thermopolion delle città greche di Sicilia si vendevano
arrosti, fritture e bolliti di ogni genere che si potevano portare a
casa o consumare insieme agli amici sul posto.
(da "I sapori lontani della cucina
siciliana" di Gino Schilirò - Lancillotto e Ginevra Editori
U sangeli (in italiano
"sanguinaccio") è un tipico piatto siciliano che viene prodotto
utilizzando il budello del suino e cotto nelle tradizionali "QUARARE"
ovvero pentoloni illuminati dalle classiche lampadine ad incandescenza
da 500 WATT in su.
Nelle zone catanesi ha acquistato una notevole importanza nelle
cosiddette chianche ("macellerie") del quartiere di San
Cristoforo,comunque si può trovare facilmente nei chioschetti ambulanti
all'angolo delle strade di molti quartieri popolari come Picanellus
Republic etc.

LA CENA ECUMENICA
Se un amico di famiglia ha insistito in maniera
fastidiosa per incontrare vostra nonna, se l’amabile intellettuale
frequentatrice di conferenze e cineforum vi ha chiesto più volte
ragguagli sulle carte di famiglia
e su quaderni di appunti riservati, o, come
rintracciare la tata che per anni è stata con voi, ecco sicuramente
siete di fronte a un accademico della cucina in azione.
Un drappello di persone sguinzagliate fra archivi,
biblioteche, strade e mercati, a investigare e ricercare, ma
difficilmente identificabili quali accademici intenti a raccogliere quel
contesto di informazioni destinato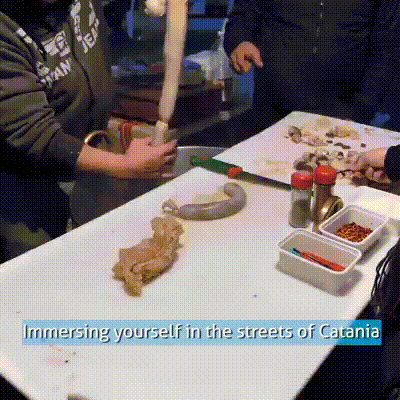 ad avere esito in cucina, in
preparazioni ripescate dalla tradizione, o individuate nel loro
specifico e ad avere esito in cucina, in
preparazioni ripescate dalla tradizione, o individuate nel loro
specifico e
ricomposte per andare in tavola! E per dare enfasi
alla ricerca, ecco la Cena Ecumenica, da celebrare nello stesso giorno
in tutto il mondo, il che equivale al fondare una «liturgia» attorno
alla quale far convergere sia l’interesse dei celebranti che quello
delle società presso le quali avviene, idealmente e concretamente
riuniti a Convivio, a evidenziare lo specifico dell’alimentazione
«italiana». La Cena si accompagna alla presentazione del volume che
quelle ricerche racchiude: «La cucina delle carni da non dimenticare»,
nella fattispecie della cena ottobrina. Scorrendo il testo non ci
sorprendiamo, a partire da Siracusa, di imbatterci in un incipit che
parte da lontano, nientemeno che dall’ecatombe sacrificale che si
consumava sull’ara di Ierone II, sulla quale si sacrificavano a Zeus
Eleutherios ben 450 tori, che squartati e divisi in pezzi venivano posti
ad arrostire sull’altare, pingue sacrificio alla divinità, che,
supponiamo, accogliesse grata il fumo opimo. Un uso «alto» dei quattro
quarti, carni per l’élite dei guerrieri e dei nobili, e gli altri pezzi,
il quinto quarto? Pezzi contesi dai cani e dai miseri. Ma oggi, quanto
di uso delle carni povere è presente sulla nostra tavola, o è possibile
ordinare al ristorante?
Fatta eccezione per polpette e polpettoni, sappiamo
tutti che per mangiare trippe e rognoni dobbiamo santificare qualche
vecchia zia o affezionata domestica che sappia prepararne, mentre i nomi
dei ristoranti sono confidati in segreto come nella carboneria. Quindi,
a partire dalle definizioni note di quinto quarto, come carne quasi di
risulta, una differenza sostanziale divide le rigaglie dalle frattaglie:
le prime derivano da
rigàglia nel senso di «bocconi da re» regalie; mentre
le seconde, le frattaglie appunto, da frango (spezzo) comprendono quanto
risulta al di fuori dei pezzi interi di carne. Le definizioni precisano
bene il contesto di appartenenza, indicando in rigaglie «dono di re», e
non scarti donati alla servitù, prerogative ben esplicitate dal nome ove
si pensi alla quantità di volatili necessari per formare quel piatto
noto come «i fagioli di Re Ferdinando», (tutto di testicoli di pollo)
appartenente alla regale cucina netina, o quello del «cappello del
prete», caro a un famoso abate.

Approdiamo nel tempo a più recenti usi e
consuetudini, facenti capo entrambi a due soggetti opposti per rango e
possibilità, le mense regali e dall’altro lato, la strada, affamata di
cibo a basso costo ma buonissimo: un uso popolare del quel quinto
quarto, non compreso nella bestia per l’appunto «squartata»,
alternativamente cibo di re e di poveracci.
Questa storia, in Sicilia, l’abbiamo visto, risale
fino all’epoca omerica e rende conto di tutto il patrimonio di
consuetudini gastronomiche stratificatesi sul fondo culturale, ma
certamente sopravanzate dall’urgere delle istanze sociali.
Come dimenticare, mangiando, che qui hanno convissuto
le religioni di Cristiani, Musulmani ed Ebrei, con i loro diversi
apporti culturali? Sembra un gioco riportare i cibi a questa o quella
dominazione: araba, normanna, sveva, ….
E ogni cultura ha lasciato un segno, un uso
particolare, parole nuove, e anche sfottò linguistici.
Modi di consumare il cibo che si portano appresso la
storia delle comunità religiose che in città e nell’isola hanno
convissuto. Quanto pesi la storia sugli usi alimentari lo si nota
osservando una delle più antiche incisioni riguardanti la Siracusa
medievale, quella di Foresti da Bergamo del 1483, che presenta in uno
spazio fra le muraglie che si affacciano sul mare, la inconsueta
immagine di quarti di carne appesi, bene in vista in un posto preciso
della città, quello della «Turba», luogo riservato al macello e al
mercato della carne dei Giudei. La beccheria, cioè il macello della
Giudecca posto fuori le mura, vicino al mare nella parte occidentale di
Ortigia, non lontano dalle concerie tra la porta Marina e la fonte
Aretusa. La comunità ebraica si era concentrata in un’aggregazione nella
zona che fu chiamata, Jurecca, Giudecca, potendo così seguire più
facilmente i precetti religiosi, come la frequentazione della Sinagoga,
i bagni rituali e la macellazione delle carni, tajura, espressione usata
in Sicilia per la macellazione Kasher. Il luogo era prima, in realtà,
«fra li cantunerifausi …et eratturpissimus omnibus fetoribusplenus». La
presenza del macello era causa di fetore insopportabile, sicchè si
fecero leggi «ad trasferendum» per allontanarlo dunque all’aria aperta,
vicino al fossato e al mare. Ma ci fu un giorno, quello dell’editto del
1492 di Ferdinando il Cattolico in cui fu ordinata l’espulsione dal
Regno. Abbandonarono la Sicilia per un esilio infinito gli Ebrei, ma
moltissimi dei loro usi rimasero.

In primis quello divenuto tradizione del consumo
delle frattaglie. Esse rappresentavano il «quinto quarto
», fatto di cervello, animelle, trippa, milza e
fegato. Fondamentale era che fossero senza alcuna traccia di sangue per
cui andavano arrostite sulla griglia prima di essere cucinate. Dagli
Archivi della Comunità Ebraica annotiamo «Animelle con i ceci, trippe
con l’agliata, lingue salmistrate, milze in padella con la salvia e
l’agresto, creste di pollo con aceto e cannella». Il trionfo totale
degli esiti di questa cucina si celebra a Palermo, mentre nella Sicilia
orientale si deve ricercare e scoprire in ricette quasi scomparse.
Ma la ricerca dell’Accademia consente una esperienza
straordinaria che può partire da squisiti tortelli di erbette, nel
contesto della cucina delle erbe, per arrivare nientemeno che a Goffredo
di Buglione, agli splendidi affreschi del castello della Manta e alla
prima Crociata.
Percorsi impensati e impensabili, per segreti di
monasteri e conventi, risonanti di laudi, come a Bingen, dove Il degarda
componeva mirabili cantie attendeva alla preparazione di salubri erbe, o
rintracciabili in un silente refettorio, nel quale la rigidità della
regola è trasmessa in un parco piatto vegetariano, come negli austeri
affreschi delle pareti della certosa di Calci, di severa sobrietà
consonante al digiuno anche quando è la Regina a servire il pranzo ai
monaci, e, per converso, il convento dei Benedettini dove in falsa
astinenza,
monaci voraci digiunano banchettando con «carizzi di
ficatu».
Tutto il «ventre molle» della golosità traspare da
questa cucina degli scarti, e non ci sorprendiamo della grandissima
popolarità e ancora largo consumo della «regina» di essi, la trippa. La
popolare trippa, viene cantata dal maggior poeta erotico catanese Miciu
Tempio, che fa augurare al suo emblematico personaggio
Mmetta, omumangiuni: «... tutta la sciara ‘ntrà ‘na
botta canciarisi si vulissi in trippa cotta! ».
Invece perplessi rimaniamo di fronte alla inusitata
cena di Pirandello, nella quale, proprio il metafisico autore di
sofisticati drammi esistenziali, trema di voluttuosa soddisfazione
pregustativa, al solo guardare la tavola imbandita per il Natale: ”Ora
il pranzo, era lì, pronto fin dalla vigilia,.. una pallida porchetta
illaurata, … sette lepri scojati, tordi, tacchini, abbacchio; trippa e
cute affettate; piedi di bue in gelatina... ”
E chi direbbe ancora che dall’austera solitudine del
convento degli Olivetani sia sortita quella preparazione di trippa
“all’olivetana”, tripudio di masticazione tattile frammista a profumato,
scorrevole unto? Ma proprio questo è il paradosso di questo tipo di
cibo, “estàsi” fra fame e voracità.
Cettina Voza - La Siclia del 5.11.2013

IL RITORNO DEL SANGELI
(CON LA PROVA)
Ottavio Cappellani - La Sicilia del
24.11.2019 Cappellani - La Sicilia del
24.11.2019
Notizia raccolta sul
campo, anzi accanto alla "quarara", che, per chi non lo sapesse è il
pentolone dove si mette a bollire il "quarume", bollito vario di
interiora di bovino e suino. Per essere tassonomici le quarare sono due,
esse camminano accoppiate ("camminano", proprio così, perché stiamo
parlando di "street food"). Nella seconda quarara risiede il "sangeli"
(quando hai poca fame), il "sancieli" (quando hai proprio voglia), il
"sanguinaccio" quando vuoi fare il fino (ammesso che ci siano pazzi che
vogliano affettare raffinatezza andandosi a calare il sangeli con lo
zibibbo, evvabbè). Il sangeli (o sangele) si divide a sua volta in
sangeli propriamente detto, e nella "matruzza".
Per chi non lo sapesse,
stiamo parlando di sangue di maiale dentro il budello dello stesso
animale, che una volta bollito prende una consistenza budinosa che fa
urlare di ribrezzo i vegetariani. E fanno male, perché carne nella
quarara non ce n'è (a parte un po' nel "musso", il muso, la funcia
dell'animale), c'è solo sangue, budello, grasso, proteine di varie
forme: stomaco, trippa, centopelle, calcagno - detto carcagnola -
stigghiola (bollita, non alla brace all'uso palermitano), zzirena (con
due zeta, con due zete, insomma con la zzeta rafforzativa) e colesterolo
in varie fogge e colori e sapori.
La notizia è la seguente: alle diciannove
praticamente è tutto finito, mentre, di solito, fino alle ventuno,
trovavi le quarare non dico piene ma pronte a soddisfare quel, come
dire, schiticchio di sangeli che ti viene all'approprinquarsi del
freddo.
Non se lo spiegano neanche i sangelari. Mario, che
esercita in via Leucatia, dice che questa stagione è partita col botto.
"Non so il motivo, ma rispetto all'anno scorso ci sono molti più
clienti".
Ed è tanto vero che da qualche giorno, il sangele, al
posto di essere l'appuntamento dell'aperitivo rinforzato catanese (il
drink è uno solo, lo zibibbo) te lo devi andare a mangiare all'orario
della merenda (dei campioni).
Io posso registrare il trend. Il motivo? Non ne ho
idea. Probabilmente la causa è la crisi economica intrecciata con il
climate change. So solo che quando ci porto le turiste dico che è il
Viagra catanese. Come il "mulune", con la prova.

Il
fascino delle dita è tardo a morire, ancora oggi siamo tentati a
mangiare... il pollo con le mani e non solo.
Oggi si
ritorna alla sensualià tattile, ci sembra degante chiamare tante
sfizioserie finger food. Forse nessuno si scandalizzerà se a fine pasto
qualcuno si leccherà le dita. Solo nel 1700 per agevolare la presa degli
spaghetti, Gennaro Spadaccini, cuoco di Ferdinando IV di Borbone, ideò
l'attuale forchetta a quattro rebbi corti, nella speranza che il suo re
uti lizzasse le mani per atti più regali. Ma a Ferdinando l'invenzione
non piacque e continuò, con disgusto della raffinata Maria Carolina, ad
arraffare i maccheroni con le mani.
La cucina dei
bbuffittari purtroppo tende a scomparire, è sostituita dai vari Mc
Donald's e self service dove tutto è all'insegna del mangia e fuggi che
soddisfano le moderne esigenze ma sono lontani dalla cultura, dal
territorio, dalla storia siciliana e stanno involgarendo e globalizzando
il gusto dei nostri giovani e non solo.
Da secoli i
siciliani mangiano frittole e cazzilli e nessuno è mai andato in
ospedale.
La
globalizzazione ha eliminato il fascino stagionale dei sapori, mangiamo
ciliege a Natale e arance a Ferragosto. La nostra secolare cucina
rischia di cedere ai precotti, ai surgelati, agli inscatolati. alle
pentole a pressione, ai forni a microonde, ai robot, alla cottura
sottovuoto e a vapore. La carbonella e la legna hanno ceduto il posto al
gas, gli untensili di rame e terracotta all'acciaio. Anche il nostro
vecchio piatto è stato sostituito da poco invitanti piatti di design,
dove "T'elaborato gastronomico" viene posto come una piccola opera
d'arte astratta (food design) tale da soddisfare il gusto culturale ed
intellettuale ma spesso non il buon gusto del palato.

In questi
ultimi anni si cerca di contrastare la massificazione del gusto con la
riscoperta delle cucine regionali, dei slow food, della cucina
casereccia. Sono spesso degli ingenui rifacimenti della cucina popolare.
Le verdure, i
cereali da soli o insieme senza alcun condimento costituivano le zuppe
dove bagnavano il pane nero qualche volta con la barba verde della muffa
come l'ha chiamata Verga. Oggi gli chef sofisticati pare che l'ab-biano
riscoperta presentando le zuppe come creme e vellutate.
Anche le
sagre vorrebbero essere un viaggio nella tradizione. Nei tempi passati
la sagra o la festa del Patrono era accompagnata dalla fiera, dal
mercato, dai divertimenti e dai balli. Oggi indipendentemente dalla
festa del Santo del paese si fanno sagre di tutti generi: della cipolla,
dell'aglio, del formaggio, della ricotta, del pesce, del maiale, del
pistacchio, e chi più ne vuole più ne metta. Si cerca di tornare alle
vec- chie tradizioni e agli antichi sapori che i giovani non hanno
conosciuto e purtroppo oggi non potranno apprezzarli nella veste
originaria. Gli anziani sono delusi dalle novità, che non hanno nulla a
che con i sapori di un tempo.

Le condizioni
climatiche sono diverse, le piante geneticamente modificate, gli
antiparassitari per combattere nuove malattie sono in uso anche indiscri
minato e infine il prodotto viene lavorato con metodi industriali
sofisticati che spesso ne alterano le caratteristiche organolettiche.
Anche le nostre abitudi- ni ei nostri gusti sono cambiati. Si cerca
anche di ricreare la cucina storica, il cui fascino non può che essere
una curiosità culturale.
Oggi tutto è
diverso compreso il nostro gusto. Sarebbe bello se le inevitabili
innovazioni, rispettassero la nostra cultura e la nostra storia.
Fonte:
SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne
editrice 2019
___________________
.jpg) Le
panelle di Palermo Le
panelle di Palermo
La storia gastronomica dei popoli mediterranei è ricca di pietanze,
inventate o importate dai popoli occupanti, e poi radicate sui
territori.
Tra i consumi alimentari primordiali, la leguminosa pianta erbacea del
cece, originaria dell'oriente, che cresce spontanea in tutto il bacino
del Mediterraneo, occupa un posto di rilievo. Basti pensare che i suoi
semi sono presenti nelle mense più povere di latini e arabi, popoli
distanti fra loro parecchi secoli.
Gli arabi, dominatori della Sicilia a cavallo tra il 9° e l'11° secolo,
avvezzi alla sperimentazione gastronomica, ne macinarono i semi,
ricavandone una farina che mescolata all'acqua e cotta sul fuoco dava
una sorta di impasto crudo, dal sapore non eccezionale. Ma una sfoglia
sottile di questa pasta, cotta a sua volta in una sostanza oleosa, diede
vita alla prima "panella": una sorta di "schiacciata" di piccole
dimensioni, di un bel colore dorato. Il detto: "pari 'na paniella"
(sembra una panella) è appunto riferito ad oggetti che hanno avuto la
malasorte di trovarsi schiacciati sotto pesi eccessivi.
Prerogativa del territorio, le "panelle" si possono gustare solo a
Palermo e dintorni, associate al pane, e rappresentano il caratteristico
spuntino del palermitano. Si dice che non esista cittadino palermitano,
di vecchia o di nuova generazione, che non le abbia gustate almeno una
volta. Studenti e scolari nell'ora di ricreazione, negozianti,
impiegati, manovali, artigiani, nelle pause di lavoro. Le deliziose
frittelle di ceci, travalicano, con il loro superbo gusto, ogni
differenza di censo e di cultura.
Si possono acquistare in una serie infinita di "friggitorie", di tipo
fisso od ambulante, sulle strade di grande traffico, nei quartieri
popolari o residenziali, nei quartieri nuovi, nel centro storico.
I luoghi di stazionamento delle friggitorie ambulanti sono, da sempre e
puntualmente, i luoghi ove a certe ore si verifica un notevole movimento
di persone: quindi scuole, uffici, grandi magazzini, chiese, cimiteri e
finanche i campi sportivi nei giorni in cui si svolgono gli incontri. In
passato il panellaro si presentava con la carretta sulla quale era
montata una baracca di legno chiusa da tre lati. Al suo interno erano
posizionati: un fornello in pietra lavica sul quale una grande
casseruola veniva utilizzata per la frittura, un ampio ripiano in cui si
mostravano le panelle già fritte contenute in piatti di alluminio, un
contenitore di latta (barattolo di conserva) con il coperchio
bucherellato per il sale, usato in funzione della richiesta del cliente.
In un'angolo emergeva una piccola collinetta di "mafalde", una classica
forma di pane con la "gigggiulena" e, appesi ad un gancio, i rettangoli
di carta già tagliati a mo' di tovagliolo.
In tempi più recenti hanno fatto la loro apparizione le "motolape" e i
furgoncini che, attrezzati di tutto punto, portano in giro il prodotto
già pronto per essere cucinato a richiesta, perché, per gustarle a
dovere, le panelle devono essere molto calde. Una volta raffreddate,
anche se insaporite con qualche goccia di limone, perdono il gusto
originale. Se si prova poi a riscaldarle il risultato non è dei
migliori. Vanno gustate calde, e basta.
Il destino delle
panelle è condiviso con le crocchè, o "cazzilli" come li chiamano
comunemente i palermitani richiamandosi alla loro forma fallica. Panelle
e crocchè sono inseparabili, stanno sempre accanto e talvolta vengono
mangiate insieme, nello stesso panino.
La contraddizione tra i due cibi è dovuta alla materia prima di cui sono
composti. Le crocchè, ritenute meno classiche, sono realizzate con la
patata, umile tubero importato dal nuovo mondo cinque secoli fa. Un
connubio, questo, di prodotti vegetali diversi e di culture diverse.
Entrambi erano riposti dentro "u cannistru" (il canestro) e coperti da
una "mappina" (salvietta a quadri), pronti per essere fritti.
Corre voce che,fino a qualche anno fa', per verificare la temperatura
dell'olio, il panellaio di tanto in tanto adottasse un sistema… che
preferiamo non riferirvi (comunque approvato dai clienti) ma che gli
segnalava la condizione termica ideale. Quindi, armeggiando con alcune
schiumarole (manico lungo, manico corto, veri attrezzi del mestiere)
immergeva le panelle e, rimestando, in pochi minuti serviva gli attenti
clienti che là davanti seguivano con attenzione il processo di cottura.
.jpg) Altro prodotto da "friggitoria" era la melanzana, da sempre accreditata
come la "carne dei poveri": tagliata a "fieddi" (fette) , poi fritte, da
mettere in mezzo al pane o "a quaglia" (nulla a che vedere con l'omonimo
volatile) cioè incisa lungo i lati, lasciando la parte superiore
integra, poi fritta intera, ideale nella stagione estiva per una
colazione in riva al mare.
Altro prodotto da "friggitoria" era la melanzana, da sempre accreditata
come la "carne dei poveri": tagliata a "fieddi" (fette) , poi fritte, da
mettere in mezzo al pane o "a quaglia" (nulla a che vedere con l'omonimo
volatile) cioè incisa lungo i lati, lasciando la parte superiore
integra, poi fritta intera, ideale nella stagione estiva per una
colazione in riva al mare.
L'evoluzione ha portato alla nascita di diverse friggitorie, ovviamente
più evolute dal punto di vista della scelta gastronomica, che si sono
localizzate in più parti della città, divenendo un punto di riferimento
per i clienti del "fast-food" alla palermitana. Questo tipo di locale
richiama alcuni locali dei mercati arabi, ma anche alcuni delle città
spagnole: ambedue friggono ogni sorta di vivanda, poi consumata per
strada.
Il panellaro inizia la sua attività la mattina presto, in modo da
fornire alle maestranze edili, già nella prima mattina, la possibilità
di consumare una prima colazione a base di pane e panelle, con o senza
l'aggiunta delle crocchè.
Le panelle, si preparano facendo sciogliere la farina di ceci in acqua
con sale e prezzemolo.
Poi si pone il recipiente sul fuoco e si rimescola continuamente sino ad
ottenere una pasta piuttosto solida (tipo polenta) che, ancora calda, si
spalma in apposite formelle di legno di faggio dalla canonica forma
rettangolare (4x8 cm). Sulla formella di legno può essere inciso un
elemento floreale che, al raffreddamento della pasta, forma sulla
panella cruda un rilievo di circa 3 millimetri.
Il Pitrè ci riferisce che in passato questi rilievi avevano differenti
forme tra cui, più frequente, quella di pesce. I "i pisci-panelli", così
le chiamavano i più indigenti che, mangiandole, s'illudevano di mangiare
frittura di pesce, allora troppo costosa.
Arrivano ben calde e gonfie sul bancone, dove sono adagiate in un
ripiano d'alluminio bucherellato per permettere all'olio di scolare, e
in men che non si dica vanno a riempire la pagnottella che sarà tagliata
a metà, aperta a mo' di cerniera, e riempita.
I cazzilli o crocchè si ottengono bollendo le patate che, una volta
pelate, vengono passate per creare una purea piuttosto densa a cui si
aggiunge prezzemolo o menta, sale e pepe.
Utilizzando le esperte mani, si formano delle crocchette dalla tipica
foggia ellittica, della lunghezza di circa sei centimetri. Anche queste
vengono poi fritte in abbondante olio di semi.
Dalla preparazione delle panelle e delle crocchè, raschiando con una
paletta sia il fondo sia i bordi delle casseruole dove era stato
preparato l'impasto, si otteneva un nuovo impasto fatto dalle due
materie prime. Con questi impasto si produceva una crocchetta di
"rascatura" dal gusto particolare e, cosa da non sottovalutare, dal
prezzo ancora più basso, per chi non poteva permettersi neanche le
crocchè tradizionali.
In ogni stagione altre fritture arricchiscono il bancone della
friggitoria, per la delizia degli avventori, e così troviamo i cardoni
(cardi) e broccoletti (cavolfiore) "alla pastella", i carciofi, le
arancine di riso con carne o burro, lo sfincione (sorta di pizza morbida
molto spessa, condita con la cipolla), i timballi di pasta al forno o di
riso o di verdure, il "grattò" (gatteau di patate), e ancora, frittate
miste con erbette di montagna, sarde a "beccafico", fritture di
maccarroneddu o cicireddu (piccoli pesci e pesciolini), di calamari, e
l'intramontabile "caponata" il cui ingrediente base è la melanzana.
Le friggitorie ricalcano antiche tradizione della Magna Grecia, quando
al "thermopolium" (antico bar - tavola calda) si compravano pietanze
cotte, da consumare per strada.
Un momento importante per le panelle (e per le arancine) si riscontra il
13 dicembre, giorno in cui si festeggia Santa Lucia e, per devozione, in
tutta l'isola, non si consumano farinacei.
(n.d.r.)
Ciò che è stato narrato, pur con dovizia di particolari storici, non può
né potrà mai sostituire l'esperienza diretta: al viaggiatore
raccomandiamo quindi di soffermarsi davanti ad una friggitoria, prima di
acquistare il "pane con le panelle", per assaporare gli intensi profumi
dei vari ingredienti. Poi assaggi. Il gusto "unico" della panella
solleciterà le sue papille gustative come non mai. Degustandola, provi a
guardarsi attorno… i palazzi… le chiese… la storia, gli sembrerà di
farne parte Molti, prima di partire, ci ritornano. Molti, la seconda
volta, appena scesi dal traghetto, girano subito a sinistra per andare
alla tal panelleria dove due anni prima…
Carlo Di Franco per PalermoWeb.com
Sono stati
gli Arabi a realizzare le saporite panelle palermitane. Sono delle
fettine di polenta di ceci condite con prezzemolo e fritte, che i
bbuffittari vendono ancora oggi cavuri cavuri (calde calde) alla
Vucciria. Le panelle sono la versione antica e semplice delle falafel
(polpettine di farina di ceci e verdure fritte), diffuse tra la
popolazioni del Nordafrica e in Israele. Anche i Romani preparavano
polpettine di cereali.
I ceci
entrarono di prepotenza nella storia siciliana quando al suono delle
campane della Chiesa del Santo Spirito del Vespro del lunedi di Pasqua
del 1282 il popolo palermitano, presto seguito da tutti i Siciliani,
insorse contro il mal governo di Carlo d'Angiò che era stato posto sul
trono dal Papa. Dante immor talò l'avvenimento nel VIII canto del
Paradiso: «Se mala signoria che sempre accora/li popoli suggetti non
avesse mosso Palermo a gridar: mora, mora!”
Mi piace
riportare la cronaca redatta da un anonimo del tempo: Lu rebella mentu
di Sicilia et intraru intra la chitati cum grandi rimuri, et foru per li
plazi et quanti Franchiski trovavano, tucti li auchidianu. Di poi andaru
a lu steri di lu capitanu, et lu capitanu si rindiu cum certi pacti. Et
poi ki fu in putiri loru, non li foru actisi: lu auchisuru, et tucta la
sua compagna. Ancora andaru a li loki di frati minuri et frati
predicaturi, et quanti chi nni trovaru chi parlassiru la lingua
franchiska, li auchisiru intra li ecclesi A tre secoli di distanza
dall'avvenimento, Vincenzo Auria nel 1673 scrive: «E antica tradizione,
che dura sino ad ora come nel tempo dell'eccidio francese in Palermo,
che i palermitani, cercando sterminarli tutti, e dubitando di non
conoscerli tutti per francesi, incontrandoli per la città, gli facevano
proferi e ciciri in lingua siciliana; e perchè i veri francesi ciò non
potevano fare, ma solamente dicevano chichiri, dandosi a conoscere,
erano a morte feriti e trucidati dai Siciliani.
La drammatica
rivolta popolare non ha avuto né una leadership né un progetto politico
ed è finita tristemente nel nulla. Stipulata la pace della guerra dei
vespri pel 1302 a Caltabellotta, i baroni siciliani, sempre gli uni
contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a governare altri
potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio della Martorana
decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro di Aragona,
sposato con Costanza figlia di Manfredi re di Sicilia. La Sicilia rimase
"indipendente" sotto gli aragonesi fino al 1375. Furono anni di guerre e
ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri investiti dagli aragonesi.
Fonte:
SPIGOLATURE STORICHE SULLA CUCINA DI SICILIA – Gino Schilirò – Aracne
editrice 2019


Catania ha una grande "cultura" sulla carne equina....jpg) Dicono
che nella cottura della carne di cavallo, come si può constatare nei
rioni di via Plebiscito, il trucco sta nel buttare il salmoriglio Dicono
che nella cottura della carne di cavallo, come si può constatare nei
rioni di via Plebiscito, il trucco sta nel buttare il salmoriglio
non solo sulla carne, ma anche sulla brace (e che fumata!). Anzi, si
raccomanda di non usare la carbonella,.jpg) ma il carbone.
ma il carbone.
Per questo il turista spesso rimane sorpreso che a Catania possa
esserci la "nebbia" in ogni periodo dell'anno. Gli amanti del culto (eh
sì, lo è!) mangiano la carne equina persino cruda... ma c'è da
chiedersi: da dove vengono i cavalli che finiscono al macello? Sempre se
sia carne di cavallo... ma c'è chi garantisce che sia davvero carne
d.o.c. al 100%. Ma dove finiscono quei cavalli "dopati"di cui spesso si
parla nelle cronache cittadine vittime di incidenti in corse
clandestine? ...i vegetariani sono salvi! Intanto in America è sorta una
nuova preoccupazione: il consumo di carne di cavallo! Infatti gli USA
sono tra i più grossi produttori di carne equina, che viene importata
soprattutto dall'Europa, e sono molti i capi equini che finiscono sui
banconi delle macellerie. Tra gli attivisti della campagna contro la
macellazione dei cavalli ci sono nomi celebri, Clint Eastwood e Bo
Derek. Ambedue gli attori hanno lavorato tantissimo coi cavalli,
soprattutto la Derek! Ma gli Americani, come mangiano la carne di
cavallo? Arrostita con salmoriglio e messa in mezzo alla "vastedda" di
pane di casa?
http://salmoriglio.blogspot.com/2006_11_01_archive.html

(nd.r. I catanesi ne sono molto ghiotti. A Catania ci sono molti posti
dove si può mangiare in tutti i modi la carne di cavallo, . Io, invece,
mi fermo qui perchè, personalmente, trovo terribile mangiare la carne di
un animale come il cavallo. Clliccate
qui
e forse, dopo, cambierete idea.

Carne di cavallo: colore rosso vivace, succulenta,
dal gusto indiscusso con tendenza dieci su dieci al dolciastro, da
mangiare se possibile al sangue. Se anche voi ne siete appassionati
sappiate che c’è un solo posto in Italia dove viene santificata,
adorata, riverita.
Una città dove la carne di cavallo è l’unica e
indiscussa regina della gastronomia da strada, diventata tradizione
molto tempo prima che “street food” diventasse un termine di uso comune.
Quel posto è Catania, ma se volete godere della
squisitezza di questa carne, al netto dei problemi etici che può creare
mangiarla, dovete sporcarvi le mani: i luoghi dove bisogna andare non
sono certo segnalati dalla Guida Michelin.
La regola è infatti solo una: più il quartiere di
Catania è popolare, più è considerato poco raccomandabile, e più la
carne di cavallo sarà buona. Più sarà internato e inquietante, più si
assaporerà la genuinità della tradizione.
ARROSTITA SULLA BRACE O BOLLITO?
Cotta alla brace, la si può mangiare al tavolo o in
piedi, nel panino, e nei posti più antichi direttamente nel tovagliolo
di carta. In tutti i casi, che sia fettina o polpetta, fondamentale è il
‘salamarigghiu’, un intruglio di olio, aceto, sale e abbondante origano
che l’addetto alla cottura spennella sulle fettine ancora sul fuoco con
la tradizionale “bruscia“ ricavata da un mazzetto di origano.
Trinca, ossopiatto, lattughina, costata, policiata, a
differenza della carne vaccina qualsiasi taglio è adatto all’arrosto.
La spiegazione dei macellai etnei è semplice:
“cavaddu curri, u viteddu zappa“.
Arrosto dunque, ma non solo. Se sarete così curiosi
da spingervi nei quartieri più popolari potrete assaggiare il bollito,
un vero rituale che nelle macellerie equine inizia sin dalle prime ore
del mattino.
Sul ciglio della strada, un unico pezzo di carne
viene fatto bollire in enormi pentoloni. A cottura ultimata viene
spezzettato. Lo si può assaggiare sul momento condito con olio, sale,
pepe e limone, oppure lo si può comprare per mangiarlo comodamente a
casa.

dal video CATANIA FOOD TOUR di Sofia, qui:
https://www.youtube.com/watch?v=8bjF6tw3eWQ&t=129s
Catania - Lo diciamo prima: questo cibo non è per tutti,
sappiamo che molti non amano mangiare il cavallo, ma siccome invece a noi piace
e riusciamo a mangiare di tutto senza ritegno, per quanto ci riguarda che si
tratti di cavallo, mucca, pollo, maiale o agnello, non ci facciamo pregiudizi. E
come tutti sanno, per assaggiare dell’ottimo cavallo bisogna andare a Catania.
Catania, la città dove in via Plebiscito non puoi muoverti senza essere
investito da una densa coltre di fumo aromatizzato alla carne. Catania, la città
dove arrostire la carne fuori, in barba a tutte le regole igieniche, è
socialmente accettato. E diciamocela: la carne è buonissima, vero street food
d’altri tempi in cui la fettina si gira con le mani…e il tizio del braciere
nemmeno si ustiona!
E quindi, presi da un momento di entusiasmo per la carne
equina, abbiamo deciso di mangiare in una delle trattorie più note della città,
dove la carne di cavallo si cucina dentro e fuori. Stiamo parlando della
Trattoria Achille, vero must della cucina etnea di strada. Faceva ancora un po’
freddino e quindi ci siamo messi dentro. Il locale è un tripudio al Catania
calcio, con le magliette dei giocatori appese alle pareti e i tavolini con le
tovagliette di carta, proprio come vuole la tradizione catanese. Oltre ad avere
la possibilità di assaggiare il cavallo in tutti i modi, dalla classica fettina
arrosto all’ottima salsiccia, è possibile anche gustare l’ottimo buffet di
antipasti: un tripudio di parmigiana di melanzane, frittatona di ricotta e
spinaci e wurstel con cipolla.
E poi ancora peperoni arrostiti, caponata di melanzane,
piselli, zucchine grigliate e…e poi non mi ricordo. C’era di tutto.
E poi è arrivato il momento clou della serata: assaggiare le
prelibatezze a base di carne di cavallo. Eccezionali le polpette: morbide,
succose, cotte al punto giusto. Veramente ottima anche la salsiccia di cavallo,
condita con cipolla e spezie: la carne si scioglieva in bocca ed e non è
risultata né pesante, né salata. Ma se volete comunque provare la
Trattoria Achille e non volete mangiare carne di cavallo, non preoccupatevi. Il
menù offre la possibilità di mangiare altri tipi di carne, come gli involtini di
suino, pistacchio e philadelphia, oppure i triangoli di manzo conditi con
formaggio filante e rucola. Insomma, il menù è piuttosto vario e comprende anche
i primi. Naturalmente, non mancano nemmeno le stigghiole, fatte con cipolla e
intestino, ma questa è roba solo per stomaci forti.
Ideale per una serata alternativa alla solita pizza, tanto si
spende anche meno.
Irene Savasta
https://www.ragusanews.com/2018/03/30/attualita/vero-street-food-carne-cavallo-catania/87362

DOVE MANGIARLA


|
|

Territorio
interessato alla produzione: Catania e comuni del comprensorio.
Descrizione
sintetica del prodotto: Gelatina di maiale
Descrizione
delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura:
Ingredienti: parti non commestibili del maiale, e tocchetti di carne di
maiale, chiodo di garofano, foglie d' alloro sale e pepe in grani.
Preparazione: alcune parti del maiale come il muso, le orecchie, i
piedi, la cotenna e pezzetti di carne attaccati alle ossa (della zampa)
vengono messi in un gran pentolone e fatti bollire insieme al sale al
pepe in grani e al chiodo di garofano. Il brodo così ottenuto viene
sgrassato, filtrato e rimesso sul fuoco amalgamato con tocchetti di
carne di maiale, succo di limone e foglie d' alloro; ancora caldo viene
versato in contenitori o formelle il cui fondo si cosparge di pepe nero
e rosso e fatto raffreddare in modo che si rapprenda. Viene consumato
freddo e tagliato a fette
Materiali
e attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione e il
condizionamento: Nessuna attrezzatura specifica
Descrizione
dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura: Laboratori di
gastronomia, macellerie e ambienti domestici
Elementi
che comprovino che le metodologie siano state praticate in maniera
omogenea e secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai
25 anni: Prodotto legato all' antica tradizione dell' uccisione del
maiale. Dalle parti non commestibili veniva creato a caldo un prodotto
che raffreddato ha la consistenza gelatinosa. "Quando il sole avrà
preso corpo e scaldato l' aria fatevi offrire dal massaro alcune fette
di zuzzu, portentosa gelatina a base di carne di maiale". (Piero
Isgro, Sicilia a tavola)
Fonte:
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 6/02/1999 - Parte I n.6
Ingredienti:
Dosi:1 kg. di carne di maiale, un piede e l'orecchia di maiale, 1
bicchiere di aceto, succo di limone, pepe rosso.
Istruzioni
per la preparazione: Mettere a bollire le parti del maiale in molta
acqua salata per circa tre ore. Poi mettere da parte la carne,
aggiungere al brodo un bicchiere d'aceto e farlo bollire a lungo fino a
ridurlo ad 1/4 della quantita' iniziale. Lasciare riposare per una notte
intera. Il giorno dopo filtrare il brodo e aggiungere succo di limone;
intiepidirlo e versarlo sulla carne gia' tagliata a fette e sistemata
nei piatti e condita con pepe rosso macinato.
 |
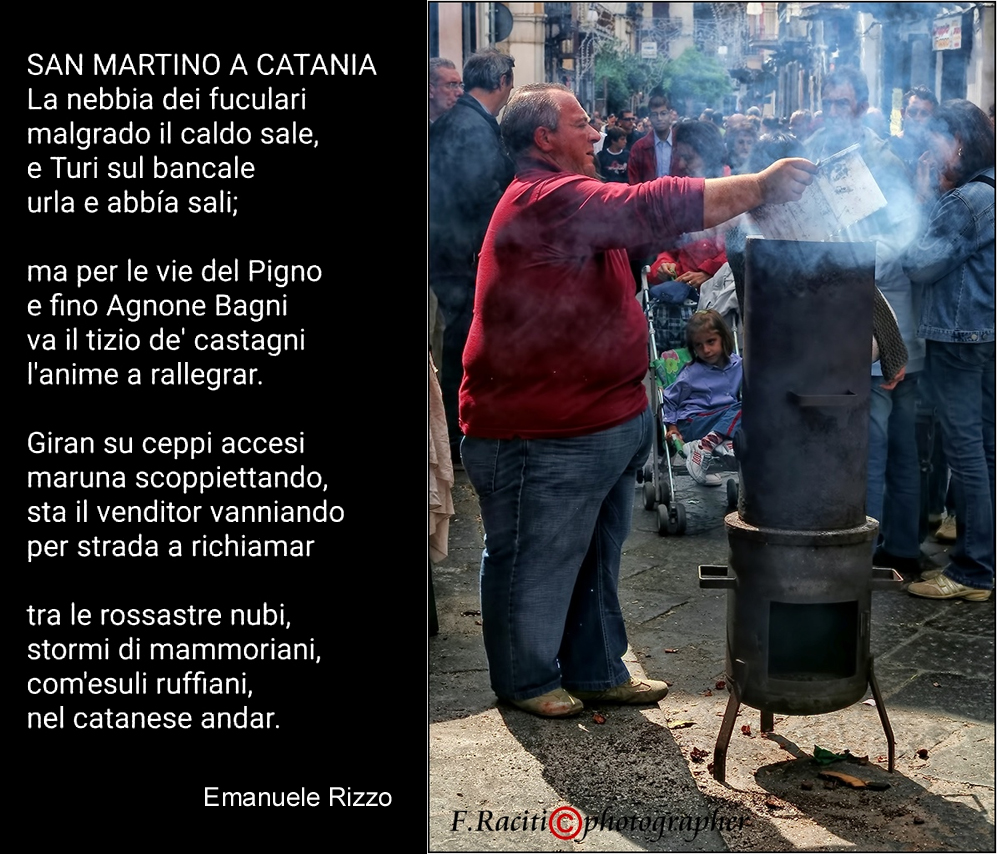
L'11
novembre la festa che celebra il vescovo di Tours, noto come San Martino.
Proverbiali la sua umiltà e la sua carità che hanno dato vita ad alcune
leggende, una delle quali legata alla cosiddetta estate di San Martino, la quale
si manifesta, in senso meteorologico, all'inizio di novembre e dà luogo ad
alcune tradizionali feste popolari.
La
leggenda narra che Martino, figlio di un ufficiale dell'esercito romano, a causa
di un'ordinanza dell'epoca divenne anch'egli soldato romano e trovandosi, in una
grigia giornata d'autunno, alle porte della città di Amiens con i suoi soldati
incontrò un mendicante seminudo. D'impulso tagliò in due il suo mantello
militare e lo condivise con il mendicante. Miracolosamente il freddo si
affievolì e comparve il sole: fu quella la prima estate di San Martino.
Questa
data, simbolicamente associata alla maturazione del vino nuovo, ed alla
«svinatura» - da qui il proverbio "A San Martino ogni mosto diventa vino" - è
quindi un'occasione di ritrovo e festeggiamenti nei quali si brinda, appunto,
stappando il vino appena maturato e molte cantine aprono le loro porte alla
degustazione. Il proverbio «S'ammazza lu porcu e si sazza lu vinu» è legato alla
tradizionale uccisione del maiale che avviene in alcuni paesi per farne
prosciutti, salami e salsicce.
Sagre e
feste in questo giorno, occasione buona per gustare le classiche caldarroste e
del buon vino novello, ma anche il pane casereccio, ed i dolci tipici di questa
ricorrenza come i biscotti di San Martino.
Nel
Palermitano si mangia u viscottu di San Martino abbagnatu, i biscotti,
realizzati con una forma rotondeggiante ed aromatizzati con semi d'anice,
vengono gustati bagnati nel vino moscato. Questi tipici dolci, che abbondano
nelle pasticcerie siciliane anche un mese prima della ricorrenza, possono essere
di vari tipi: il tricotto (croccante e friabile, destinato all'inzuppo), il
rasco (pasta morbida, inzuppata di liquore, destinata ad essere riempita di
crema di ricotta) e la versione del biscotto decorato (pasta morbida, scavato e
riempito di conserva, glassato e merlettato con zucchero e decorato con un
cioccolatino e frangette d'argento).
I
biscotti di San Martino
sono dei
particolari biscotti artigianali, che si preparare l’11 Novembre in memoria di
San Martino.
Un chilo di
farina - 00 50 grammi lievito di birra 300 - grammi di zucchero semolato 200 -
grammi di strutto 30 grammi di semi di anice Un pizzico di cannella (meglio se
in bacca) 40 grammi di burro, -sale.
Sciogliere
il lievito di birra in poca acqua tiepida. Setacciare la farina in una grande
ciotola e versarvi il lievito sciolto nell’acqua. Lavorare con un cucchiaio di
legno e, continuando ad impastare, amalgamarvi lo zucchero, lo strutto, i semi
di anice, la cannella e tanta acqua per ottenere un impasto morbido ed elastico
(la consistenza deve essere come la pasta di pane). Lavorare l’impasto fin
quando si formeranno le bolle di lievitazione, quindi ricavare dei bastoncini
della lunghezza di circa dieci centimetri che avvolgeremo a spirale in modo da
ottenere delle ciambelline. Adagiarle, distanziate tra loro, in una teglia
imburrata e metterle da parte a lievitare, in luogo tiepido, per qualche ora.
Quando
saranno ben gonfie mettere in forno preriscaldato a 200° per dieci minuti,
quindi sfornarli e portare il forno alla temperatura di 160° e infornare di
nuovo per altri 20 – 25 minuti avendo cura che non scuriscano troppo. Una volta
cotti lasciare i biscotti a riposare nel forno spento per qualche ora, così
raggiungeranno quella particolare croccantezza e friabilità caratteristica.
A SPASSO
PER LA SICILIA
La
tradizione di San Martino in Sicilia è molto diffusa e sono diversi gli
appuntamenti che si possono seguire.
LINGUAGLOSSA (CT). Piazza dei Vespri Siciliani 11 novembre dalle ore 19:00.
Degustazione di piatti della tradizione siciliana e spettacolo di musica Folk.
ZAFFERANA
(CT). Festa di San Martino, castagne e vino nella piazza di Sarro, frazione di
Zafferana Etnea.
PALAZZO
ADRIANO (PA). Festa di San Martino l’11 novembre. Originalissima e folkloristica
tradizione che festeggia le coppie sposate nell’arco dell’ultimo anno.
ROMETTA
(ME). San Martino Gimellese - Festa di San Martino nel piccolo borgo di Gimello,
poco distante da Rometta. Sabato 15 novembre c’è la degustazione di pane caldo
casereccio con l’olio, salsiccia arrosto, caldarroste e del buon vino novello.
RIPOSTO
(CT). Fiera di San Martino tra Castagne e Vino fino a martedì a Carrubba,
frazione di Riposto (CT) in Piazza Chiesa. S

|
La
cornice è quella del golfo di Catania: un arco che va da Capo Mulini a
Capo Santa Croce, nel comune di Augusta. Una porzione di mare tutelata
in parte dalla Riserva Naturale Marina delle Isole Ciclopi e solcata
ogni giorno dalle piccole barche dei pescatori del golfo. Qui, secondo
la stagione, si pescano aguglie, spigole,
tonni, triglie, sgombri, e masculini. I pescatori li chiamano anche
anciuvazzu o ancora anciuvurineddu: molti nomi per le piccole, guizzanti
acciughe, le stesse catturate dai liguri e dalle menaidi cilentane. Le
stesse che, diceva padron ’Ntoni ne I Malavoglia, «sentono il grecale
ventiquattr’ore prima di arrivare, (…) è sempre stato così, l’acciuga
è un pesce che ha più giudizio del tonno». Ad aprile, si comincia a
calare le tratte (così chiamano a Catania le reti menaidi, che hanno
maglie di un centimetro di lato e sono lunghe circa 300 metri): il
momento giusto è la notte fonda, quasi sul fare dell’alba. La tecnica
è la stessa praticata in tutto il Mediterraneo già dai tempi di Omero.
Questo meccanismo di cattura (l’imprigionamento della testa dell’alice
nelle maglie della rete, da cui il nome da magghia) provoca un
dissanguamento naturale che rende il pesce più gustoso e quindi
pregiato.

In Italia le flottiglie che praticano la pesca tradizionale
con la menaide sono poche: si trovano a Pisciotta, in alcuni piccoli
centri della costiera del Cilento (in Campania) e nel golfo di Catania.
Qui le famiglie che vivono di questo mestiere antico sono una trentina:
un gruppo sparuto – che si divide fra i porticcioli di San Giovanni li
Cuti, Ognina, Aci Trezza – e qualche civitotu (così si chiamano gli
abitanti del quartiere catanese della Civita) al porto di Catania.
Attualmente, i masculini da magghia sotto sale non sono in commercio: si
possono ancora assaggiare soltanto in qualche ristorante di Catania o
nelle dispense delle famiglie dei pescatori. Il neonato Presidio sta
tentando di riorganizzarne la produzione e la commercializzazione.
I
masculini si vendono freschi sul mercato catanese di piazza Pardo ( ‘a
Piscaria) oppure vengono messi sotto sale dalle mogli dei pescatori. La
tecnica di salagione è la stessa di tutto il Mediterraneo, ma qui
esiste una preparazione assolutamente unica, inventata dai pescatori
catanesi per sfamarsi durante le molte ore trascorse in mare. Si tratta
di una conserva fatta con pezzetti di alici e con le teste che rimangono
impigliate nelle maglie della menaide. Impossibili da vendere, questi
“scarti” erano consumati in barca. Tornati a riva, le donne di casa
mettevano ciò che rimaneva sott’olio di oliva, in vasetti di vetro o
in piccoli orci di terracotta (i cugnitti) e all’occorrenza se ne
prelevava una parte per cucinare sughi e salse.
Area di produzione: Golfo di Catania

|
|
LA
CARNE SOTTO IL VULCANO. LINGUAGLOSSA


Come cucinare le salsicce?
Del maiale, si sa, non si butta via nulla: dalle parti meno nobili, come
muso e piedino, si ricavano saporiti piatti regionali, mentre quello che
avanza dalla preparazione dei prosciutti, della pancetta e del carré, le
salsicce sono un prodotto versatile in cucina e apprezzate nella maggior
parte delle occasioni si insacca con spezie ed erbe e nel giro di
qualche giorno diventa una g ustosa salsiccia o un salame. Le salsicce in
particolare sono un alimento amato da quasi tutti, perfetto per essere
gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino croccante
con due foglie di insalata e una dose generosa di salse. Può capitare
però di dover preparare un pasto da mangiare con forchetta e coltello, e
di voler evitare la solita anonima padella: fortunatamente la salsiccia,
come il maiale, è versatile e si presta a numerose interpretazioni. Ecco
quindi 10 modi per preparare le salsicce, con qualche suggerimento di
cottura a cui forse non avevate ancora pensato. ustosa salsiccia o un salame. Le salsicce in
particolare sono un alimento amato da quasi tutti, perfetto per essere
gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino croccante
con due foglie di insalata e una dose generosa di salse. Può capitare
però di dover preparare un pasto da mangiare con forchetta e coltello, e
di voler evitare la solita anonima padella: fortunatamente la salsiccia,
come il maiale, è versatile e si presta a numerose interpretazioni. Ecco
quindi 10 modi per preparare le salsicce, con qualche suggerimento di
cottura a cui forse non avevate ancora pensato.
1 Alla brace: non a caso la salsiccia è la regina del barbecue.
Contrariamente alle abitudini più diffuse, non deve necessariamente
essere preparata da un maschio: il confronto diretto con fuoco e
carbonella è alla portata di chiunque sia animato da buona volontà.
L’importante è mettere la salsiccia intera sulla griglia, facendo
attenzione a non bucare il budello almeno per i primi minuti, così da
far cuocere la carne nel suo stesso grasso, in un amalgama unico di
profumi e sapori.
2 Sotto la brace, o meglio, sotto la cenere: ne serve di
caldissima e di solito la si trova come risultato di un fuoco acceso nel
caminetto o di un barbecue. Bisogna avvolgere bene le salsicce nella
carta forno o nella carta d’alluminio e lasciarle cuocere per circa 15
minuti. I cartocci si aprono direttamente nei piatti per non disperdere
il sughetto di cottura.
3 Alla piastra. È la tipica preparazione da panino, ma si può
replicare facilmente per abbinarla a un contorno leggero. La salsiccia
va tagliata a metà e privata del budello, per poi essere schiacciata
bene sulla superficie calda della piastra. Anche in questo
 caso
generalmente non occorrono grassi aggiuntivi. caso
generalmente non occorrono grassi aggiuntivi.
4 In padella, ubriaca. Bisogna bucare la salsiccia e farla cuocere
con un paio di dita d’acqua, che si riempirà presto del grasso della
carne e andrà eliminata. A questo punto si sfuma con il vino rosso, che
dà colore e sapore. La stessa preparazione si può replicare al
microonde, cuocendo la salsiccia a massima potenza per 5-7 minuti prima
con l’acqua e poi con il vino, per poi farla colorire eventualmente con
un passaggio al grill o in padella.
5 Tornando alla padella e alla salsiccia privata del budello, si
può preparare un saporitissimo ragù in bianco. Si spezzetta la salsiccia
nella padella calda e si sfuma a piacimento con l’aceto balsamico:
aggiungete la pasta, mantecate e gustate.
6 Al forno, in una pirofila con patate, cipolle o il contorno che
desiderate. La salsiccia si può bucherellare prima o durante la cottura,
per far fuoriuscire parte del grasso e insaporire così le verdure: è
bene tenere presente che il contorno andrà comunque condito con olio,
sale o altro prima dell’inizio della cottura.
7 Bollita. Basta lasciare la salsiccia in acqua bollente per
circa 30 minuti: farà tutto da sola.
8 Al cartoccio. Dovrete ungere bene un foglio d’alluminio e
disporvi le salsicce, le patate, gli aromi: chiudete tutto e lasciate
cuocere a 200 °C per una trentina di minuti.
9 Se preferite un ricco piatto unico, o un primo sostanzioso,
dovreste mettere della salsiccia ancora cruda fra le lasagne o gli
strati di polenta, e poi a cuocere insieme in forno. A piacimento unite
besciamella, funghi, formaggio e tutto ciò che vi stuzzica l’appetito.
10 Gli spiedini di salsiccia si cuociono bene in forno, ma sono
adatti anche alla padella, alla griglia o alla piastra. L’importante è
tagliare le salsicce in pezzetti di dimensioni uguali, alternarli con
qualche verdura per smorzare il grasso e ricordarsi di girare spesso gli
spiedi.

 |

|
IL
TEMPO DEL MAURO PERDUTO
Il
periodo è quello giusto, ma trovare questa erba marina lungo le coste
laviche catanesi è ormai un'impresa per colpa dell'inquinamento
Il
periodo è questo, ma bisogna sapere dove andare e, nonostante ciò,
essere fortunati. Poter gustare il "mauro" - o "u mauru",
in dialetto catanese - è infatti ormai talmente raro da essere una
delizia da veri gourmet. Si tratta di un'erba marina dai lunghi
filamenti callosi, un'alga commestibile che fino a qualche decennio fa
cresceva spontaneamente lungo le coste laviche catanesi e della Sicilia
orientale, ma che adesso è quasi scomparsa a causa dell'inquinamento.
Inutile chiedere alla Pescheria e nei ristoranti di pesce di Piazza
duomo o di Acitrezza; a restare legati a questa specialità sono alcuni
ristoratori lungo la Timpa ed a Stazzo (nei pressi di Acireale), e
giusto un paio di commercianti della zona di Ognina, a Catania.

"Ogni venerdì me lo porta un vecchietto - spiega Tino, titolare di
una rivendita di frutti di mare in piazza Mancini Battaglia - che lo
raccoglie insieme a suo figlio in una località vicino Acireale.
Trovarlo è così difficile che neanche lui vuole far sapere dove
riescono a prenderlo".
Un "segreto professionale" che, tuttavia, non turba la
serenità del rivenditore e dei suoi clienti: "Credo sia una
località poco inquinata - continua Tino - perché so che per crescere
ha bisogno di acque limpide". Magari, perciò, si chiude un occhio
su tracciabilità e sicurezza alimentare, ma volentieri si apre la bocca
per assaggiare una prelibatezza tipica che rischia l'oblìo: "La
domenica è già terminato - prosegue il commerciante - perché ho dei
clienti affezionati che vengono qua apposta".
Come ogni sciccheria marinara, di solito si consuma crudo:
"Cinquanta anni fa mia mamma se lo mangiava a mare mentre lo
raccoglieva - ricorda Tino - ma c'è chi lo preferisce condito con sale
e limone, o chi lo salta in padella".
Sono questi i mesi migliori in cui tentare la fortuna: l'alga trova il
suo habitat ideale da aprile a giugno. Una vaschetta da 100 grammi costa
più o meno tre euro. Ben 30 euro al chilo, ma vale per la memoria.
Francesca
Marchese - Giovedì 16 Aprile 2009

Estate, mare, ferie. Ma anche mangiate di pesce. E, a Catania, terra di
sushi autoctono da sempre, anche di frutti di mare crudi. Ricci, occhi
di bue, patelle, perfino il “mauro” l’alga che mangiavano i nostri nonni
con sale e limone. Tutta roba che si trova regolarmente sui banchi della
pescheria, ma a quale prezzo? Non parliamo di euro, ma di ecostenibilità.
Fino a quando possiamo pensare di mangiare occhi di bue (a 80 euro al kg
sui banchi del pesce) saccheggiando i fondali? Per quanto tempo siamo
disposti ad ipotecare il mare alle future generazioni per un piatto di
spaghetti con i ricci pescati in maniera massiccia e senza scrupoli?
«I ricci che noi mangiamo non sono le femmine,
come si crede comunemente - spiega Emanuele Mollica, biologo marino e
direttore dell’Area marina protetta Isole Ciclopi - è una specie
“colorata” che ha maschi e femmine e si chiama Paracentrosus Lividus
mentre quello che chiamiamo riccio “maschio” è un’altra specie non
commestibile, qualla nera con gli aculei più lunghi. I ricci sono
soggetti ad un “overfishing” cioè una pesca eccessiva e quindi le loro
dimensioni si riducono, il quantitativo è sempre minore e, inoltre,
raccogliendo solo una delle due specie, l’altra, che è competitrice,
finisce per avere campo libero e ce ne saranno sempre di più».
E gli occhi di bue?
«E’ una vera tragedia. Non sarebbero buoni da
mangiare, noi catanesi siamo gli unici al mondo che li consumiamo. La
pesca dell’occhio di bue è quasi esclusivamente clandestina e vietata
dalla legge perché fatta con le bombole abusivamente: Per catturare
questi animali vengono rivoltate le pietre sul fondale danneggiando la
specie. Ormai la dimensione delle conchiglie è sempre più ridotta.
Diventa adulta in tre anni e raggiunge i 5 cm ma potrebbe arrivare anche
a 7-8 cm, ma ormai questa misure ce le siamo dimenticate».
Non c’è una legge che obblighi a rispettare le misure?
«Esiste semplicemente una legge che vieta la
pesca subacquea con le bombole».
E se si pescano in apnea?
«Si fa comunque un danno ambientale enorme,
perché girando la pietra, tutto quello che ci vive sopra, e che è amante
della luce, finisce al buio e viceversa, quindi non si uccide solo il
mollusco ma anche la vegetazione».
C’è ancora l’uso della pietra celeste (il solfato di rame che si
gettava per far “uscire” il mollusco e i polpi dalle tane ndr)?
«Sì alcuni la utilizzano ancora, ma oggi la
stragrande maggioranza dei raccoglitori “gira” le pietre, è molto più
veloce. Tenete presente che per raccogliere circa un chilo di questi
molluschi bisogna rivoltare un’area di circa un ettaro di fondale. Forse
è arrivato il momento di evitare di comprarli. Ci sono tanti, troppi
pescatori abusivi, anzi bracconieri, chiamamoli con il loro nome.
Ciascuno ne prende circa un chilo al giorno, calcolate voi il danno
ambientale».
Ma non esiste una regola come per i raccoglitori di funghi, per esempio
un tesserino?
«Ripeto, è proprio vietata la pesca con
l’autorespiratore. Se venissero raccolti come si faceva vent’anni fa dai
pescatori, di notte con la lampara, che li tiravano su con il gancio
dalla superficie, allora sarebbe una pesca sostenibile».
E per i ricci che limiti ci sono?
«Gli appassionati che vanno con maschera e pinne
possono prenderne al massimo 100 al giorno».
Da dove viene la polpa di riccio che vendono nei supermercati?
«In genere dall’oceano, ci sono alcuni paesi che
hanno delle regolamentazioni, per esempio in Australia, dove la specie è
molto più grande, ci sono dei pescatori professionisti autorizzati che
possono prelevare delle quote prestabilite e in determinati punti. La
polpa di ricci che troviamo al supermercato non proviene dai nostri
mari».
Ma come si fa a sapere dove vengono raccolti, se sono sicuri da
mangiare?
«Io non vedo grossi rischi da questo punto di
vista nel consumo dei ricci. Certo, se c’è un’immissione inquinante da
terra è evidente che è più pericolosa nei primi metri dalla costa, anche
se poi c’è l’effetto diluizione... ».
Ma se un pescatore abusivo va a prendere ricci ad Aci Trezza vicino
allo scarico fognario, il consumatore come si difende?
«Se va a pescare ad Aci Trezza vicino alla fogna
infrange un triplice divieto: pescare nell’area protetta, violare
l’ordinanza sanitaria che vieta la balneazione vicino agli scarichi e
mettere in pericolo la salute di chi mangerà quei ricci».
Non mi pare che ci sia tutto questo rispetto per le regole. I ricci
che arrivano sulle nostre tavole chi li certifica?
«Nell’80 per centro dei casi è roba pescata
clandestinamente con metodi vietati. E’ vero che alla capitaneria di
porto di Catania sono registrati dei pescatori subacquei professionisti
che hanno una licenza speciale per raccogliere fino a mille ricci al
giorno con le bombole, ma la maggior parte del pescato è clandestino ed
è bene che si sappia. Lei pensa che una persona che non ha alcuno
scrupolo di andare a pescare clandestinamentesi ponga il problema di
andare a raccogliere ricci, per esempio, nella baia di Augusta dove c’è
un forte inquinamento? O accanto ad una fognatura? Che gliene frega...
».

Possibile che non si possano mettere dei freni a questa situazione?
«Guardi, le dico una cosa. C’è un pescatore
abusivo habitué ad Aci Trezza, che pesca occhi di bue con le bombole. E’
un pregiudicato, non dico il nome per la privacy, il quale ha accumulato
90mila euro di sanzioni amministrative che ovviamente, non paga perchè
risulta nullatenente e, quindi, non teme alcuna confisca, oltre a
tredici avvisi di reato per pesca abusiva. Ebbene, continua ad essere lì
tutti i giorni, perché gli occhi di bue glieli pagano 70 euro al kg».
Quindi mi sta dicendo che non si può fare nulla?
«Il metodo più efficace è quello di avvertire il
consumatore che delinque anche lui se consuma gli occhi di bue, un po’
come è stato già fatto, con una specifica campagna d’informazione, per
vietare il consumo di datteri di mare».
Sì, ma allora non si dovrebbero neppure vendere in pescheria e nei
ristoranti...
«Certo, purtroppo succede che, ai controlli della
capitaneria di porto il ristoratore di solito è in grado di dimostrare,
con fattura, l’acquisto ufficiale del mollusco e, questo, perché
probabilmente c’è qualche commerciante che si presta a fatturare questo
pescato che altrimenti non potrebbe essere fatturato perché non proviene
da una pesca autorizzata ufficialmente».
Quindi si tratta di fatture false?
«L’ha detto lei... ».
C’è chi va a pescare nell’area marina protetta?
«Rispetto ai primi anni il fenomeno è molto più
ridotto. Certo, c’è sempre quello che vede un bel sarago e pensa di
poterlo catturare ma c’è anche la videosorveglianza i controlli della
capitaneria di porto, del nostro personale, e poi ci sono anche gli
altri utenti che segnalano situazioni di questo tipo. Abbiamo qualche
problema in più la notte».
In pescheria vendono il “mauro” ai turisti, un piattino 4 euro...
«E’ pericolosissimo, è un’alga che appartiene al
genere Girartina, predilige le acqua poco salate e, infatti, vive dove
sfociano i fiumi sotterranei ad Ognina, a S. Giovanni li Cuti, al porto
di Catania. Va da sè che se il suo habitat naturale è in prossimità
degli scarichi inquinanti... ».
Il punto è che il catanese doc non si pone il problema, né di
impoverire il mare, né di prendere un’intossicazione. Di fronte allo
spaghetto con i ricci perde la coscienza ambientale semmai ce n’ha
una...
«Lo so, il nostro lavoro è quello di divulgare
queste informazioni. Chi ha una coscienza, magari evita di mangiare un
piatto di spaghetti con i ricci e opta per un buonissimo piatto di pasta
con le vongole o con le cozze che sono allevate e controllate. La prima
tutela dell’ambiente è a tavola. Vale la pena mangiare un piatto di
occhi di bue sapendo che per quel piatto si distrugge mezzo ettaro di
fondale marino?».
Carmen Greco - La Sicilia del 19.7.2015
 |

|
Adorate dai Greci e dai Romani, simbolo del Festino di Santa Rosalia a
Palermo, le lumache sono una delizia anche per il palato dei più
scettici.
Le chiocciole delle lumache ed in siciliano babbaluci, sono molto amate
in Sicilia e soprattutto nel Palermitano in cui vengono largamente
utilizzate durante il festino di Santa Rosalia.
I
babbaluci, sono un alimento molto diffuso, e vengono consumate durante l’estate
e l’autunno.
Hanno carni tenere, con pochi grassi e con un livello proteico affine a
quello del pesce.
A Palermo vengono associate al festino del 14 Luglio, e cioè alla festa
di Santa Rosalia, santa patrona della città, che liberò gli abitanti
dalla peste del 1624.
L’utilizzo delle lumache a tavola risale ad epoche remote e almeno sin
dai tempi dei Sicani, da come è documentato dai ritrovamenti a Sambuca
di Sicilia nella grotta di Isaredda.
In generale venivano e vengono consumate in tutta Italia: i Greci e i
Romani le adoravano e nel 49 a.C., come riporta Plinio il Giovane,
Fulvio Lippino trasportava le lumache, provenienti dalla Sicilia, dalla
Sardegna, dal Nord Africa, da Capri e dalla Spagna, a Roma tramite
traghetti, per soddisfare la propria clientela.

Sono tre i tipi di lumache terrestri consumate
in Sicilia:

Babbaluci, Helix (Theba) pisana,
a Catania VACCAREDDI,
che si caratterizzano per essere piccoli e bianchi; esiste anche una
varietà più grande, detta
RIGATA;
La specie più diffusa è l’Helix (Theba) pisana, i cui appartenenti
vengono chiamati Babbaluci, il cui nome deriva, presumibilmente dall’arabo
"babush", che indicava le scarpe da donna con la punta
 ricurva
verso l’alto. ricurva
verso l’alto.
Alcuni studiosi indicano invece la provenienza dal greco arcaico “boubalàkion”,
bufalo, a cui veniva paragonato il babbaluciu per via delle corna. Ziti
a vasàri e babbalùci a sucàri nun pònnu mai saziàri (Fidanzati da
baciare e lumache da mangiare non possono mai saziare) I babbaluci
vengono raccolti da cardi spinosi nelle campagne siciliane per mano dei
babbaluciari.
È molto interessante vedere ancora a Palermo alcuni fruttivendoli, e
soprattutto quelli dei grandi mercati, proporre e vendere questi
molluschi già pronti da mangiare.
In Sicilia è usanza mangiarli con le mani, ma la tecnica per tirarli
fuori dal guscio è davvero particolare: alcuni utilizzano gli
stuzzicadenti per infilzare e tirare fuori il mollusco, altri, i
siciliani doc, procurano alla conchiglia, con un dente canino, un buco
piccolo piccolo opposto all’apertura del nicchio testaceo, in modo da
creare un canale d’aria che farà uscire il babbaluciu, nel momento
della suzione.
Per cucinare l’Helix (Theba) pisana bisogna prima prepararla lavandola
ben bene: prendete un largo recipiente pieno d’acqua e strofinate,
senza farle rompere, le lumachine, in modo da togliere tutti i residui
del guscio e interni. Se è necessario, togliete con l’aiuto di uno
stuzzicadenti, la piccola membrana (operculum) presente in prossimità
dell’apertura. Cambiate l’acqua spessissimo e continuate fino a che
risulta pulita e limpida.
Dopo aver terminato questa prima parte del procedimento, prendete una
pentola grande e distribuite del sale grosso sul bordo, in modo che i
babbaluci non fuoriescano.
Lasciate riposare al sole per circa due ore, in modo tale che escano
fuori dal guscio, per via del calore. Appena pronte, cambiate un’ultima
volta l’acqua, se necessario, e ponete sul fuoco lento per qualche
minuto.
i Castruni, Helix vermiculata,
grossi e scuri, a Catania CRASTUNI.
Helix vermiculata, italiana vignaiola o martinaccio. Il colore è
bruno-verdastro. Per questo motivo vengono indicati anche con il nome di
“setti sordi” o “carrìnu”, rassomigliando ad una di quelle
monetine in rame che si ossidavano diventando verdastre quando si
perdevano in campagna. Ma pure barbàniu, muntuni…
gli Attuppateddi, Helix naticoides, che hanno
una membrana grossa e scura, a
Catania N'TUPPATEDDI;
Helix
naticoides, caratterizzati da una membrana mucoso-calcare di
colore bianco che chiude l’apertura del nicchio testaceo. Sono
comunissimi nelle terre argillose dopo le prime piogge autunnali
Si difendono dalla calura rifugiandosi a oltre un palmo di
profondità. Quando escono dal loro rifugio sono ricoperti di
fango per cui vengono detti “attupateddi nìuri”. A seconda
delle varie zone linguistiche isolane prendono nomi bizzarri
come izzu, scaùzzu o scavuzzi, scataddìzzu, munacheddi.
Se
vendute in estate, cioè quando sono in letargo sottoterra, con
l'intestino vuoto e ancora coperte dalla membrana bianca, il loro prezzo
varia dai 40 agli 80 auro al chilogrammo a seconda della
qualità, la zona e il volume. Dopo le prime piogge, le lumache
escono all'aperto e il loro prezzo scende vertiginosamente sia per la
facilità di raccolta, sia per il fango, l'alimentazione e la continua
defecazione durante il loro percoso.

La varietà "RIGATA"

LE
RICETTE
“Babbaluci
a picchi pacchiu”
Dopo
averle lavate ben bene si pongono in un tegame il cui bordo si ricopre
di sale umido facendo attenzione a non farlo cadere nell’acqua. Si
comincia con un fuoco bassissimo che permette di fare uscire le
malcapitate dal guscio. Appena saranno stordite si alza la fiamma, si
aggiunge il sale e si lasciano bollire per qualche minuto e quindi si
scolano. In tegame si fa soffriggere in olio d’oliva la cipolla
tritata, si aggiungono dei pomidori pelati a pezzetti, sale e pepe
quanto basta. A sugo ristretto si aggiunge il prezzemolo e le lumachine.
Bastano pochi minuti per insaporire.
“Babbaluci
del Festino”
Dopo
la cottura come sopra indicato, si provvederà a preparare la salsa. In
tegame si farà soffriggere l’aglio, rosso o rosa, in olio d’oliva,
sale quanto basta, ma pepe nero abbondante. Aggiungere le lumachine e il
prezzemolo. Anche in questo caso bastano pochi minuti per insaporire.
“Crastuni
fritti”
Dopo
la cottura, con l’aiuto di uno stuzzicadenti, si estrarranno dal
guscio. A questo punto basterà togliere il filettino nero e passarle
una ad una prima nella farina poi nell’uovo battuto e quindi nel
pangrattato. Vanno fatte dorare nell’olio d’oliva bollente
ponendocele poche per volta. Si servono ben calde.
“Crastuni
del Monsù”
Variante
elegante, baronale, della ricetta precedente. Tolte dal guscio si fanno
saltare in padella con burro e aglio. Si aggiunge il prezzemolo al
momento di servire.
“Attupateddi
ccu sucu russu”
Dopo
la cottura identica a quella di babbaluci e crastuni, si provvederà
alla salsa rossa. In tegame si soffrigge la cipolla in olio d’oliva;
quindi si aggiungeranno, poco alla volta delle nocciole di estratto di
pomodoro ben concentrato, fino alla consistenza desiderata. Aggiungere
sale e (molto) pepe e servire ben caldo.
“Attuppateddi
o crastuni arrustuti”
E’
piatto tipico della Sicilia orientale. Le lumache si mettono su una
griglia con brace viva per cinque/sei minuti. Sistemate in una zuppiera
vanno condite con un ottimo olio d’oliva extra vergine, sale e pepe.
Mescolare bene con cucchiaio di legno prima di servire.
A
TAVOLA
Mangiare
“comme il faut” le lumache è segno di riconoscimento: debbono
succhiarsi direttamente dal guscio dopo che con i canini si è creato
quel forellino che ne permette la fuoruscita. Insomma, sicilianità
vuole che a ciascuna di loro sia riservato un bacio post mortem. E’
chiaro che è previsto soltanto l’uso delle dita, della bocca e una
notevole forza aspirante. Soltanto alle giovinette di buona famiglia fu
consentito l’uso di un uncino (d’argento, naturalmente…) per
evitare quel poco elegante risucchio.
“Cui
vivi acqua ccu li babbalùci, sunàti li campani pirchì è mortu”:
mai acqua, dunque, ma un bicchiere di buon vino. Da un bianco d’Alcamo
a un nero d’Avola: dipenderà dalla salsa.

COME
PREPARARLE PER LA COTTURA
si divide in tre fasi: la
purgatura, l'eliminazione della bava, la precottura con estrazione dal
guscio.
Purgatura
La lumaca raccolta in campagna in primavera od estate deve essere
"purgata" per eliminare residui di erbe o funghi velenosi o
con cattivo sapore che abbiano mangiato. Le lumache che si sono chiuse
con il loro opercolo allo inizio dell'inverno o d'estate sono già
purgate. Il metodo tradizionale di purgatura consiste nel far digiunare
le lumache per 5 o 6 giorni dentro della gabbie di legno oppure di
plastica, purché abbiano un fondo ben aerato su cui non si formi
umidità perché lo scopo della purgatura è quella di farle asciugare e
far sì che si attacchino alle superfici del contenitore.
In molte zone si usa mettere inizialmente le lumache nella crusca o
mollica di pane affinché ne mangino per due giorni, ma non pare che
l'uso abbia una particolare utilità. Ancor meno senso ha il mettere
segatura al posto della crusca!

Secondo un esperto francese tutto questo sistema è inutilmente
complicato, specialmente per lumache di allevamento che non hanno
mangiato erbe amare, ed egli procede diversamente. Mette le lumache in
una cassa di legno privo di tannino e con il fondo a griglia e sollevato
dal suolo di una quindicina di centimetri almeno. Poi le lava con un
forte getto d'acqua togliendo ogni residuo di terra od altro; ripete poi
l'operazione per due volte lasciano passare 24 ore tra una operazione e
l'altra. Passati così tre giorni le lascia asciugare per altri tre
giorni.
Eliminazione della bava e prima cottura
1) Purgate le lumache, si mette in un largo recipiente uno strato di
lumache e poi un pugno di sale grosso e così via con altri due o tre
strati. Le lumache emettono molta bava e dopo alcune rimescolate si
lavano più volte.
2) In alcune zone, prima di bollirle, vengono messe per un'ora in acqua
sale ed aceto (o solo acqua con il 20% di aceto) e poi ripetutamente
sciacquate e, se ancora bavose, sfregate con farina di mais grossa. Dopo
di che vengono buttate nell'acqua bollente e si fanno bollire per
dieci-quindici minuti. Si scolano, si tolgono dal guscio e si elimina la
parte nera.
3) In molte zone, sia con l'intento di uccidere rapidamente le lumache,
sia di eliminare eventuali lumache morte, si procede diversamente: le
lumache vengono messe sul fuoco in poca acqua fredda; quando l'acqua si
scalda le lumache escono dal guscio. Se in quel momento di versa sopra
di esse abbondante acqua bollente, esse muoiono subito e si possono
eliminare quelle che non sono uscite da guscio.

Questo è il metodo
preferibile. Altri, per individuare le lumache morte, le punzecchiano
con uno stuzzicadenti prima di metterle nell'acqua.
Il sistema di preparazione preferibile e più semplice è di lasciar
purgare le lumache 4 o 5 giorni, lavarle bene, accertarsi che siano vive,
metterle in uma pentola e buttare loro soprea acqua bollente per
ucciderle e farle bollire per una decina di minuti. Dopo di ciò
estrarre la lumaca dal guscio, togliere l'intestino tenendo solo la
parte carnosa anteriore e procedere alla sbavatura.
Anche
i sistemi per togliere la bava sono svariati. La parte carnosa
raffreddata viene messa in acqua fredda in cui si sia sciolto del sale
fino a saturazione (fino a quando non si scioglie più) e vi si lasciano
per un quarto d'ora. Oppuro si possono anche impastare e sfregare con del
sale grosso e farina di mais. Si sciacquano poi abbondantemente, dopo di
che sono pronte per essere cucinate o congelate (la lumaca si presta
molto bene al congelamento).
Se si vogliono conservare i gusci per una successiva utilizzazione, si
svuotano accuratamente, si lavano bene con un pizzico di soda Solvay (ma
alcuni si accontentano del bicarbonato) e si sterilizzano in acqua
bollente (se si utilizzano subito, basta la bollitura). Poi si fanno
asciugare nel forno a bassa temperatura.
La lumaca è così pronta per la cottura successiva. I tempi di cottura
finali variano a seconda della taglia della lumaca e di altre
circostanze; in genere occorrono da una a due ore. Per le lumache in
scatola basta un quarto d'ora. Attenzione: in alcune zone, specialmente
se si tratta di lumache di piccola taglia, le lumache vengono cotte
direttamente nel loro guscio, con l'intestino.
In molte ricette le lumache vengono utilizzate già cotte a puntino; per
ottenerle si procede nella seguente maniera: cuocere le lumache (che
già hanno subito la prima cottura e sono state pulite) in una parte di
vino bianco e una parte d'acqua, in quantità tale da ricoprirle
completamente; aggiungere carote, cipolla, scalogno tritato e un
mazzetto guarnito. Condire con 8 g di sale per ogni litro di brodo e
cuocere a fuoco lento fino a che sono tenere.
http://lamiacucinacasalinga.forumcommunity.net/?t=22962542

Crastuni alla Pescheria di Catania

ELICICOLTURA
L'elicicoltura,
branca della zootecnia,
è l'allevamento
della chiocciola
a scopo alimentare. Ha come obiettivo produrre quantità elevate di
questi molluschi per poi venderli alle aziende ristorative interessate.
La pratica ha visto la luce a partire dal 1970 in alcune regioni del
nord Italia (Piemonte, Veneto ect.), per poi diffondersi nel resto della
penisola e successivamente in tutta Europa.
Attualmente
essa è diventata una realtà agricola riconosciuta dagli enti pubblici
e istituzionali, molti dei quali hanno leggi per atto a suo favore,
creando interessanti incentivi economici per la diffusione di tale
produzione.
sistema
di allevamento all'aperto[modifica] esempio di recinto di pascolo
allevamento all'apertoIl sistema di allevamento a ciclo biologico
completo, pur essendo di più complessa realizzazione,risulta essere il
più diffuso: esso rappresenta nel panorama nazionale, la percentuale
del 97% degli impianti di elicicoltura. L’elicicoltura si attua
esclusivamente su libero terreno e all’aperto, senza coperture o l’uso
di protezione, in quanto l’attività diventa produttiva ed economica
solamente se impostata con costi ponderatamente limitati e controllati.
Questo metodo consiste nell’introdurre, in apposite recinzioni,
chiocciole fattrici destinate ad accoppiarsi e a moltiplicarsi. La
vendita del prodotto è costituita quindi non già dalle chiocciole
immesse, come succede con il sistema incompleto e sotto serra, ma da
quelle che nascono dalle chiocciole fattrici e si sviluppano nel periodo
di ingrasso.
Il
sistema prevede una recinzione perimetrale esterna, atta a contenere
l'intero impianto e ad evitare incursioni da parte di predatori
dall'esterno. Lo spazio così creato verrà suddiviso in settori più
piccoli e maggiormente agevoli per la manualità. I recinti così
costruiti con una speciale rete anti-fuga e anti-bava, sostenuta da pali
in legno o in PVC, saranno seminati all'interno con l'alimentazione che
nutrirà le chiocciole. I semi consigliati per una sufficiente e
adeguata nutrizione, ingrasso veloce e protezione per mezzo delle foglie
laminari e molto sviluppate contro i raggi solari sono:
1)
Ravizzone Ungherese (Cavolo Cavaliere) 2)
Bietola da coste 3)
Radicchio Spadone (Cichorium intybus) 4)
Trifoglio Nano (Trifolium Repens) 5)
Girasole (Helianthus annuus)
Ogni
recinto ha le dimensioni standard di 45 metri x 4 metri; queste misure
però sono suscettibili di modifiche e variazioni, a seconda delle
dimensioni del terreno a disposizione dell'allevatore. I diversi recinti
costruiti sull'appezzamento totale di terreno destinato
all'elicicoltura, sono divisi in 2 categorie differenti: recinti
destinati alla riproduzione e recinti destinati all'ingrasso dei nuovi
nati in rapporto di 4 a 6. Ogni recinto è separato dagli altri da una
zona di passaggio per l'operatore, larga 1 metro.
La
scelta dell’allevamento all’aperto, sul terreno, è stata
determinante nell’impostazione e nello sviluppo di questa attività, e
si è notevolmente differenziata dall’impostazione dell’elicicoltura
negli altri paesi europei come la Francia e la Spagna. Fin dai primi
esperimenti, gli italiani hanno considerato improponibile un allevamento
di chiocciole in condizioni che non fossero quelle naturali proprie del
mollusco, abituato da sempre ad un habitat rurale e in piena armonia con
la natura. Ciò anche in relazione alla assoluta semplicità dell’anatomia
e fisiologia del mollusco ed alla lentezza del ciclo di vita.
In
pratica lo scopo del sistema all'aperto è quello di seguire la natura
ma con controllo da parte dell'uomo, per creare un prodotto biologico di
alto livello e di alte resa.
Il
sistema di allevamento al chiuso[modifica] esempio di recinto in serra
destinato all'elicicolturaIl tipo di allevamento in serra è tipico di
paesi europei quali la Francia e la Spagna. La chiocciola, mantenuta ed
allevata in condizioni artificiali (in serra, contenitori od ambienti al
chiuso) si accoppia, depone le uova e può anche diventare adulta, ma
necessita di un continuo lavoro per la pulizia, per l'apporto di
alimenti dall'esterno e per la continua irrigazione artificiale. Al
coperto è meno soggetta alla prelazione da parte di insetti, roditori,
volatili. Quindi da tutti gli animali predatori delle chiocciole che
possono causare seri danni alla vita regolata dell'allevamento. I
problemi però che l'allevamento in serra può presentare sono di
diversa natura. Tra i principali troviamo: l'eccessiva assimilazione di
anidride carbonica e la mancata possibilità di beneficiare della
naturale umidità, derivante dalla deposizione della rugiada, condizione
ideale per la vita delle chiocciole, inoltre il prodotto che cresce al
coperto, senza la luce del sole, ha carne con bassa consistenza che alla
cottura perde una alta percentuale di peso.

OLTRE
LE ALPI, OVVERO, LE ESCARGOT
E'
il nome comune dei Gasteropodi dei generi Arion (famiglia degli Arionidi)
e Limax (famiglia dei Limacidi), detti anche limacce o lumaconi. Hanno
corpo cilindrico dotato di conchiglia rudimentale, sul capo si trovano
quattro tentacoli retrattili e la parte strisciante (detta radula) con
numerosi dentelli.
Vivono nei luoghi umidi e freschi. Sono dannosi alle coltivazioni per la
voracità con cui divorano foglie e germogli. E fin qui, credo che tutti
saremo d'accordo. I loro peggiori nemici sono i ricci o porcospini: ne
vanno pazzi!
Ci
sono diverse specie "commerciali" di lumache:
- la lumaca Agatina che proviene originariamente dall'Africa Orientale
ed è diffusissima in Asia dove è anche largamente allevata.
- la lumaca della Borgogna è originaria del centro Europa che ha un
guscio di 3-4 cm di diametro. Questo tipo si trova anche precotto e
surgelato in barattolo. E' sempre più rara e costosa.
- la lumaca detta Petit Gris, di stazza più piccola originaria
dell'Europa meridionale, ha un guscio di circa 2-3cm con diverse
varietà, alcune delle quali sono diffuse anche in Medio Oriente.
E'
ovvio che qui tenteremo di visitare particolarmente l'aspetto
gastronomico delle lumache, con qualche notizia sull'origine della loro
apprezzata versione culinaria.
Il fondatore della raffinata cucina francese che nel XIX secolo portò
in tavola le lumache fu Antoine Careme; fu lui a proporre le lumache
alla borgognona, escargots à la bourguignonne, con burro, aglio e
prezzemolo facendo salire questo piatto alle più alte vette della
gastronomia.
Questi
molluschi così a misura di... bocca, furono subito molto apprezzati
tanto da richiedere addirittura l'invenzione di speciali piattini con
pinzette annesse per poterne afferrare il guscio bollente mentre con
un'apposita forchettina a due denti si estraeva la parte commestibile.
Pochi forse, dinnanzi ad un piatto tanto prelibato, sanno quanto lavoro
preliminare richieda e quanti laboriosi procedimenti vi siano alle
spalle di quel bocconcino cartilaginoso.
Si
comincia con un digiuno forzato cui vengono sottoposte le povere lumache
per almeno dieci giorni. In alcune regioni della Francia, durante questo
periodo, il digiuno viene reso meno drastico somministrando loro del
timo.
Questa procedura non è casuale: le lumache si cibano di vegetali alcuni
dei quali sono velenosi o tossici per l'uomo. In questo modo, si
depurano evitando pericoli e malesseri. Successivamente, le lumache per
ragioni igieniche vengono lavate per tre volte.
La prima volta si effettua un lavaggio a getto della superficie del
guscio; il secondo lavaggio, viene effettuato con acqua e sale. Segue un
bel bagno in acqua limpida e fresca. A questo punto, le lumache vengono
sbollentate, raffreddate, estratte dal loro guscio e solitamente si
procede alla loro cottura in un brodo ben insaporito di aromi e
speziato.
Una
volta scolate e lasciate raffreddare, vengono reinserite nei loro gusci
ben sterilizzati dalla bollitura per essere servite ricoperte di burro
particolare (appunto burro per lumache) oppure di burro erborinato.
In alternativa potranno essere cotte in umido, con una sorta di
intingolo, o sughetto, o zimin, o rosolandole in burro, poca cipolla,
aglio e prezzemolo e, quasi alla fine di cottura, irrorandole con del
buon vino bianco secco. Oppure, come usano nella zona del Cuneese,
bagnandole con del buon Barbera. La cottura andrà fatta lenta e per
almeno un'ora.
I
nostri antenati pare apprezzassero questi gasteropodi, visto che nei
rifiuti di vecchi insediamenti preistorici si sono ritrovati mucchi di
questi gusci coi quali erano state fatte graziose collane; alcuni invece
erano utilizzati per decorare degli oggetti ornamentali. I Greci si
limitarono a studiarli, mentre i Romani buongustai ne studiarono
l'allevamento.
Le
lumache venivano grigliate dai Romani direttamente col loro guscio
gettandovi sale per far uscire la bava; pratica in uso ancora oggi dai
Catalani e dai Provenzali. Stranamente i ceti più elevati della
Francia, lasciavano les escargots ai meno abbienti e se ne cibavano
soltanto nei periodi del digiuno quaresimale. Oggi si sa che i Francesi
hanno un vero e proprio debole per le lumache tanto che la pregiata
qualità di Borgogna - che ha un guscio che raggiunge i 5 centimetri -
ormai è pressoché introvabile.
Gli
allevamenti, per far fronte alla grande richiesta e al consumo di questi
molluschi, non guardano troppo per il sottile. Si accontentano delle
Petits Gris che sono più piccole, col corpo grigio e il guscio
picchiettato di bianco e di giallo. Questi grandi allevamenti si trovano
nell'Est Europeo che esporta grandi quantità di lumache, oppure in
Turchia dove si allevano lumache dalla carne scura e dal guscio che
presenta un vistoso contorno nero. In Cina, si alleva il gigante della
qualità delle Agatine che raggiunge il peso di ben 250 grammi! La loro
esportazione rappresenta una voce notevole nell'economia cinese.
L'allevamento, chiamato elicicolo, generalmente viene fatto in casse di
legno all'aria aperta, dove il mollusco cresce per almeno un anno
nutrendosi di insalate ed erbe aromatiche controllate rigorosamente. I
recinti sono le strutture più importanti in quanto devono impedire
innanzitutto la fuga delle lumache, debbono proteggere l'allevamento da
eventuali predatori e anche permettere una separazione tra i vari stadi
del ciclo di crescita. E' molto importante anche una buona aerazione di
tutta la zona di allevamento. Ogni cassa inoltre, è dotata di tubicini
forati per l'acqua che distribuiscono la giusta dose di umidità al loro
ambiente artificiale, tenendo conto anche del grado di crescita.
La
carne delle lumache è ricca di sali minerali, ma è terribilmente
difficile da digerire e si dovrebbe consumare con moderazione. In
Italia, particolarmente pregiate sono le lumache piemontesi della zona
di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) e delle vallate adiacenti. Il tipo
appartiene ad una sottospecie chiamata chiocciola alpina, che è nota
come Helix pomatia e riesce a sopravvivere a oltre 2000 metri di
altitudine. Questa lumaca è alquanto grande e riesce a raggiungere il
peso di 50-70 grammi.
Questa
è la ricetta per ottenere un buon Beurre d'escargot (burro per lumache)
alla maniera francese.
1 scalogno 2 spicchi d'aglio 1 ciuffo di prezzemolo tritato finissimo
125 gr di burro sale e pepe nero
Lo scalogno va pelato e quindi tritato con l'aglio. Si unisce il
prezzemolo e si impasta col sale e col pepe. Il tutto, va unito al burro
morbido. Se ne deve ricavare una crema.
Questo burro così preparato, viene spalmato sull'apertura delle lumache
(già pulite e spurgate) che verranno sistemate su di una teglia in
forno caldo fin quando il burro si scioglie. Attenzione che il burro non
dove dorarsi. Una volta sfornate, le lumache vanno consumate subito.
http://www.cooker.net/doc/232DAF633E72F0ABC12575BA00292C33

Vaccareddi alla Pescheria di Catania
 Prodotta
con metodi tradizionali ed utensili storici, dopo la produzione, rimane nella
fiscella per circa 24 ore, in modo da permettere il necessario drenaggio del
siero e, nello stesso tempo, di farle assumere la giusta consistenza. Prodotta
con metodi tradizionali ed utensili storici, dopo la produzione, rimane nella
fiscella per circa 24 ore, in modo da permettere il necessario drenaggio del
siero e, nello stesso tempo, di farle assumere la giusta consistenza.
Resta
per 48 ore fuori dalla fiscella, per consentire un ulteriore asciugatura.
La
salatura viene effettuata tenendo ogni forma in mano e cospargendo accuratamente
tutta la superficie di sale; completata tale operazione, si procede, sempre in
maniera manuale, all’eliminazione del sale in eccesso.
Per
la salatura di ogni forma, occorrono circa 40/50 g di sale.
La
stagionatura avviene su scaffali di legno in ambienti ben areati; durante tale
fase, ogni 2/3 giorni le forme vengono capovolte e sottoposte ad un’attenta
pulizia della superficie esterna, al fine di eliminare sia le muffe, sia il sale
residuo.
La
ricotta Salata entra a far parte di diritto tra gli ingredienti piu’
importanti della cucina Siciliana, utilizzata soprattutto nel periodo estivo, la
troviamo nelle ricette di alcuni piatti simbolo della cucina tipica Isolana.
http://andreagraziano.com/2009/04/22/la-ricotta-salata/
La
ricotta salata, è ottenuta in seguito a salatura a secco e stagionatura per
circa due mesi. Deliziosa e gustosissima se grattugiata sui maccheroni o altre
pietanze.
Tipologia
latticino caseoso fresco, prodotto dal siero del latte di pecora, di capra e di
vacca (o misto).
Origine
del Nome
il termine "ricotta" conduce alla specifica tecnica di produzione, che
consiste nel ricuocere il siero di latte con aggiunta di altro latte fresco e di
sale: la ricotta si ottiene per affioramento.
Caratteristiche
del prodotto
La forma, generalmente tronco - conica, dipende da quella della fiscella dove
è posta la ricotta; la consistenza è morbida e cremosa, il colore è bianco. - Al naso risalta l'odore delicato del siero di latte.
- Al gusto è dolce e soave.
Storia.
La ricotta salata è un prodotto di antica tradizione, conosciuta notoriamente
come indispensabile ingrediente di alcune rinomate pietanze siciliane.
Tecniche e ambienti di produzione. Prodotta con metodi tradizionali e utensili storici; dopo la produzione rimane
nella fiscella per circa 24 ore in modo da permettere il drenaggio del siero e,
nello stesso tempo, assumere la giusta consistenza. Resta per 48 ore fuori dalla
fiscella per consentire un’ulteriore asciugatura. La salatura viene effettuata
a mano cospargendo accuratamente tutta la superficie di sale; completata tale
operazione si procede all’eliminazione del sale superfluo. La stagionatura
avviene su scaffali di legno in ambienti ben aerati.
Caratteristiche. Prodotto cremoso, compatto, di colore giallo-paglierino. Peso. Circa 1 Kg. Gusto. Sapore forte, gusto marcato, odore di grasso.
Origine. Tutto il territorio siciliano.
http://www.terramadre.it/

di Mimmo Gargano
Fino agli anni settanta del secolo scorso la versione estiva
del paese di Bagheria -non ancora città- era caratterizzata dalla presenza
diffusa nelle piazze, negli slarghi, ma anche nelle vie della parte più antica
del paese, di distese di tavole rettangolari di legno,
su cui faceva bella mostra il succo di pomodoro steso ad asciugare al sole: era
il periodo in cui si faceva "‘astrattu "
Fino a quegli anni i pomodori erano un frutto tipicamente estivo che comparivano
sul mercato ai primi di luglio per sparire a settembre/ottobre; nulla a che
vedere con quanto avviene oggi quando i pomodori freschi sono presenti
ininterrottamente sul mercato e quindi ad esempio la "salsa" fresca si può avere
tutto l'anno
"'Astrattu", il succo di pomodoro asciugato al sole fino a ridurlo a circa un
decimo del suo volume iniziale e salato in maniera robusta per consentirne la
durata, assieme alla passata "‘a salsa" conservata in bottiglia, costituiva uno
dei modi per utilizzare questo frutto così importante nella cucina meridionale
anche nei mesi invernali.
"Fari astrattu" era una attività fondamentale per molti bagheresi dei ceti
popolari, attività complessa e faticosa che coinvolgeva intere famiglie almeno
per un paio di giorni.
Bisognava intanto rifornirsi dei pomodori, andando a comprarli al mercato " u
scaru", (che negli anni '50 si trovava nell'ordierna piazza Vittime della Mafia
a Palagonìa), dove si spuntava un prezzo più conveniente, oppure comprandoli
direttamente dal contadino produttore; in genere questi era persona conosciuta,
vicino di casa o comunque uno del quartiere, e ciò appariva una rassicurazione
relativamente alla qualità del prodotto.
Allora i pomodori in commercio erano quasi completamente di una sola varietà: la
cosiddetta nostrale (corrispondente al "genovese a coste" adattato da molti anni
alle condizioni locali) caratterizzati da buccia sottile poca fibra e buona resa
in succo; i più ricercati erano quelli di pezzatura più piccola, "sansieri"-
cioè esenti da alterazioni visibili-, e specialmente che fossero "ru siccagnu"
coltivati cioè in zone non irrigate perchè questo si traduceva in un minore
contenuto in acqua di vegetazione quindi in una maggiore velocità di asciugatura
del succo e in una resa maggiore; particolarmente ricercato il pomodoro dell'Accia.
L'attrezzatura per fare l'estratto era abbastanza semplice: il passapomodoro, un
vaglio molto sottile fatto con crini di cavallo -‘u crivu ri pilu", le tavole su
cui stendere il succo ad asciugare -"‘i maiddi" e veniva spesso presa in
affitto; servivano anche una o più spatole "‘a rasca "con cui raschiare dalle
tavole il succo man mano che andava asciugandosi.
(Esistevano delle leggere varianti locali nella tipologia delle "maidde"; a
Bagheria erano delle tavole rettangolari di 80cm x 200 cm. lisce senza bordo; a
Casteldaccia invece le stesse tavole erano dotate di un bordo rilevato di circa
3 cm che impediva che il succo appena versato, quindi molto fluido, scolasse dai
bordi).
Il "passapomodoro" era costruito anch'esso in legno ed era costituito da una
cassa capace di circa cento litri di succo, poggiante su piedi, chiusa in alto
da una lamiera di zinco traforata inserita in un bordo di legno; su questa si
versava una intera cassetta di pomodori che venivano spremuti a fondo fino a che
restava solo "‘a spùagghia" (un misto di bucce, semi e scheletro fibroso dei
pomodori che era talora utilizzata come mangime per gli animali); il succo
veniva ricuperato tramite un foro posto nella parte bassa di uno dei lati.
La sera precedente i pomodori venivano "spiricuddati" -si toglieva il picciolo-
lavati e lasciati ad asciugare; si passava quindi alla spremitura, attività
faticosa in cui valeva molto la forza fisica; perciò questa fase era spesso
affidata ad un uomo di casa che spremeva le 4-5 cassette di pomodori nelle prime
ore del mattino prima di recarsi al proprio lavoro.
Il succo ottenuto dalla spremitura, setacciato attraverso "u crivu ri pilu", per
togliere completamente le fibre ed ottenere un prodotto finale più fine, veniva
steso in strato sottile sulle tavole posizionate in modo da godere della
maggiore insolazione, mano a mano che queste andavano scaldandosi; nei luoghi
ove l'esposizione era migliore, ad esempio nelle piazze, non era necessario
spostarle per inseguire il corso del sole, ed era un buon risparmio di fatica!
Una volta che il succo era tutto steso sulle tavole veniva salato con circa 100
g di sale per ogni chilo di pomodori e veniva mescolato - "arriminatu"-
frequentemente con le mani al fine di ottenere una asciugatura uniforme ed
evitare che si attaccasse alle tavole; via via che si andava asciugando veniva
concentrato in un numero sempre minore di tavole.
Questa fase della lavorazione era appannaggio delle donne ed era fonte di
discussioni infinite: quale fosse la migliore esposizione da dare alle tavole,
la scelta del momento migliore per raccogliere il succo dalle "maidde" dove la
asciugatura era più avanzata, le attenzione da porre in atto per evitare che
anche una piccola parte del succo andasse perso, per colatura dalle tavole o per
imperizia di chi operava nel raccoglierlo da una "maidda" e trasferirlo ad
un'altra.
Durante la asciugatura una importante attività collaterale era quella di bagnare
il terreno attorno alle "maidde" (va ricordato che allora a Bagheria molte
piazze e vie non erano asfaltate) per evitare che il traffico dei veicoli, non
intensissimo allora ma pur presente, alzasse polvere che si sarebbe
inevitabilmente depositata sull' "astrattu".
Quando le condizioni del tempo non erano del tutto rassicuranti - soleggiamento
intenso accompagnato da ventilazione leggera era l'ideale - era tutto un
invocare / scongiurare la divinità perché il tempo si mantenesse buono e
consentisse di portare a buon fine l'impresa; succedeva talora che invocazioni e
scongiuri non sortissero l'effetto voluto, il tempo si guastava e per evitare "
r'appizzàricci u sceccu cu tutti i carrubi", cioè per limitare il danno, si era
costretti a ritirare il succo steso e/o da stendere che a questo punto doveva
essere concentrato con la cottura e ovviamente il risultato non era lo stesso.
Quando tutto era andato bene a fine giornata si aveva la soddisfazione, che
remunerava ampiamente la fatica, di avere ottenuto alcuni chili, (in genere si
considerava buona una resa in cui i pomodori "ittavano" circa un decimo del peso
iniziale), di "'astrattu", con le caratteristica di una pasta semisolida, di un
bel colore rosso mattone, dal profumo intenso e dall'altrettanto intenso sapore
("ch'è dduci! " era l'inevitabile commento) che raccolto su uno "scanaturi"
-spianatoia- piccola tavola quadrata di circa 80 cm di lato-, sarebbe rimasto
per qualche giorno esposto all'aria, però al fresco.
Il ruolo dei bambini si limitava al tempo ad "arruciari 'ntierra" e nel leccare
l'astrattu recuperato dalle scanalature delle "maidde"
Alla fine della lavorazione "'astrattu" veniva conservato in recipienti smaltati
con apertura relativamente stretta, coperti da un foglio di carta oleata.
Piccola digressione di costume: nel gergo locale esisteva (non saprei dire se è
ancora in uso) la definizione di "astrattari" che definiva le persone -in genere
intere famiglie- che facevano "'astrattu" per venderlo; trattandosi di attività
che costringeva a stare per la strada, esponeva agli sguardi, non sempre
innocenti, ed ai commenti dei passanti con cui spesso si istaurava, diciamo
così, una certa dialettica.
Per questo motivo la definizione di "'astrattara" veniva talora rivolta, come
epiteto, a donne il cui comportamento non era esente da una qual volgarità, di
modi e/o di linguaggio. Ovviamente chi faceva "'astrattu" per sè non rientrava
in questa categoria; infatti sempre a Bagheria si dice "cu strigghia ‘u so
cavaddu un si chiama ‘arzuni" (garzone).
Per tutto l'autunno e l'inverno successivi si aveva così la materia prima per
preparare "u sucu" ingrediente mito della cucina locale, che oltre ad indubbi
pregi aveva -ha- l'altrettanto indubbia caratteristica di prevaricare sulle
sfumature di sapore dei cibi che in esso si cucinano.
(A tale proposito: un amico cacciatore mi confidò una volta di avere smesso di
offrire all'anziano padre qualche pernice, qualche beccaccia, qualche quaglia
frutti delle sue cacce più fortunate, perché alla domanda su come le avesse
cucinate, invariabilmente quello rispondeva "cu sucu"; soccorre al riguardo- "si
parva licet componere magnis"- la descrizione gattopardiana degli effetti del
vento che mescolava tutti gli odori in un quid indistinto, omogeneizzando odore
di principe, odore di cani, odore di Tumeo ecc. che pare anche, a chi scrive,
un'ottima metafora di un aspetto importante della sicilianità).
P.S. Il sugo ottenuto con piccole dosi di estratto ricostituito con acqua su
abbondante soffritto di cipolle si utilizza(va) per cuocervi i piatti a base di
carne di maiale (la prima volta a metà settembre per la Festa della Madonna
della Milicia, che costituiva l'ouverture per il consumo di tale carne)
bruciuluni, salsiccia, "cutini"; si otteneva così "u sucu ‘ ngrasciatu" cioè con
una ricca componente di grasso; oppure, altro uso tipico, le ultime melanzane
della stagione, piccole perché le piante ormai esauste, non riuscivano a
portarle a piena maturazione, previamente farcite con pezzetti di pecorino,
aglio, menta, sale e pepe- e rosolate in olio: le cosiddette "mulincianieddi
ammuttunati".
Avvertenza per le moderne e salutiste cuoche: nessuno dei piatti citati,
peraltro estremamente gustosi, è propriamente dietetico.
http://www.bagherianews.com/attualita/5985-u-tempu-rastrattu-di-mimmo-gargano.html


Un pesce versatile, da riscoprire
Condimento per un primo piatto, secondo gustoso o persino base per un
coraggioso dolce con crema e bucce di limone: il merluzzo essiccato
grazie alla sua versatilità vive una stagione d'oro e i prezzi salgono.
«Contiene solo i grassi utili, gli Omega 3»
Un pesce versatile, da riscoprire. "Piscistoccu e baccalaru", come
vengono chiamati in dialetto lo stocco e il baccalà, stanno vivendo un
periodo di rivalutazione gastronomica, se è
 vero
che anche i grandi chef ne fanno un uso sempre maggiore nelle loro
cucine. «È un pesce dalle grandi potenzialità e dal sapore duttile; si
ingentilisce facilmente e si possono creare delle ricette fresche e
veloci dal momento che contrariamente a quello che si pensa il baccalà
ha un tempo di cottura molto breve, quello necessario per cuocere la
pasta» afferma Maria Elena Curzio, presidente dell'associazione
nazionale Cuoche a domicilio. vero
che anche i grandi chef ne fanno un uso sempre maggiore nelle loro
cucine. «È un pesce dalle grandi potenzialità e dal sapore duttile; si
ingentilisce facilmente e si possono creare delle ricette fresche e
veloci dal momento che contrariamente a quello che si pensa il baccalà
ha un tempo di cottura molto breve, quello necessario per cuocere la
pasta» afferma Maria Elena Curzio, presidente dell'associazione
nazionale Cuoche a domicilio.
Già, proprio così il tempo di cuocere la pasta perché col baccalà «si
possono creare primi, secondi e persino dolci» precisa la cuoca, che in
pochi minuti svela la ricetta di un primo piatto gustosissimo: "Spaccatelle
con carciofi e baccalà". «È una ricetta veloce ed economica, basti
pensare che con un carciofo e 150 gr di baccalà possono mangiare quattro
persone. Durante il tempo di cottura della pasta si fa soffriggere il
carciofo tagliato a fettine molto sottili e si crea una salsa con olive
e capperi (qualche fettina di carciofo si impana con la farina di semola
si frigge e si tiene da parte per la decorazione finale); il baccala si
unisce al condimento: si spezzetta con le mani e si mescola al sugo,
magari aggiungendo un po' di menta, e si versa la pasta a fuoco spento.
Infine, si aggiungono i carciofi fritti per decorare il piatto ed ecco
pronto un primo gustoso e nutriente. Proprio per la sua versatilità
viene sempre più richiesto durante i banchetti».
Un pesce che piace sempre di più. Che prima era rilegato anche ad una
certa fascia d'età e definito il pesce "dei poveri" ma che adesso attira
anche i più giovani, se è vero che nella bottega del signor Michele
Longo, alla Pescheria, la confusione è tale «da non far sentire nemmeno
la crisi». Nella sua casa di "Stocco e Baccalà norvegese" Michele, 64
anni, racconta di essere figlio d'arte. «La professione è stata
tramandata da padre in figlio, gestisco quest'attività da quarantacinque
anni o forse anche 50. Praticamente questo pesce per me non ha segreti».
Dalle vasche ripiene d'acqua il signor Michele esce il pesce in ammollo
e ne mostra la "purezza" della carne bianca, spiegando la lavorazione.
«Lo stoccafisso (pesce stocco) e il baccalà sono il prodotto di due
differenti lavorazioni del merluzzo per renderlo conservabile più a
lungo. Una volta pescato il merluzzo, liberato già sul natante della
testa, delle pinne, della coda e dell' intestino, viene immediatamente
messo in barili, con abbondante sale che ne garantisce il prosciugamento
e la lunga conservazione e diventa baccalà. Quando invece il merluzzo
viene fatto essiccare all'aperto, si ha lo Stoccafisso.

Questo pesce arriva tutto dalla Norvegia, mentre il gaspé è un genere di
baccalà che proviene dal Canada e che viene essiccato col metodo dello
stocco».
Un uso poliedrico. Per preparare antipasti sofisticati: mantecato con
pomodorini secchi o marinato ad insalata; fritto con la pastella; alla
ghiotta (stocco alla messinese con patate olive, capperi e pomodoro);
cotto a vapore con acqua aromatizzata al limone e menta o semplicemente
a polpettine per i bambini stocco e baccalà sono ricchi di proteine,
sali minerali, hanno pochi grassi e calorie. «Quelli che sono utili: gli
Omega 3», afferma il giovane nipote di Michele, Salvatore, che ai
clienti più curiosi regala anche un ricettario.
E a proposito di curiosità, i bene informati dicono che la moda abbia
fatto lievitare i prezzi: lo stocco costa 15 euro al kg, i filetti di
baccalà 12.50 euro al kg; mentre per comprare il baccalà norvegese
necessitano 11 euro al kg e per un chilo di Gaspè si spende 15 euro.
E per chi volesse scoprire sapori nuovi, infine, la ricetta di un dolce.
«Bisogna lavorarlo a lungo con un filo di olio facendolo diventare una
crema e poi unirvi delle bucce di limone caramellato. Dolce azzardato,
ma buono» conclude la Maria Elena Curzio.
Lucy Gullotta (La Sicilia del 17 feb 2013)

IL RE DEL BACCALA' (by
Massimo Vittorio)
Al numero 33 della storica via Gisira, nel cuore
di Catania, vi è una bottega di stocco & baccalà, una semplice
bottega che porta dentro di sé una storia intrisa di tradizione,
sacrifici e affetto. L’ incontro che ho avuto con Carmelo, il
titolare, è stato del tutto casuale e forse questa storia assume per
me quel valore in più proprio perché frutto della casualità. Nel
settembre del 2021, girando tra i vicoli colorati della pescheria mi
imbatto nella via Gisira. Facendomi largo tra bancarelle e
banchetti, tra file di turisti ferme tra le ombre degli ombrelli che
si stagliano nel lavico basolato, attira la mia curiosità una
tabella legata con una corda ad una asta di ferro con su scritto:
“Baccalà norvegese 1° qualità spugnato”. Mi avvicino e volgendo
curioso lo sguardo verso l’interno noto delle vasche di marmo
bianco. Subito la mia mente va a pescare tra le tasche della memoria
ricordi d’infanzia, quando andavo a comprare il baccalà nel periodo
invernale in una bottega dove il forte odore, che già inebriava la
via, ti investiva con tutta la sua forza nel momento in cui il pesce
veniva estratto dalla vasca piena d’acqua.
Ricordi che svaniscono
nel momento in cui viene il mio turno ed il sig. Toscano gentilmente
mi chiede in cosa può essere utile. La macchina fotografica che ho
con me non passa inosservata e subito diventa il mezzo di
comunicazione e, senza quasi farci caso, parliamo subito di memoria,
fotografia, storia, tradizioni. Faccio spazio ad altri avventori e
inizio a scattare foto cercando di non essere invadente e provando a
testimoniare un lavoro che affonda le sue radici tanti secoli fa.

“Ricordo quando le moto ape facevano viaggi di andata
e ritorno per lo scarico delle merci, venivano dal mercato San Giuseppe
La Rena alla pescheria”, racconta Carmelo con un pizzico di nostalgia.
Ha 47 anni e ha iniziato questo lavoro a 15 anni, “anche se già all’età
di sei anni scendevo giù in pescheria perché mio padre aveva una
salumeria, siamo negli anni 80”. La via Gisira era una vera e propria
strada commerciale, aperta quasi ventiquattrore al giorno. Si iniziava
la mattina presto e si smontava nel tardo pomeriggio. Non c’erano ancora
i vari ristoranti o la movida che riempiono a poco a poco gli spazi
lasciati dalle vecchie botteghe. Qualcuno ancora resiste, con tenacia,
con passione, con speranza. Resiste perché si sente parte integrante del
luogo, perché è lì che ci sono le proprie radici, dove ogni portone ha
con sé una sua storia fatta di ricordi, dolci e amari.

E la bottega di
Carmelo Toscano è una di queste, portando con sé una bella storia che
tramanda rispetto e affetto. In realtà il titolare per tanti anni è
stato il sig. Pippo Giuffrida il quale ha preso con sé “a bottega” il
giovanissimo Carmelo, il quale ha sempre seguito tutti i suoi consigli
diventando nel tempo non solo un abile aiutante ma ha creato pure un
rapporto affettivo, al punto di essere considerato il terzo figlio. E
Carmelo, oggi, ci parla del sig. Giuffrida con le lacrime agli occhi,
ricordando quanto gli ha insegnato e ha deciso di portare avanti la
tradizione come un segno di rispetto che un figlio ha per un padre. E
con lo stesso rispetto il sig. Pippo veglia il lavoro di Carmelo ogni
giorno. Tempo ne è passato e cambiano anche gli usi, “oggi le persone
preferiscono i centri commerciali al vocio dei venditori tra i banchi”
dice mestamente Carmelo, ma bisogna provare a resistere mantenendo
sempre la qualità, così come si faceva un tempo e “oggi ho ancora dei
suoi clienti, ma che siano vecchi o nuovi, per me quando consegno il
pacchetto con il pesce scelto dò sempre consigli e ricordo i passaggi da
fare prima di essere cucinato”. E in effetti non bisogna dimenticare che
in questa storia un altro protagonista d’eccellenza è proprio il baccalà
o stoccafisso, la cui differenza sta proprio nel metodo di
conservazione, perché fondamentalmente è lo stesso merluzzo (gadus
morhua). U piscistoccu o baccalaru ormai è entrato da secoli nella
cucina siciliana (e non solo), tradizionalmente diventato un piatto
tipico durante le festività natalizie ma, ci assicura Carmelo, “non è
vero che il baccalà è cucinato solo nel periodo invernale, c’è una buona
consumazione anche in estate”.

La storia del baccalà si perde nella notte dei tempi.
Il merluzzo è detto “maiale di mare”, poiché come del maiale non si
butta niente. In Sicilia probabilmente arriva grazie ai normanni,
intorno all’anno mille. Il basso costo e l’elevato valore nutrizionale
ne hanno fatto l’alimento principale di tutte le popolazioni meno
abbienti d’Europa. Inoltre con il Concilio di Trento che raccomandava
oltre duecento giorni di “magro”, il merluzzo divenne cibo ideale a tale
scopo.
Lo stoccafisso migliore è considerato quello
proveniente dalle isole Lofoten, riconosciuto con il marchio IGP
dall’UE. Il baccalà è un prodotto che ci arriva da mari lontani e che ha
conquistato le mense di quasi tutti i ceti sociali, ideale per ogni
fantasia gastronomica, che nel tempo ha stuzzicato la creatività delle
nostre nonne e madri, elaborando piatti succosi e saporiti. Dicevamo che
la storia del baccalà si perde nella notte dei tempi e infatti, scrive
Livio Cerini di Castegnate: “il baccalà porta con sé lunghe storie di
vicende umane, di migrazioni, di viaggi famosi; partecipa all’origine
del commercio e degli scambi tra i popoli, a usi e costumi, ha un suo
pizzico di letteratura. I suoi valori alimentari e culinari sono
inestimabili e vale realmente la pena di conoscerli a fondo per
goderseli in tutti i modi e in tutte le stagioni.” Questa lettura
poetica mi piace accostarla alla storia di Carmelo Toscano, che oggi,
all’età di 47 anni, difende con tenacia un lavoro che trasmette
tradizione, rispetto e affetto in memoria di Pippo Giuffrida “il re del
baccalà”.
https://vittoriomassimo.wordpress.com/2022/12/31/il-re-del-baccala/?fbclid=IwAR3tG_9aHKrlMTHN6q_hp_nfxrdqXeBnpatwwa0aRYRJTNWzFXzHwSFFGSY
I MIGLIORI A CATANIA

Aringhe affumicate, che a Catania chiamano "Arenga"


La Sàusa.
 Potrebbe
trattarsi della simulazione di una pietanza presente sulle
tavole dell'antica nobiltà siciliana, che il popolo non poteva
permettersi. Ma se con le sarde a beccafico si cercava
di imitare l’uccelletto e con quelle allinguate la
prelibata sogliola (in spagnolo “lenguada”), qui non
credo si possa simulare qualcosa perché a vederla
sembra solo un’accozzaglia ittica, ben condita, per
attenuare i morsi della fame
plebea. Come la pietanza, probabilmente il termine
deriva dagli arabi, forse dovuto alla quantità di grasso
animale presente
o dalla storpiatura di "sauza" (salsa). Potrebbe
trattarsi della simulazione di una pietanza presente sulle
tavole dell'antica nobiltà siciliana, che il popolo non poteva
permettersi. Ma se con le sarde a beccafico si cercava
di imitare l’uccelletto e con quelle allinguate la
prelibata sogliola (in spagnolo “lenguada”), qui non
credo si possa simulare qualcosa perché a vederla
sembra solo un’accozzaglia ittica, ben condita, per
attenuare i morsi della fame
plebea. Come la pietanza, probabilmente il termine
deriva dagli arabi, forse dovuto alla quantità di grasso
animale presente
o dalla storpiatura di "sauza" (salsa).
Si tratta delle parti
della testa del tonno: lingua, occhi, mascelle, bocca,
branchie, frattaglie, guance, cartilagini di contorno e
parti grasse del collo (tranne la parte dorsale, che è
un taglio pregiato del tonno rosso). Tutto ciò viene
messo sotto sale per 30-40 giorni, poi bollito e infine
lasciato per 48 ore in acqua, ghiaccio e limone. Dopo
una risciacquata, questa festa di trigliceridi viene
condita con olio, limone, prezzemolo e peperoncino.
Per chi non soffre di
pressione alta (per via del sale), questa gustosa
"porcheria" è una prelibatezza che ormai è difficile
trovare anche alla Pescheria storica di Catania. Non è
facile incontrare colui che perde del tempo a prepararla
e poi venderla al banco. Una volta considerata il "cibo
dei poveri", oggi costa parecchio perché si prepara
quasi su ordinazione, per veri amatori di questa
leccornia.

Alici diliscate alla Pescheria di Catania

carciofi alla brace alla Pescheria di Catania preparati da Gaetano


foto
di Francesco Raciti
Il lupino: un legume versatile ricco
di storia e di proprietà nutritive
I lupini sono i semi delLupinus albus, una pianta appartenente alla
famiglia delle Leguminose, alta fino a 1 metro e con foglie palmate. Si
tratta di un legume noto e diffuso fin dalla più remota antichità nel
bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente, citato da Giovanni Verga ne
“I Malavoglia”, in cui scrive: “Sulla riva c’era soltanto padron ‘Ntoni,
per quel carico di lupini che ci aveva in mare, colla Provvidenza e suo
figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non
aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo
fratello Menico, nella barca dei lupini. …”
In tempi di carestia, i ragazzini erano soliti andare in giro con le
tasche piene di lupini “sanati”, che piluccavano, lasciando una scia di
bucce. Oggi, più che un alimento, troviamo i lupini come passatempo
alle sagre e alle fiere paesane, dove vengono venduti nelle bancarelle.
Questo legume, dalle origini antichissime, è stato coltivato con diverse
finalità: per migliorare il suolo a pascolo, nell’alimentazione umana,
per le sue qualità terapeutiche. Gli archeologi hanno ritrovato i suoi
semi nelle piramidi egizie e maya. Le prime coltivazioni vengono fatte
risalire a circa 4000 anni fa, sia nell’area del Mediterraneo, che nelle
zone andine del Sud America.

Luppinaru, venditore di luppini (lupini = Lupinus spp.).
Munito di bicicletta sulla quale vi caricava du panara ri luppini, che vendeva
co coppu (involucro) fatto di carta paglia (che era usata per avvolgere la pasta
quando si comprava a “ròtulu”). Ordinariamente si sentiva vanniari dopo pranzo
del sabato o della domenica; era solito anche piazzarsi vicino na putia, dove il
cliente poteva prendere un buon bicchiere di vino.
I lupini sono composti per il 10 % di acqua, il 40 %da carboidrati, il
38 %da proteine, il 3,2 %da ceneri e la restante percentuale è formata
da grassi. Al loro interno sono presenti anche minerali come lo zinco,
che promuove la funzione immunitaria; il manganese, che neutralizza i
radicali liberi, prevenendo i danni cellulari; rame, selenio, magnesio,
che mantiene perfetta la densità ossea e protegge il sostegno muscolare;
calcio, fosforo, potassio, sodio e ferro; mentre le vitamine presenti
sono la vitamina A, le vitamine del gruppo B e la vitamina C. E’ molto
elevata anche la presenza di aminoacidi come l’acido glutammico e
l’acido aspartico. Il lupino contiene arginina, che ha effetti benefici
sulla funzione endoteliale, migliorando la prestazione dei vasi
sanguigni, tiamina (vitamina B1), essenziale per il metabolismo dei
carboidrati e dei grassi, che aiuta a mantenere in forma il sistema
nervoso, acido folico (vitamina B9), che aiuta le cellule corporee a
metabolizzare le proteine e controlla l’attività dei geni. Questi legumi
si pongono come ottima alternativa alle proteine di origine animale,
fornendo un apporto notevole: le proteine in essi presenti, infatti,
corrispondono a 38 gr. ogni 100 gr. di prodotto, quantità paragonabile a
quella della carne e superiore a quella delle uova; sono facili da
digerire, prevengono l’ipertensione, riducono i livelli di colesterolo
cattivo, aumentando quello buono grazie agli omega 3; contenendo
tocoferolo prevengono il diabete di tipo2 e il tumore al colon, grazie
alla proteina conglutina, contenuta nei semi, combattono l’accumulo di
glucosio nel sangue, mimando l’azione dell’insulina. Essenziale è la
funzione esercitata dalle fibre, che accelerano il transito intestinale,
contrastano la stipsi, danno un senso di sazietà, aiutando nel
dimagrimento in una dieta ipocalorica e bilanciata.
I lupini, che contengono 116 kcal per 100 gr. di prodotto, possono
essere consumati solo dopo un lungo periodo di ammollo con ricambio
d’acqua per 12 ore, effettuato per 3-4 giorni e dopo bollitura in acqua
per 20 minuti in modo da eliminare la lupaina e la lupinina, sostanze
alcaoloidi basiche, tossiche se ingerite in elevate quantità e
amarissime (lupinus, infatti, in greco significa “sapore amaro”). Per
ottenere lo snack che tutti conosciamo, occorre aggiungere circa il 10%
di sale sul peso totale del lupino trasformato. La farina di lupino
viene già utilizzata, per gli intolleranti al glutine, nella
preparazione di pane, pasta, biscotti, cracker, insaccati e carne in
scatola. Riscopriamo, dunque, le innumerevoli virtù benefiche di questo
legume antico, ricco di storia, consumandolo un po’ più spesso, non solo
nelle sagre e nelle feste di paese.
Caterina Lenti
http://www.siciliafan.it/il-lupino-legume-versatile-ricco-storia-proprieta-nutritive/

|
|









.jpg) Non
è nebbia sulle strade, ma carne al fuoco.
Non
è nebbia sulle strade, ma carne al fuoco.
.jpg) empre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a
governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio
della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro
di Aragona. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino
al1375. Furono anni di guerre ed ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri
investiti dagli aragonesi.
empre gli uni contro gli altri armati, hanno preferito chiamare a
governare altri potenti. Il parlamento siciliano riunitosi nell'atrio
della Martorana decise di dare la corona del Regno di Sicilia a Pietro
di Aragona. La Sicilia rimase "indipendente" sotto gli aragonesi fino
al1375. Furono anni di guerre ed ai vecchi baroni se ne aggiunsero altri
investiti dagli aragonesi. 



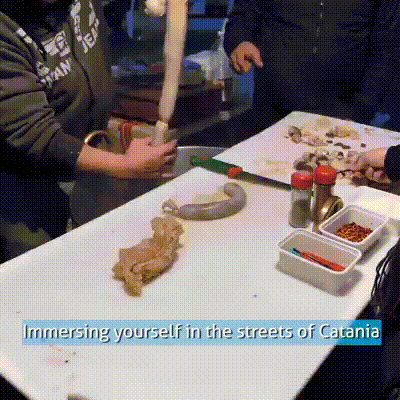 ad avere esito in cucina, in
preparazioni ripescate dalla tradizione, o individuate nel loro
specifico e
ad avere esito in cucina, in
preparazioni ripescate dalla tradizione, o individuate nel loro
specifico e


 Cappellani - La Sicilia del
24.11.2019
Cappellani - La Sicilia del
24.11.2019

.jpg) Le
panelle di Palermo
Le
panelle di Palermo.jpg) Altro prodotto da "friggitoria" era la melanzana, da sempre accreditata
come la "carne dei poveri": tagliata a "fieddi" (fette) , poi fritte, da
mettere in mezzo al pane o "a quaglia" (nulla a che vedere con l'omonimo
volatile) cioè incisa lungo i lati, lasciando la parte superiore
integra, poi fritta intera, ideale nella stagione estiva per una
colazione in riva al mare.
Altro prodotto da "friggitoria" era la melanzana, da sempre accreditata
come la "carne dei poveri": tagliata a "fieddi" (fette) , poi fritte, da
mettere in mezzo al pane o "a quaglia" (nulla a che vedere con l'omonimo
volatile) cioè incisa lungo i lati, lasciando la parte superiore
integra, poi fritta intera, ideale nella stagione estiva per una
colazione in riva al mare.

.jpg) Dicono
che nella cottura della carne di cavallo, come si può constatare nei
rioni di via Plebiscito, il trucco sta nel buttare il salmoriglio
Dicono
che nella cottura della carne di cavallo, come si può constatare nei
rioni di via Plebiscito, il trucco sta nel buttare il salmoriglio.jpg) ma il carbone.
ma il carbone.









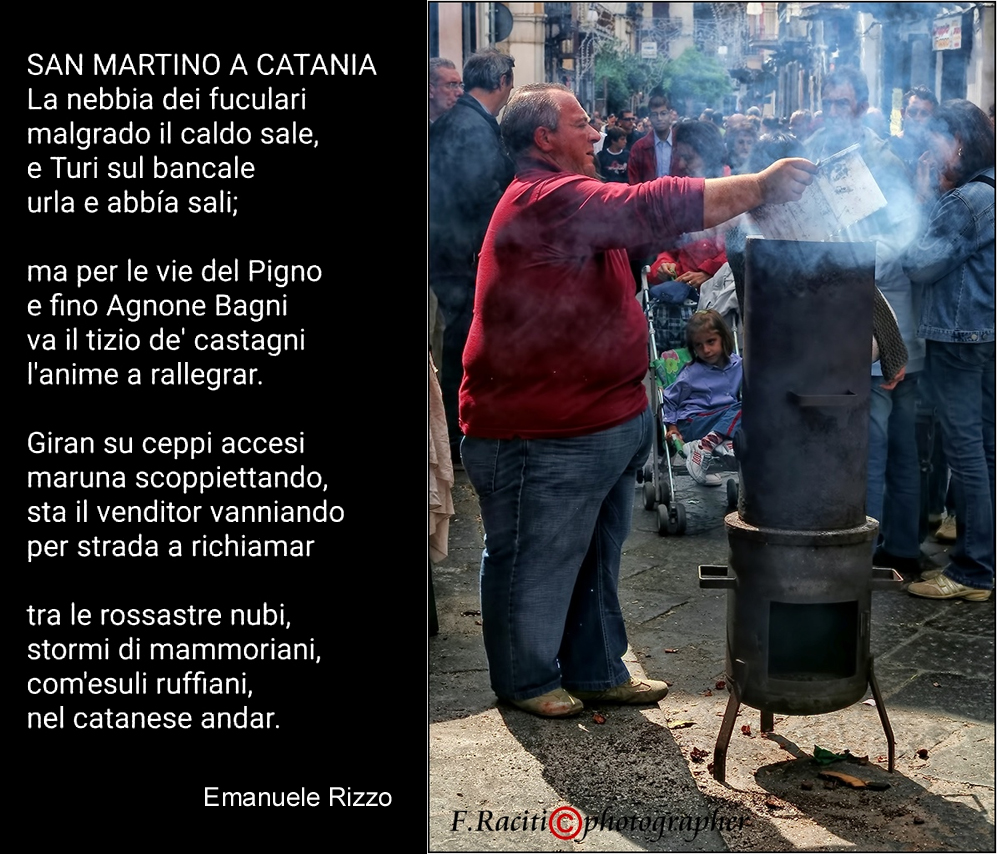






 ustosa salsiccia o un salame. Le salsicce in
particolare sono un alimento amato da quasi tutti, perfetto per essere
gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino croccante
con due foglie di insalata e una dose generosa di salse. Può capitare
però di dover preparare un pasto da mangiare con forchetta e coltello, e
di voler evitare la solita anonima padella: fortunatamente la salsiccia,
come il maiale, è versatile e si presta a numerose interpretazioni. Ecco
quindi 10 modi per preparare le salsicce, con qualche suggerimento di
cottura a cui forse non avevate ancora pensato.
ustosa salsiccia o un salame. Le salsicce in
particolare sono un alimento amato da quasi tutti, perfetto per essere
gustato, nelle sue numerosissime varianti locali, in un panino croccante
con due foglie di insalata e una dose generosa di salse. Può capitare
però di dover preparare un pasto da mangiare con forchetta e coltello, e
di voler evitare la solita anonima padella: fortunatamente la salsiccia,
come il maiale, è versatile e si presta a numerose interpretazioni. Ecco
quindi 10 modi per preparare le salsicce, con qualche suggerimento di
cottura a cui forse non avevate ancora pensato. caso
generalmente non occorrono grassi aggiuntivi.
caso
generalmente non occorrono grassi aggiuntivi.










 ricurva
verso l’alto.
ricurva
verso l’alto.









 Prodotta
con metodi tradizionali ed utensili storici, dopo la produzione, rimane nella
fiscella per circa 24 ore, in modo da permettere il necessario drenaggio del
siero e, nello stesso tempo, di farle assumere la giusta consistenza.
Prodotta
con metodi tradizionali ed utensili storici, dopo la produzione, rimane nella
fiscella per circa 24 ore, in modo da permettere il necessario drenaggio del
siero e, nello stesso tempo, di farle assumere la giusta consistenza.

































