|


lattuga, radicchio,
bietola, asparago, indivia, borragine, sedano, spinacio, rucola,
catalogna, cavolo, basilico, bietola, spinaci, cardo, cicoria;

CLICCA PER APPROFONDIRE

|
LATTUGA
LOLLO bionda o rossa
  La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in
Campania da circa un
decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso
leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE
RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi
con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),
portamento basso e semisferico. La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in
Campania da circa un
decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso
leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE
RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi
con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),
portamento basso e semisferico.
La lollo verde è una tipologia di lattuga con cespi di
colore verde brillante chiaro, bassa ed semisferica.
Poverissima di calorie, è un ottimo rinfrescante e
aperitivo. Presenta una buona dose di vitamine, minerali
e oligoelementi, specialmente iodio, nichelio, cobalto,
manganese e rame.
Entrambe sono specie biennale, il primo anno forma una
rosetta, il secondo lo scapo fiorale. Le foglie basali
formano un grumolo o "testa" più o meno compatto. Lo
scapo fiorale è alto 100-150 cm e porta ramificazioni
corimbiformi terminanti con un capolino. I fiori sono
ermafroditi, ligulati e gialli, i semi sono costituiti
da un achenio di colore bianco marrone e nero, separato
dal pappo.
Dal gusto intenso è adatta a condimenti forti ed è
ampiamente usata in cucina mescolata con altri tipi di
lattuga, nelle insalate miste.
La lollo è coltivata in prevalenza per IV gamma per la
produzione di TRIS insieme con altre tipologie,
croccante e di sapore leggermente amarostico, ottima
shelf life.
http://www.terramore.net/lollo-rossa-e-verde.html
|

IL FINOCCHIO

Il finocchio (Foeniculum vulgare) fa parte della stessa famiglia
delle carote, così come il prezzemolo, il sedano, l'aneto e il
coriandolo. Diversamente dai suoi aggraziati parenti, però, il
finocchio è un ortaggio goffo, dall'aspetto buffo: un corpo bulboso,
croccante e bianco sormontato da steli con foglioline svolazzanti.
Ma ha un pregio: diversamente dalla maggior parte delle verdure, è
commestibile in ogni sua parte (corpo, gambo, foglie e semi),
 e può
essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche. e può
essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche.
Il finocchio coltivato (o dolce) è una pianta annuale o
biennale con radice a fittone. Raggiunge i 60–80 cm di
altezza. Si consuma la grossa guaina a grumolo bianco
che si sviluppa alla base.
Il finocchio è ampiamente coltivato negli orti per la
produzione del grumolo, una struttura compatta
costituita dall'insieme delle guaine fogliari, che si
presentano di colore biancastro, carnose, strettamente
appressate le une alle altre attorno a un brevissimo
fusto conico, direttamente a livello del terreno.
Il suo colore bianco è dato dalla tecnica
dell'imbianchimento: si tratta di una rincalzatura e si
effettua a cadenza regolare nel corso dello sviluppo del
grumolo o almeno due settimane prima della raccolta.
La raccolta dei grumoli avviene in tutte le stagioni,
secondo le zone di produzione. Si adatta a qualsiasi
terreno di medio impasto con presenza di sostanza
organica. Le piante vengono disposte in file e
distanziate di circa 25 cm l'una dall'altra. La raccolta
del grumolo avviene dopo circa 90 giorni dalla semina.
Richiede frequenti e abbondanti irrigazioni e preferisce
un clima temperato di tipo mediterraneo.
Il finocchio è sempre stato considerato un cibo saporito e
versatile, e un tempo alimentava anche un grande mercato. Nel mondo
antico, una varietà di finocchio gigante di nome silfio ha fatto la
fortuna di Cirene, una colonia greca in Nord Africa, nell'attuale
Libia. Il silfio era così importante per l'economia del posto che la
sua immagine veniva impressa sulle monete, sia sotto forma di
baccello a forma di cuore (secondo una teoria, da qui deriverebbe la
raffigurazione del classico cuore di San Valentino), sia accanto a
una figura femminile che si indica il pube in modo significativo:
oltre a essere molto usato nelle ricette romane (Marco Gavio Apicio,
nel suo De re coquinaria, raccomanda di servirlo con il melone
bollito), il silfio di Cirene era ampiamente usato come
contraccettivo. Da qui deriverebbe la sua massiccia richiesta:
nell'antichità, insomma, il finocchio era quanto di più simile si
potesse trovare alla pillola del giorno dopo.

Non possiamo provarlo, sfortunatamente. Il silfio sembra essersi
estinto intorno al primo secolo dopo Cristo, forse proprio a causa
della raccolta eccessiva per usarlo a scopi contraccettivi. Plinio
il Vecchio lo raccomandava anche per i morsi di serpente e le
punture di scorpione, per curare la gotta e l'epilessia (ma,
avverte, non per il mal di denti: lo scrittore racconta di un uomo
che dopo aver applicato un impacco di silfio su un dente sofferente
si era buttato giù da una scogliera per il dolore), e sostiene che
l'ultimo stelo di silfio sia stato divorato dall'imperatore Nerone.
La resina odorosa viene prodotta dal carnoso fittone (la radice
principale) della pianta, quando ha quattro anni; è usata, seccata e
fatta in polvere, nella cucina indiana. L'odore agghiacciante se ne
va quando l'assafetida viene gettata nel burro o nell'olio bollente,
trasformandosi in un piacevole aroma simile a quello dell'aglio. In
Occidente, l'assafetida contribuisce all'aroma speziato della salsa
Worcestershire.
Al'inizio del XX secolo, si pensava che il cattivo odore
dell'assafetida fosse in grado di curare qualsiasi cosa,
probabilmente perché si dava per scontato che nessun organismo
patogeno avesse il coraggio di avvicinarsi. Fu addirittura inserita
nella farmacopea degli Stati Uniti come rimedio per l'epidemia di
spagnola del 1918. Generazioni di riluttanti studenti sono stati
obbligati a indossare attorno al collo dei sacchetti contenenti
assafetida per prevenire qualsiasi malattia, dalla poliomielite al
morbillo, dalla pertosse al comune raffreddore. In alcuni casi
potrebbe aver aiutato davvero: di sicuro, nessuno voleva avvicinarsi
a chi girava con un pacco di assafetida, cosa che potrebbe aver
limitato alcuni casi di contagio.
E per la stessa ragione, potrebbe aver avuto un effetto deterrente
per quanto riguarda i rapporti sessuali. Anche se, probabilmente,
non è proprio ciò che avevano in mente gli antichi romani.
http://www.nationalgeographic.it/food/2016/08/04/news/finocchio_l_ortaggio_multitasking-3192670/
 |
Nel finocchio non esistono piante «maschio» e piante
«femmina»; questo è solo un modo comune di chiamare i
grumoli (e neppure in tutte le zone dove si coltiva
questo ortaggio). I grumoli non sono altro che la parte
del finocchio che si consuma: quelli con forma
tendenzialmente tondeggiante (nella foto) sono
considerati «maschi», destinati in prevalenza a essere
consumati crudi; quelli con forma sostanzialmente
appiattita sono considerati «femmine», utilizzate
soprattutto dopo cottura. Lo sviluppo di grumoli
cosiddetti «maschio» o di grumoli cosiddetti «femmina»
dipende soprattutto dalla selezione delle sementi delle
varietà disponibili per il piccolo appassionato. La
presenza di grumoli «femmina» è limitatissima nelle
varietà a disposizione dei coltivatori professionisti.
|


carciofo,
cavolfiore, broccolo;
BROCCOLO
Il broccolo (Brassica oleracea var. italica), chiamato anche cavolo
broccolo, è una varietà di Brassica oleracea, la grande famiglia di
piante conosciute comunemente come cavoli e che comprende numerose
varietà molto diverse di aspetto. I broccoli rientrano nel gruppo di
piante di cui non vengono mangiate le foglie bensì le infiorescenze
non ancora mature.
Viene coltivato in varie zone d'Italia e del mondo anche se è una
pianta originaria dell'area mediterranea e diffusa già all'epoca
romana (come suggerisce anche il nome scientifico). È un ortaggio
molto conosciuto.

Il suo utilizzo in cucina è diffuso in gran parte d'Europa e del
mondo, soprattutto previa cottura e per la preparazione di zuppe e
minestre. Il broccolo è originario del Sud Italia e ancora oggi,
fuori dall'Italia, viene associato alla cucina italiana. Si può
consumare crudo pinzimonio, ma è valorizzato soprattutto dalla
cottura al vapore, gratinata o saltata. Rientra in numerose
preparazioni tipiche regionali.
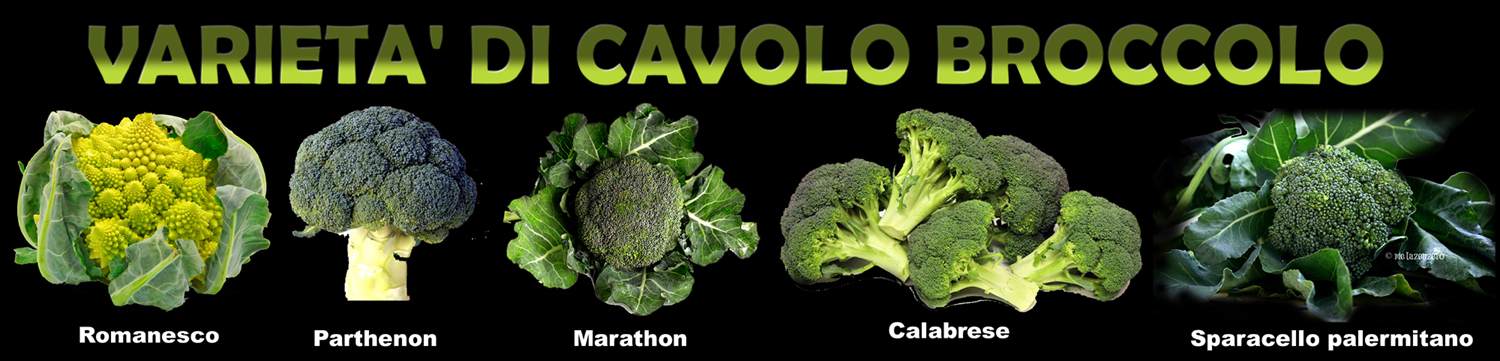
CAVOLFIORE VIOLETTO DI ADRANO
Il cavolfiore è il fiore commestibile della
pianta erbacea Brassica oleracea L., appartenente alla famiglia
delle Crucifere. In Italia questo ortaggio presenta diverse
proprietà organolettiche in relazione al luogo in cui viene
coltivato.
Nel catanese, in particolar modo nella città
Etnea di Adrano il Cavolfiore cambia connotati rispetto al classico
cavolfiore bianco.
Queste caratteristiche sono dovute ad modifiche
genetiche ad opera degli agricoltori del luogo: Il cavolfiore
diventa ricco di antiossidanti, tra cui antociani carotenoidi,
presentando la tipica colorazione violetta.
Il cavolfiore violetto è una verdura tipica del
catanese appartenente al VII gruppo degli alimenti per il suo
quantitativo quantitativo di vit. C (acido ascorbico);
parallelamente, potrebbe essere inquadrato tra gli alimenti del VI
gruppo, in quanto non mancano i carotenoidi (pro-vitamina A). Grazie
al notevole contenuto di antiossidanti (anticiani, il sulforafano,
la clorofilla ecc.) il cavolfiore crudo rappresenta un alimento
dalle caratteristiche anti-aging e anti-tumorali.

Il cavolfiore apporta un’ottima razione di fibra
alimentare, componente saziante, preventiva e terapeutica verso la
stitichezza, modulatrice dell’indice glicemico, prebiotica ed
ipocolesterolemizzante. Analogamente alle altre Brassica oleracea,
anche il cavolfiore cotto e frullato (a comporre una minestra
brodosa) può essere utilizzato nella purificazione e nel ripristino
della funzionalità intestinale ed epatica in seguito a periodi di
cattiva alimentazione.
D’altro canto, il cavolfiore è ricco di purine,
ragion per cui viene escluso dalla dieta preventiva
dell’iperuricemia e della gotta.
Perché utile nella prevenzione di tumori.
Molti tumori a crescita rapida consumano una
notevole quantità di energia, assorbendo l’ossigeno che si trova
nelle aree circostanti e rendendo la presenza di HIF-1 critico per
la loro sopravvivenza. HIF-1 (transcription hypozya-inducible factor
1) è una proteina che può svolgere la propria funzione solo in
presenza di un elevato livello di radicali liberi. Se gli
antiossidanti eliminano radicali liberi, tendono ad arrestare
l’azione della proteina HIF-1 e di conseguenza la crescita del
tumore.
Un gruppo di ricercatori Johns Hopkins University,
attraverso esperimenti condotti sui topi, è riuscito a dimostrare
che una significativa supplementazione nella dieta con vitamina C
fosse in grado di prevenire il cancro ed inibire la crescita di
alcuni tumori. Come? per via della capacità degli anti ossidanti nel
destabilizzare la crescita crescita di alcuni tumori in condizioni
di scarsità di ossigeno.
I ricercatori hanno concluso che l’azione
protettiva degli antiossidanti non deriverebbe dalla prevenzione dei
danni al DNA ma sfrutterebbe un altro meccanismo. In particolare,
coinvolgerebbe la proteina HIF-1, ove la sua elevata presenza a
causa di ipossia (mancanza di ossigeno) e radicali liberi aumenti la
proliferazione delle cellule tumorali. Mentre l’impiego di
antiossidanti, quali vitamina c, diminuendo i radicali liberi e
conseguentemente l’azione di HIF-1 la quale viene inibita, porti
all’arresto della crescita delle cellule cancerogene.
A cura del dott. Carmelo Gulli
http://www.mitocondrio.it/cavolfiore-violetto-di-adrano-un-alleato-nella-prevenzione-di-tumori/

https://www.mimmorapisarda.it/altro/ctcalcio/cart/69-87.jpg
https://www.mimmorapisarda.it/altro/ctcalcio/cart/04.jpg
Vi
presento il 'bastardo'
Devo una spiegazione in merito alla foto, non
mia, pubblicata ieri, in quanto, com’era forse da aspettarsi, non
tutti i miei amici hanno colto l’associazione, fatta da un 'erbaiuolo',
tra la foto dei cavolfiori e un noto politico. "Cosa c’entra?" mi ha
scritto un amico non catanese; "Ma io non ho capito, eppure sono
sicula etnea!", commenta un’altra. Approfitto dunque
dell’occasione, prendendola alla lontana, per parlarvi dei nomi del
‘cavolfiore’ (Brassica oleracea, var. botrytis) in Sicilia.
Scrive su "Il ruggito degli Iblei" (19-11-2009)
la blogger siculo-piemontese che si fa chiamare ‘Piccola samurai’
che «In Sicilia tutto è broccolo. Non importa se bianco, verde,
rosso, nero, cappuccio o che altro. Tutto è broccolo. Pertanto,
quando cerchi di spiegare una ricetta che tu fai con il broccolo,
quello che per te è verde, uno capisce cavolfiore, l'altro capisce
cavolo. Insomma, una zuppa».
In realtà le cose non stanno così: è vero, per
esempio, che ‘broccolo’ può significare ‘cavolfiore’, ma non nella
stessa area. In ogni area, infatti, i parlanti distinguono con nomi
diversi i vari ortaggi cui fa riferimento la blogger. Parliamo
dunque dei nomi del cavolfiore, avvertendo che in Sicilia ne sono
coltivate e commercializzate almeno tre diverse varietà, quella
bianca, quella verde e quella viola.
Il nome più diffuso sembrerebbe il tipo "cauliçiuri"
("caulu di xiuri" nell’Hortus Catholicus di Francesco Cupani, 1696)
con diverse varianti. Nella Sicilia occidentale prevale il tipo "bbròcculu",
"vròcculu", con varianti fonetiche e morfologiche. Chi va in una
trattoria di Palermo e ordina la ‘pasta coi broccoletti arriminati’
in realtà mangia ‘penne o bucatini conditi con mollica abbrustolita
e cavolfiore prima cotto in acqua e poi soffritto con aglio, pinoli
ed altri ingredienti’. In area centrale prevale il tipo "smuzzatura",
con varianti. Nella Sicilia sudorientale troviamo i tipi "scamuzza",
"scamuzzatura" e "çiurietti". Giungiamo, finalmente, a Catania e in
qualche altro centro etneo in cui il ‘cavolfiore’ è chiamato "bbastaddu".
Perché, potreste chiedere a questo punto, il
cavolfiore a Catania e dintorni si chiama ‘bastardo’? Cominciamo,
intanto, col dire che ‘bastardo’ significa ‘prodotto ibrido di due
razze diverse’; ‘pianta per incrocio’, ed è evidentemente ricavato
da una locuzione sostantiva come *"càulu bbastardu*, o anche *"bbròcculu
bbastardu", entrambe derivate dall’italiano "cavolo bastardo" e
"broccolo bastardo", documentate in alcuni trattati di botanica,
come in questi due esempi, fra i tanti:
1) «Sanno eglino ab immemorabili, che molte
piante congeneri, e di famiglia, che fioriscono alla stessa epoca,
possono, attesa la mescolanza de’ pulviscoli, o frutti, e semi
imbastarditi, quindi niuno di essi, sebbene all’oscuro dei due
articoli inseriti nel Calendario georgico, semina i Cetrioli presso
i Poponi, nè le belle varietà del Cavol fiore presso il Cavol nero
appunto per evitare il tralignamento, che darebbe ai Poponi il
cattivo odore de’ cetrioli, e farebbe sparir la palla dal Cavol
fiore, riducendolo al così detto Cavolo bastardo, che non è nè un
Cavol fiore, nè un Cavol nero, ma una razza di mezzo tra l’uno, e
l’altro» (recensione al " Calendario georgico della R. Società
agraria di Torino per l’anno 1882");
2) «Tanto per gli animali quanto per le piante
che fuorviano dalle loro naturali qualità, s’impiega il verbo
spuriare. Spuriati, sost. pl., sono una varietà di cavolfiore
bastardo, dal colore violetto» (Giustiniano Gorgoni, "Vocabolario
agronomico" 1891).
Appare evidente, dunque, che ‘bastardo’ è
riferito a una particolare varietà di cavolfiore, quella che si è
affermata nel Catanese, appunto, un «ibrido di media precocità che
si differenzia per la caratteristica infiorescenza a palla di colore
viola intenso che alla cottura diventa di un bel verde tenero» (aziendaagricolalacollina.it).
Il colore viola è dovuto al contenuto molto alto di antociani e
carotenoidi, sostanze che sono in grado di ridurre i danni provocati
dai radicali liberi. Particolarmente apprezzato da chi scrive è il
‘cavolfiore di Adrano’, "u bbastardömi", una varietà locale che si
contraddistingue dagli altri cavolfiori per il suo sapore
inconfondibile e unico.
Quanto all’etimo, infine, del nostro lessema,
"bastardo" deriva dal francese antico "bastard" ‘figlio nato da
un principe con una donna tenuta in concubinaggio’, voce di
ambito giuridico, assai probabil¬mente dal germ. *bansti *fattoria,
grangia ’ (cfr. got. bansts, con lo stesso valore), che spiega
anche l’antica espressione fils o fille de bast (GDLI).
Alfio Lanaia


IL MONDO DEGLI AGRUMI
è talmente vasto e articolato che ogni suo aspetto,
culturale e colturale, potrebbe essere, da solo, oggetto di un intero
volume. Si tratta, infatti, non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in
particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello
mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo
dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,
6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande
religione monoteista, l’ebraismo. non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in
particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello
mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo
dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,
6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande
religione monoteista, l’ebraismo.
Ogni agrume è, infatti, testimone di epoche e di grandi
civiltà e dovunque essi siano stati coltivati hanno sempre suscitato
meraviglia tale da essere divenuti rapidamente protagonisti delle lettere e
delle arti, oltre che dei mercati e della gastronomia. Così, l’arancio è il
simbolo stesso della civiltà islamica euro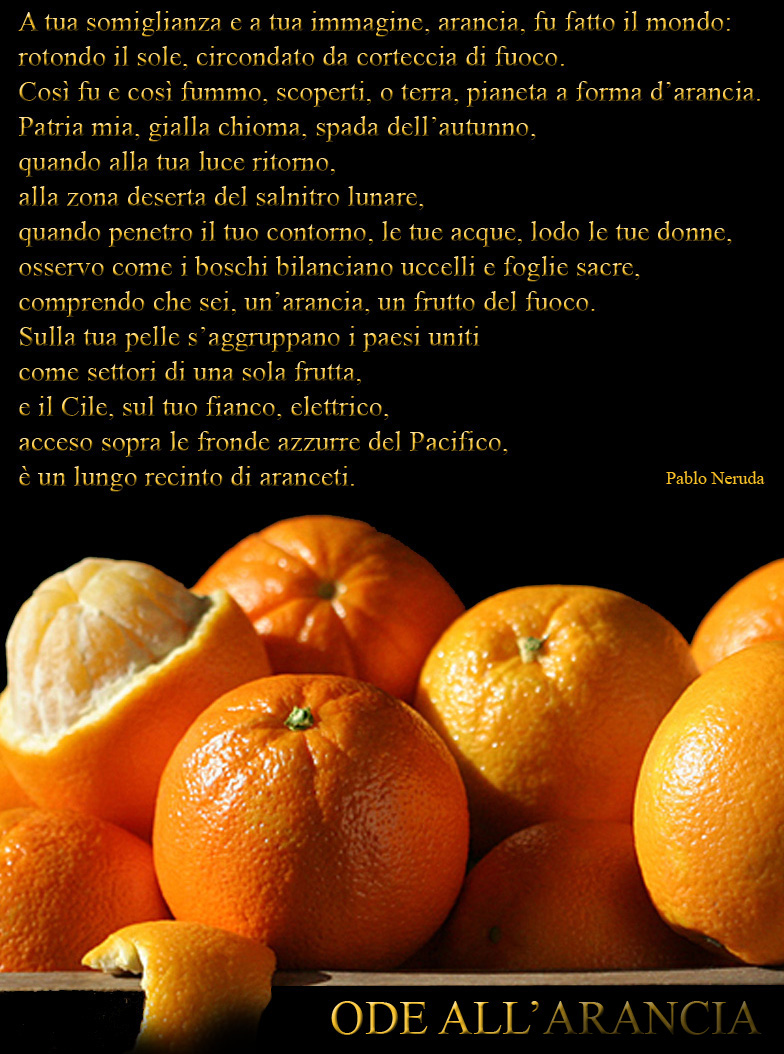 pea, diffusa nella Sicilia
arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli
successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di
diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del
Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville
Medicee, che ne sono simbolo imperituro. pea, diffusa nella Sicilia
arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli
successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di
diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del
Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville
Medicee, che ne sono simbolo imperituro.
L’idea stessa del paesaggio italiano, come luogo di
eterna primavera, reso immortale da Botticelli, con il boschetto di agrumi
che la rappresenta, fa sviluppare, in tutte le grandi corti europee la moda,
se non la necessità, delle orangeries, la cui tradizione, seppur in altro
modo, continua oggi con la fortuna dell’agrumicoltura ornamentale di fattura
italiana.
Stessa sorte tocca al limone, senza il quale il paesaggio
della Costa Amalfitana non potrebbe immaginarsi e che nel XIX secolo dalla
Sicilia raggiunse i mercati di tutto il mondo, quando alla navigazione a
vela fece seguito quella a vapore. E, ancora, il mandarino, che conquistò la
Conca d’Oro palermitana nel XIX secolo e del clementine capace di cambiare
il volto della piana di Sibari e dell’arco ionico tarantino, dando luogo,
negli ultimi decenni del XX secolo, a un sistema colturale utile a garantire
sviluppo economico in territori fino ad allora marginali.
Per non parlare, poi, di alcune specificità, tutte
italiane, anzi, calabresi, come la coltivazione del cedro e del bergamotto,
i cui prodotti, per ragioni affatto diverse sono comuni a larga parte del
mondo, anche se purtroppo, poco del loro valore aggiunto rimane nel nostro
Paese o, almeno, nei luoghi di coltivazione.
Abbiamo, volentieri accolto l’invito di coordinare questo
volume, che non poteva mancare nella Collana Coltura&Cultura di Bayer
CropScience. Lo abbiamo fatto immaginando un percorso articolato, tra
scienza e arte, in più di 50 capitoli, ma coerente con lo stile e la ragion
d’essere della Collana. Abbiamo chiamato a collaborare con noi oltre 60
Autori, tutti nomi di rilievo assoluto nel mondo degli agrumi e in quelli
comunque ad esso legati.
Il nostro obiettivo, che ci auguriano sia condiviso dal
Lettore, è stato quello di aver ancorato la divulgazione alle solide radici
della ricerca scientifica. Abbiamo voluto fornire al lettore informazioni
chiare, ricche di particolari, a volte anche di aneddoti, capaci, fin dove
possibile, anche nella scelta delle immagini, di compendiare il rigore della
ricerca con la vivacità dell’informazione; rispecchiando, in definitiva, i
valori propri del giardino di agrumi come luogo “fruttifero e dilettevole”,
dove scienza e arte si fondono.
E' un atto di fiducia verso un mondo che tanto ha dato
alla cultura del nostro Paese e tanto ha contribuito alla sua bellezza,
certi di poter continuare ad affermare, con Stendhal, che “C’è proprio un
Paese dove gli aranci crescono in piena terra? Chiedevo alla zia e avendo
spiegato la zia Elisabeth che c’era questo Paese e si chiamava Italia...”.
Eugenio Tribulato & Paolo Inglese
http://www.colturaecultura.it/titoli-agrumi.asp

Dagli scarti degli agrumi
un’alternativa all’olio di palma. Allo studio l’uso del pastazzo per
scopi alimentari
E se dai residui della spremitura industriale delle arance, il
cosiddetto pastazzo fatto di bucce, semi e parte della polpa, si
ottenesse un prodotto in grado di sostituire almeno in parte l’olio
di palma usato nei prodotti da forno? È il progetto al quale sta
lavorando un gruppo di ricercatori dell’Università di Catania, in
collaborazione con aziende locali e con la società di consulenza per
l’industria agrumaria Citrech.
«L’ambito più generale è quello della ricerca sui riutilizzi del
pastazzo, fino a poco tempo fa considerato esclusivamente come
rifiuto e ora invece riproposto come sottoprodotto di lavorazioni
alimentari da destinare, se possibile, a nuova vita» spiega Salvo
Barbagallo, professore di idraulica agraria e coordinatore del
progetto relativo ai nuovi impieghi in ambito alimentare. In effetti
nella sola Sicilia si producono ogni anno oltre 340 mila tonnellate
di pastazzo, che costano alla filiera oltre 10 milioni di euro
l’anno per lo smaltimento.
Da qui l’esigenza di trovare nuovi impieghi per questo sottoprodotto
secondario della lavorazione . «Il primo riguarda l’ambito
energetico, negli impianti a biomasse» continua Barbagallo. L’anno
scorso è stato realizzato il primo digestore pilota per la
conversione degli scarti di agrumi in energia, promosso dal
Distretto Agrumi di Sicilia e dall’Università di Catania con un
cospicuo finanziamento della Fondazione Coca Cola. Poi c’è il
settore agrario, dove il pastazzo potrebbe essere impiegato come
fertilizzante, ma è soprattutto l’ambito alimentare quello che
potrebbe riservare le sorprese più interessanti, per le industrie ma
anche per i produttori. «Si tratterebbe di un impiego pregiato, cosa
che permetterebbe di aumentarne il valore economico» commenta
Barbagallo. In questo caso, il progetto è finanziato dal Ministero
dello sviluppo economico grazie a fondi erogati con la legge di
stabilità 2014.
L’attenzione è puntata in particolare non sul pastazzo tout court,
ma su una fibra essiccata che si può ottenere proprio a partire
dall’insieme dei residui. «In pratica, si tratta di lavare
ripetutamente il pastazzo con acqua per allontanare tutto quello che
non è fibra ed eliminare eventuali residui amari» spiega Rosario
Timpone della Citrech. «Dopo macinazione ed essiccazione si ottiene
una farina con caratteristiche proprie delle fibre alimentari e in
grado di assorbire acqua in quantità pari a 8 volte il suo peso».

Ed
è proprio questo “effetto spugna” che permetterebbe alla farina di
sostituire almeno in parte i grassi alimentari – in particolare
l’olio di palma – nei prodotti da forno.
Le fibre estratte dal pastazzo possono contribuire a dare morbidezza
a dolci e prodotti da forno
«In torte, brioche e merendine i grassi servono per dare struttura e
morbidezza all’impasto» ricorda Barbagallo. «Ma per l’effetto
morbidezza basta trovare il modo di trattenere acqua, impedendo al
prodotto di seccare: la farina derivata dal pastazzo può essere
d’aiuto proprio in questo senso». In linea di principio, l’aggiunta
del 5% di fibra di arancia alla comune farina di grano permette di
ridurre fino al 50% la quantità di grassi nell’impasto.
«Naturalmente – precisa Timpone – per i futuri sviluppi industriali
saranno necessari ulteriori test che dovranno coinvolgere aziende
produttrici ed esperti formulatori di ricette». A questo proposito,
il gruppo di ricerca è in contatto con l’azienda locale di prodotti
da forno Dais per le prossime sperimentazioni.
Non è tutto. La farina essiccata di arancia, infatti, può essere
prodotta anche in forma solubile, con l’obiettivo di addizionarla
alle bibite – in particolare le classiche aranciate – per aggiungere
quelle fibre che comunemente non possiedono.
Valentina Murelli
http://www.ilfattoalimentare.it/pastazzo-agrumi-palma.html


NAVELINA

Washington Navel. È la capostipite delle cultivar NAVEL;
deriva da una mutazione gemmaria di Selecta, che a sua volta avrebbe
avuto origine in Portogallo dall’arancio “de Umbigo” già descritto
all’inizio del XIX secolo. Dopo la Valencia è la cultivar più
diffusa nel mondo.
I frutti sono di pezzatura medio-elevata, maturano a partire da
gennaio e possono essere raccolti fino a tutto febbraio. è presente
nei principali Paesi agrumicoli del mondo. In Italia, inizialmente,
è stata introdotta una linea denominata Brasiliano che ha avuto il
centro di maggiore diffusione a Ribera, in provincia di Agrigento;
la sua produzione ha rifornito i mercati del Meridione d’Italia e in
particolare di Palermo.
Ne esistono due cloni: Brasiliano m500, risanato mediante
microinnesto presso l’Università di Catania e Brasiliano nucellare
92 selezionato presso il Centro di Miglioramento Genetico di
Palermo. Successivamente è stata importata la linea nucellare
C.E.S.3033 costituita da Frost in California. Quest’ultima, che si è
moderatamente diffusa in Sicilia, Basilicata e Sardegna, non sempre
esprime elevata produttività.
Prodotto stagionale disponibile nei mesi di: Dicembre - Gennaio

_____________________________________________________________________________________________________________
TAROCCO
IPPOLITO
Deriva da una mutazione rinvenuta nei primi anni
’90 nel lentinese; le prime osservazioni condotte presso l’Università
di Catania hanno consentito di esprimere giudizi positivi
riguardanti diverse caratteristiche dei frutti. Tra queste la più
rilevante è l’intensa pigmentazione, specie della polpa: dopo la
cultivar Moro i frutti di Ippolito sono quelli che presentano i più
alti contenuti di antociani. La pezzatura è piuttosto elevata, la
forma leggermente ovale con lobo pedicellare appena accennato; la
buccia è di spessore medio, a grana fine, a tessitura compatta e
presenta screziature rosso-vinose.
Il sapore è particolarmente gradevole dato da un armonico rapporto
tra zuccheri e acidi. La produttività è buona e i frutti resistono
bene sulla pianta per un ampio periodo; la raccolta nelle aree
precoci può avere inizio la prima metà di
gennaio e proseguire per tutto febbraio e oltre nelle zone a
vocazione tardiva.
Ha già suscitato un certo interesse e diversi sono gli impianti
costituiti, malgrado il breve tempo trascorso dalla sua scoperta.
_____________________________________________________________________________________________________________
TAROCCO NUCELLARE 57-1E-1. Si tratta della prima selezione di
Tarocco, costituita nel 1957 presso l’allora Istituto Sperimentale
per l’Agrumicoltura di Acireale; come detto la sua diffusione ha
avuto inizio negli anni ’60 e si è affermata piuttosto rapidamente
malgrado, inizialmente, presentasse una fase giovanile piuttosto
lunga.
Va ricordato che al tempo, per accedere alle provvidenze vigenti, i
nuovi impianti di Tarocco dovevano essere realizzati con questa
linea e solo dopo diversi anni sono stati ammessi via via altri
cloni, primi tra questi il Tarocco Galici e il Tarocco Catania.
Oltre che per la lunga fase giovanile si caratterizzava per
l’elevata vigoria e la notevole presenza di spine; col passare del
tempo e con i diversi passaggi d’innesto, la durata della fase
giovanile è diminuita e le piante possono entrare in produzione già
al terzo quarto anno. Una pianta adulta può produrre oltre 2
quintali di frutti in virtù del notevole sviluppo della chioma che,
per contro, non consente densità superiori a 300-350 piante per
ettaro.
L’epoca di maturazione è piuttosto precoce; nelle zone costiere la
raccolta può avere inizio nella prima metà di dicembre e continuare
per tutto gennaio, periodo oltre il quale i frutti possono essere
soggetti a cascola e a fenomeni di senescenza, mentre nelle aree più
interne può essere ritardata di qualche mese.
I frutti sono di pezzatura media, subsferici, a grana fine e
pigmentano poco sia all’interno sia nella buccia; i principali pregi
sono la precocità e la produttività, il maggiore difetto la
spinescenza che, specie in presenza di vento, è causa di ferite ai
frutti. Il periodo di maturazione medio precoce
(novembre-febbraio);
_____________________________________________________________________________________________________________

Considerato l’ampio arco di tempo in cui è possibile riscontrare sul
mercato la presenza di frutti di Tarocco, sarebbe auspicabile che
anche il consumatore cominciasse a distinguere le caratteristiche
dei diversi cloni per meglio apprezzarne le peculiarità. A tale
scopo sarà necessario che la raccolta, il confezionamento e
l’etichettatura vengano effettuati in maniera distinta e ciò, a
oggi, non sempre avviene. Può accadere che la stessa confezione
contenga frutti provenienti da zone di coltivazioni diverse o,
peggio, da cloni a diversa epoca di maturazione, con la conseguenza
che nella stessa mensa possono arrivare frutti troppo e/o poco
maturi. Affinché si instauri un rapporto di fidelizzazione tra
produzione e consumo è indispensabile che i frutti vengano
commercializzati quando esprimono al meglio le potenzialità
qualitative tipiche di ciascun genotipo


Piretti

___________________________________________________________________________________________________________


ACETOSELLA GIALLA (Acitedda
o Acitazzu)
 L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta
a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia
come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia
delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con
evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome
che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie
che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina
erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una
delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.
Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa
collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo
giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in
Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti
alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;
sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il
prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della
Sicilia! L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta
a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia
come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia
delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con
evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome
che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie
che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina
erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una
delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.
Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa
collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo
giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in
Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti
alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;
sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il
prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della
Sicilia!
Le foglie talvolta vengono usate per arricchire le insalate, infatti
hanno un gradevole sapore leggermente aspro. Le foglie vengono
inoltre usate anche in medicina perché contengono sostanze
rinfrescanti, diuretiche, antiscorbutiche ed astringenti. Il sapore
acidulo è dato dal ricco contenuto di ossalati. Si utilizza la
pianta fresca raccogliendone le radici, il gambo e le foglie ancora
tenere. La pianta essiccata perde le sue proprietà.
Dove si trova: l’acetosella ama un
terreno fertile e ricco d’umidità e predilige le zone ombrose
montane o collinari. La posizione ideale per l’acetosella è
decisamente quella ombreggiata anche se, in Sicilia vegeta
tranquillamente nelle zone assolate. Nel lentinese il territorio ne
e’ ricchissimo e sovente si gode di vasti terreni invasi dai suoi
bei fiori gialli che spesso diventano invadenti e si infiltrano
dappertutto al punto che non vi e’ mezzo per liberarsene se non
sterilizzando il terreno
Quando si raccoglie: l’acetosella nel nostro territorio si puo’
gia’ raccogliere nel periodo gennaio-marzo, quando e’ in fioritura.
ttenzione: e’ controindicata per quanti soffrono di
disturbi e malattie renali. Rispettare scrupolosamente le dosi. Se
ingerita in grandi quantità può causare lesioni renali e
intossicazione. Avvertenza: per evitare effetti collaterali, usare
sempre sotto controllo medico.
Usi in Cucina:: come per altre
acetoselle si possono utilizzare con moderazione le foglie crude in
aggiunta alle insalate primaverili. In particolare per questa tipica
specie si possono utilizzare anche i gambi, più consistenti che in
altre. Per il loro sapore acidulo foglie e gambi possono costituire
la base o entrare a far parte di salse di accompagnamento per carni
lessate, pesci o uova. Utilizzate come sostituto del limone se ne
possono ricavare inoltre ottime limonate. Si può utilizzare inoltre
anche l’uso dei piccoli bulbi consumati dopo averli arrostiti sulla
brace, conditi o meno con olio e limone. L’utilizzo più comune
comunque e’ quello del gambo come gradevole passatempo non solo dei
ragazzi ma anche degli adulti, per ricavarci il succo amarognolo,
asprigno e dolce allo stesso tempo.
Curiosita’: negli usi più popolari si utilizzavano sulla pelle
arrossata impacchi di questa erba, ma l’uso più frequente e
immediato e’ quello di utilizzarne gli steli per togliere l’arsura
durante escursioni o lavori faticosi di campagna. Il comportamento
caratteristico dei fiori e delle foglie di chiudersi e ripiegare al
ridursi della luce solare indica ancora oggi ai contadini la
possibilità di piogge imminenti.
http://www.lentinionline.it/erbe/acetosella.htm

BIETOLA SELVATICA (Secala serbaggia)
La bietola selvatica o spontanea ha il suo nome di
riconoscimento botanico Beta vulgaris. Sembra che bett
sia un termine celtico per indicare il colore rosso e
che questa sua caratteristica si rifletta nelle venature
rossicce delle radici e sulle nervature centrali di
molte varie tà di bietola. Questa pianta è molto comune
in Italia e la troviamo sotto i vigneti, nei luoghi
sabbiosi, lungo zone coltivate e incolte ad
un'altitudine che va dal piano sino a 600 m s.l.m. La
raccolta delle foglie di bietola spontanea inizia
da
gennaio sino a giugno e riprende poi da ottobre a fine
anno. tà di bietola. Questa pianta è molto comune
in Italia e la troviamo sotto i vigneti, nei luoghi
sabbiosi, lungo zone coltivate e incolte ad
un'altitudine che va dal piano sino a 600 m s.l.m. La
raccolta delle foglie di bietola spontanea inizia
da
gennaio sino a giugno e riprende poi da ottobre a fine
anno.
Molto simile come forma alla sorella coltivata con però più
caratteristiche di resistenza e rusticità che si rispecchiano in
maggior quantità di principi attivi salutari come vitamine e sali
minerali. Infatti è importante come fonte di ferro con proprietà
antianemiche ed è una delle verdure più ricche in vitamina A. Un
consiglio per conservare tutte le sue preziose sostanze è quello di
utilizzare anche l’acqua di cottura delle bietole visto che molti
nutrienti sono solubili e per recuperarli va consumata l’acqua. Di
facile utilizzo in cucina per torte salate e pasta verde, oltre che
nelle zuppe, minestre e sformati, grazie al suo sapore delicato e
gradevole.
http://www.cure-naturali.it/dieta-alimenti/piante-spontanee-commestibili-gennaio/38/4/f

CACCIALEPRE (Caccialebbra)
Caccialebbra, Grattalingua, Latticina, Latticino,
Latticrepolo, Lattughino, Paparrastello, Terracrepolo.
Il primo termine del binomio è dedicato al medico e
naturalista tedesco J. J. Reichard, mentre il secondo
deriva dal greco picros = giallo, con riferimento al
colore dei fiori.
Pianta erbacea perenne fornita di una radice ingrossata
dalla quale, al sopraggiungere dell`inverno, vengono
emessi getti formanti una rosetta basale di foglie
tenere e carnosette, di colore verde-glauco, con margini
spesso purpurei. Dalla rosetta emerge uno scapo, alto
fino a 40 cm, che porta capolini cilindrici, piriformi
prima della fioritura, costituiti da fiori gialli, gli
esterni in genere bruni o venati inferiormente da strie
purpuree. La fioritura avviene tutto l`anno, così come
le foglie persistono in ogni stagione assumendo, però,
un colore più scuro al sopraggiungere dell`estate. I
frutti sono acheni di due tipi: gli esterni scuri,
solcato-bernoccoluti, gli interni chiari e quasi lisci.
Il Caccialepre è diffuso in quasi tutta Italia, dove è
comune sui terreni sassosi, incolti aridi, muri e rupi
marittime. Non si rinviene oltre i 1000 m di altitudine.
Si raccoglie la rosetta basale quando è giovane e verde,
prima che la pianta
 emetta lo scapo fiorale. La rosetta
va troncata a livello del terreno con un coltello in
modo da non ledere la radice. Il taglio provoca la
fuoriuscita di una modesta quantità di latice bianco e
dolciastro; questo per contatto annerisce la pelle, ma è
innocuo e può essere facilmente rimosso con olio. emetta lo scapo fiorale. La rosetta
va troncata a livello del terreno con un coltello in
modo da non ledere la radice. Il taglio provoca la
fuoriuscita di una modesta quantità di latice bianco e
dolciastro; questo per contatto annerisce la pelle, ma è
innocuo e può essere facilmente rimosso con olio.
Le foglie del Caccialepre si consumano crude in insalata
oppure lessate e perlopiù mescolate ad altri erbaggi,
quali il Crespigno, la Lattuga alata, la Piattolina,
ecc. Il Caccialepre è, infatti, particolarmente adatto
per preparare le classiche mesticanze (i vidduri
maritati o mischigghi). L`erborinatore inesperto può
confondere il Caccialepre con altre erbe mangerecce,
come il Lattugaccio (Chondrilla juncea L.) o la Lattuga
alata (Lactuca viminea (L) Presl), data la somiglianza
negli stadi giovanili.
Il Caccialepre è un erbaggio che rientra anche nelle
tradizioni fitoalimurgiche di altre regioni d’Italia. In
alcune aree ne è stata tentata la coltivazione.
Osservazioni sui nomi volgari. Il termine Caccialepre ha
etimo incerto, sembra tuttavia (DURO, 1986-93); che esso
sia composto da un primo elemento alterato: caccia(re) e
la lepre; cioè erba utile come esca per cacciare la
lepre. Il sinonimo Caccialebbra non ha nulla a che
vedere con la malattia infettiva; è un meridionalismo;
infatti in questo contesto linguistico lebbra è il
plurale (neutro) di lebbru = lepre.
Nomi dialettali Adrano: Caccialebbru, Caccialebbra
Belpasso: Caccialepri Bronte: Gallepura, Giallepura
Castiglione: Caccianepura Linguaglossa: Pirnici,
Pirnici duci Maletto: Giallepura Milo: Caccialebbri
Nicolosi: Evva di pinnici, Evva pinnici Pedara:
Caccialebbri Ragalna: Scaccialebbra, Scacciacalebbra
Randazzo: Caccialiepura Santa Venerina: Caccialebbri
http://www.dipbot.unict.it/alimurgiche/scheda.aspx?i=11

Roberto, un pezzo di terra in regalo per la laurea:
"Così costruisco il mio futuro"
04/01/2020 - 09:04di Carmen Greco
La richiesta del giovane è stata rivolta ai genitori
che hanno acquistato un terreno a
Trecastagni dove è stata avviata una coltivazione di
piante aromatiche


 |
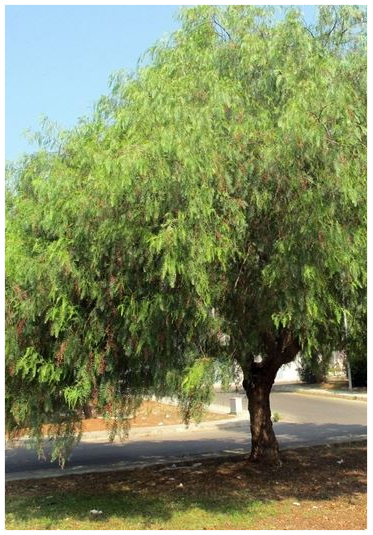 |
 |
|
MAGNOLIA |
FALSO PEPE |
EUCALIPTO |
Alberi da
frutta
 |
 |
 |
 |
 |
| ARANCIO |
LIMONE |
MANDARINO |
KIWI |
MELO |

Le palme più diffuse in Sicilia
sono Phoenix canariensis (ma il punteruolo rosso l’ha distrutta
quasi del tutto) Chamaerops humilis (la palma nana, l’unica
endemica), Washingtonia filifera e W.robusta e Phoenix dactylifera
(la palma da datteri).
 |
 |
 |
 |
 |
|
Phoenix canariensis |
Chamaerops humilis |
Washingtonia filifera |
Washingtonia robusta |
Phoenix dactylifera |
I cacciatori del punteruolo rosso
di Mario Pintagro
«Altro che ghostbusters». I tecnici e gli specialisti impegnati
nella lotta contro il punteruolo rosso che sta distruggendo le
nostre palme rifiutano l´etichetta che il cronista gli vuole
affibbiare. Loro non acchiappano fantasmi. Sì, è vero, i risultati
non sono stati granché ma il nemico è insidioso, tangibile e
difficile da sconfiggere in breve. C´è chi si appella alla scienza
per monitorare questo coleottero asiatico che sgranocchia le palme
canariensi - ne ha già distrutte tremila in Sicilia e altrettante
sono intaccate - chi invece preferisce i metodi spicci che
consistono nel salvare il salvabile. E chi, infine, vuole agire
preventivamente, prima che la minaccia rossa - ma non si tratta di
un insetto comunista, come qualcuno ironizza sul sito palermitano di
repubblica - arrivi a colpire gli apici delle palme e a
distruggerle. È il caso di Riccardo Agnello che non vuole
compromettere la vista mozzafiato della sua villa di Mondello. Ha
una sola palma in giardino, per il momento in ottima salute, ma
tutt´intorno è un rosario di attacchi del coleottero che con il suo
rostro in due settimane divora il cuore della palma condannandolo a
morte. Agnello non ci sta a perdere il vanto del giardino. E ha
chiamato Francesca Simonte, perito agrario e direttore
Confagricoltura di Trapani che sta provando con l´endoterapia.
Iniezioni di abamectina, un composto diluito, ottenuto da un
batterio presente nel terreno, che agisce sul sistema nervoso di
molti insetti. Ma il successo è garantito per piccoli insetti.
Qualche iniezione del prodotto, addizionato con un concime fogliare
e in via preventiva la palma dovrebbe essere al sicuro. O almeno si
spera, visto che la Simonte ha visto morire una a una le palme del
litorale Marausa a Trapani.
Sempre in via preventiva è la tecnica proposta dallo studio
agronomico Asa Consulting che ieri a Santa Flavia ha presentato i
suoi studi. «Utilizziamo prodotti consentiti dal decreto dell´8
marzo - dice Enrico Camerata Scovazzo, agronomo dello studio -
sostanze non nocive che vengono somministrate alle radici e
assorbite nel giro di due settimane. Si effettuano 4 trattamenti
all´anno». E di trattamenti endoterapici parlava qualche tempo fa
anche l´agronomo egiziano Nabawy Metwaly, guardato con un po´ di
scetticismo dall´ambiente accademico.

Ma ieri all´Asa è stato presentato anche un sistema biologico che
contrasta il punteruolo con l´impiego di nematodi, piccoli vermi
antagonisti. Tecnica già sperimentata da Stefano Colazza, entomologo
della facoltà di Agraria. In giro sembra che si vedano meno palme
attaccate dal punteruolo, forse è in corso una regressione? «Non
bisogna cantare vittoria - spiega Giuseppe Barbera, tra i docenti
impegnati nel progetto di monitoraggio - forse è il risultato delle
diverse strategie messe in atto, dall´abbattimento delle piante
malate ai trattamenti endoterapici e chirurgici».
E mentre l´Università procede con il suo campo di sperimentazione
in viale delle Scienze in cui sono coinvolte le facoltà di Agraria e
Ingegneria, il punteruolo arriva in Francia. A Nizza non sanno che
fare. Ieri mattina una troupe di France 2 è giunta a Palermo e ha
ripreso come si interviene. L´assessore all´ambiente Francesca
Grisafi ha illustrato il taglio di un esemplare ormai al secondo
stadio, poi è passata a illustrare la tecnica di maggiore successo,
quella dendrochirugica. Già sono state salvate 60 palme al Foro
Italico, a villa Giulia e davanti lo stadio della Favorita. Troppo
poco, ma è un timido segnale nella lotta contro il punteruolo rosso.
Per più di un´ora cestelli mobili, camion e squadre di operai muniti
di motosega andavano e venivano. Il Comune ha fatto un figurone
davanti alle telecamere transalpine. Anche se il biotrituratore in
azione era dell´Orto botanico.
http://palermo.repubblica.it/dettaglio/palme-i-cacciatori-del-punteruolo-rosso/1455723


_____________________________________________________________________________________________________
I DATTERI SICILIANI
di Antonio Castorina
Le coltivazioni più famose e diffuse sull’Isola sono quelle degli
agrumi, importati dagli Arabi. E sempre gli Arabi diffusero
l’utilizzo delle Phoenix dactylifera L. più conosciuta come Palma da
dattero.
Attualmente questo tipo di palma, per il suo portamento slanciato ed
elegante, è utilizzata come pianta ornamentale in quasi tutte le
città ed i paesi siciliani.
Quello che è curioso, però, è che in tantissime zone di Sicilia i
frutti della palma da dattero, i datteri appunto, arrivano a
maturazione e nonostantela Siciliasia una delle maggiori terre in
cui questo frutto dalla polpa zuccherina viene consumato, non è mai
partita una campagna di sensibilizzazione verso una coltivazione
destinata al commercio.
Probabilmente il motivo va ricercato nella concorrenza che andrebbe
a trovare il dattero siciliano, dovendo competere con i più celebri
datteri nordafricani. Ma non è detto che la produzione non potrebbe
essere proficua, infatti a sentire alcune persone di Catania e
provincia che hanno assaggiato i datteri che spontaneamente sono
maturati nella città etnea questi frutti non dovrebbero temere
confronti, infatti secondo la signora Serafina : “I datteri
Siciliani sono molto simili, nel gusto, ai datteri Tunisini”mentre
la signora Laura ha dichiarato: “Questi datteri sono carnosi e molto
gradevoli al gusto”.
Purtroppo è difficile trovare gente che abbia assaggiato i datteri
che crescono e si maturano sulla nostra Isola, anche perché molte si
trovano in giardini privati.
Nel centro storico di Catania, in piazza Cutelli ed piazza Iolanda,
vi è una grande concentrazione di palme da dattero, all’interno di
aiuole pubbliche, che riescono a portare a maturazione i loro
frutti.
Questo è dovuto al fatto che nel centro della città etnea, in
estate, si raggiungono elevate temperature, molto spesso vicine
ai40°C,, l’inverno non è mai rigido ed inoltre le zone sulle quali
insistono queste essenze arboree sono quotidianamente ed
abbondantemente irrigate.
La coltivazione per la commercializzazione dei datteri potrebbe
rappresentare, oltre ad una novità nell’ambito delle coltivazioni
siciliane ed europee, una nuova opportunità lavorativa.
Se è vero che le palme impiegano circa 20 anni per produrre i primi
frutti è pur vero che le palme dattifere sparse perla Siciliagià
oggi producono questo gustoso frutto, che attualmente dopo la
maturazione cade a terra e resta a marcire ai piedi della pianta
madre.
Attualmente la Siciliaè l’unica terra dove la palma da datteri
cresce numerosa e dà frutti, ma non vengono sfruttati per la
commercializzazione.
Un freno alla coltivazione potrebbe essere caratterizzato dalla
presenza del Rhynchophorus ferrugineus, meglio noto come punteruolo
rosso.
Questo coleottero è responsabile della morte di un elevato numero di
esemplari di palme, ma attualmente molte piante di questo genere non
sono state attaccate dall’insetto e continuano a produrre datteri.
Insomma, la possibilità di vedere sulle tavole dei Siciliani dei
datteri siciliani è ancora remota, ma la nostra Isola ne produce ed
in buone quantità, pertanto attualmente possiamo gustarli mentre
passeggiamo lungo le vie delle nostre città.
https://mis1943news.wordpress.com/2011/10/30/i-datteri-siciliani/
|







 ere al clima rigido di questa stagione.
ere al clima rigido di questa stagione.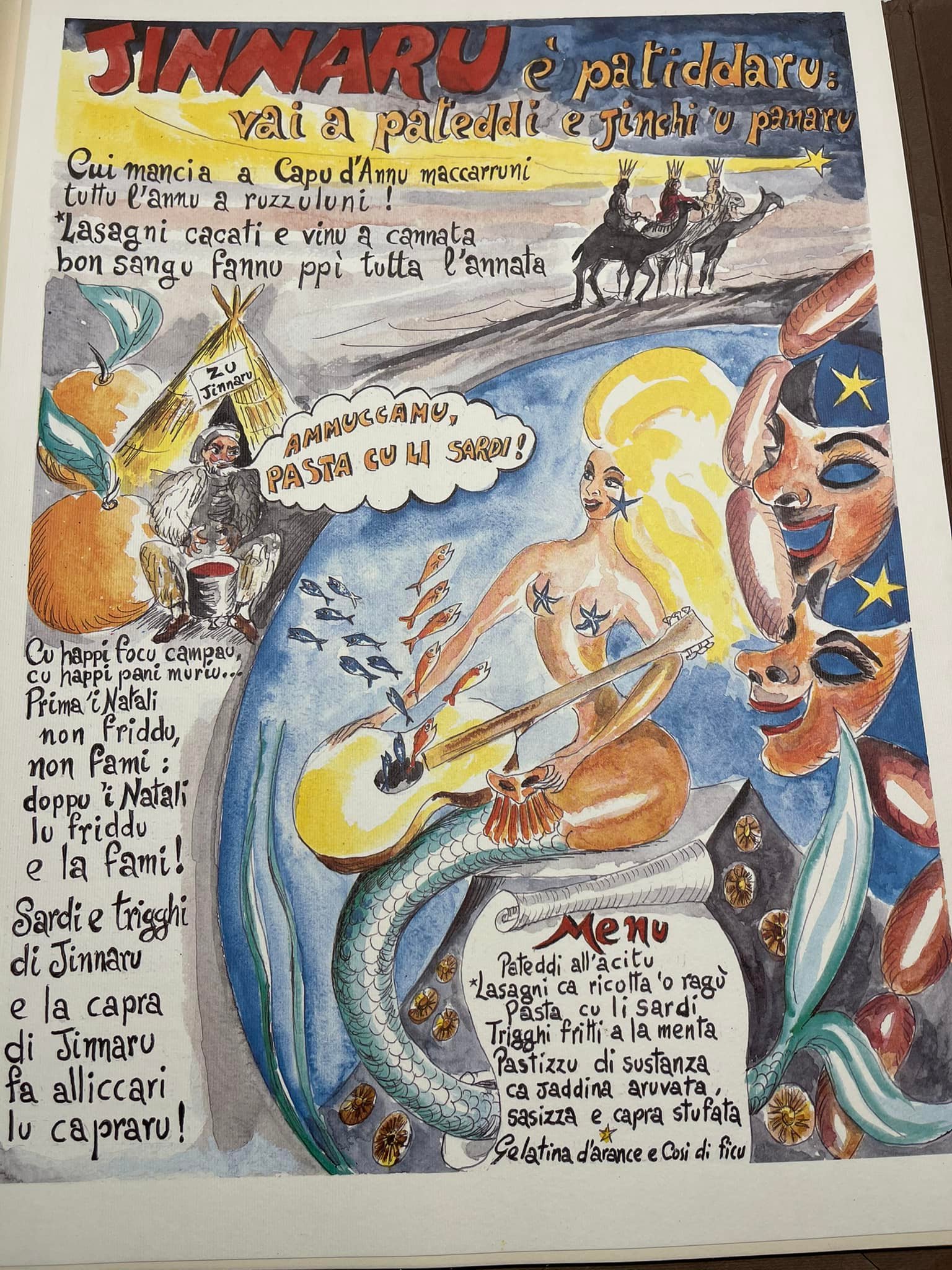






 La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in
Campania da circa un
decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso
leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE
RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi
con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),
portamento basso e semisferico.
La lollo rossa è una qualità di lattuga introdotta in
Campania da circa un
decennio dal Nord Europa, con cespi di colore rosso
leggero tendenti al verde oppure nella variante "TRIPLE
RED" di un rosso accesso e tendente allo scarlatto e poi
con cespi mediamente leggeri (200 gr in media),
portamento basso e semisferico. 

 e può
essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche.
e può
essere usato per una gran varietà di piatti, dalle insalate alla ceviche.





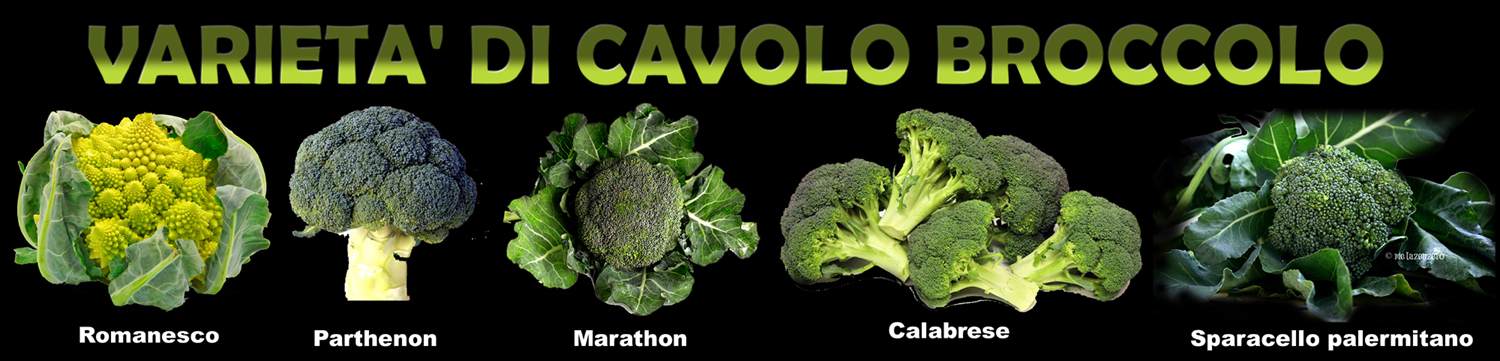




 non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in
particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello
mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo
dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,
6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande
religione monoteista, l’ebraismo.
non solo di alcuni dei prodotti alimentari, in
particolare le arance e i loro derivati, più diffusi e consumati a livello
mondiale, ma di frutti, come il cedro, che hanno accompagnato lo sviluppo
dell’agricoltura sin dagli albori della civiltà indoeuropea, a Babilonia,
6000 anni orsono, fino a diventare parte importante della prima grande
religione monoteista, l’ebraismo.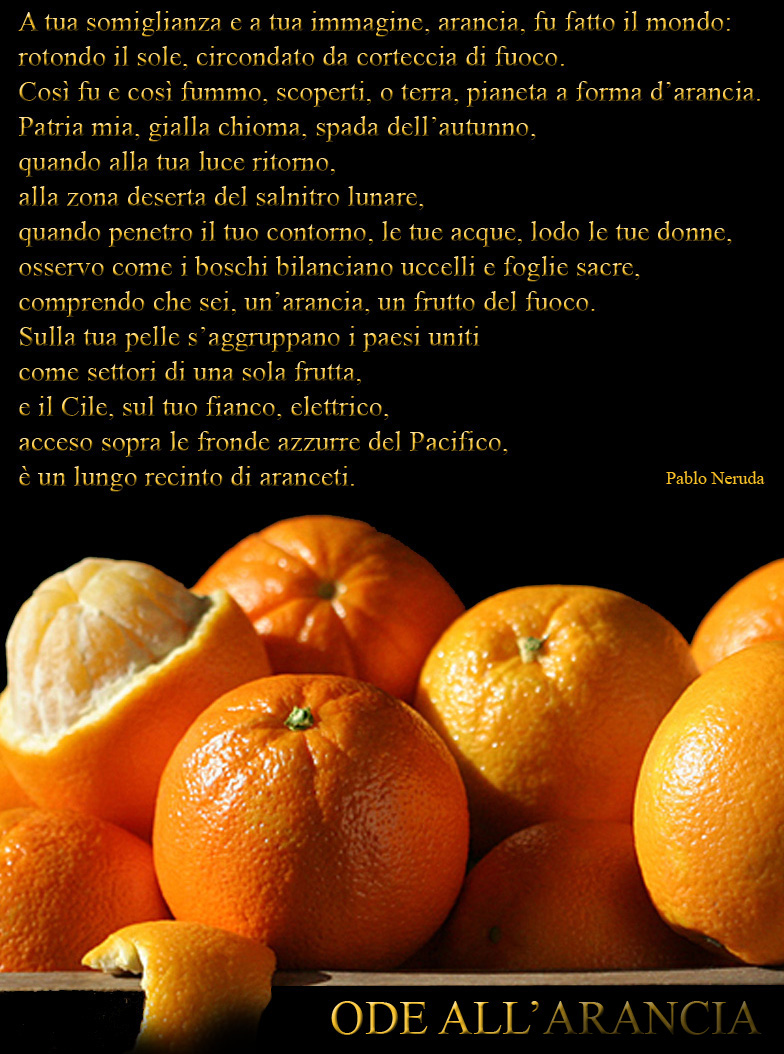 pea, diffusa nella Sicilia
arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli
successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di
diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del
Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville
Medicee, che ne sono simbolo imperituro.
pea, diffusa nella Sicilia
arabo-normanna e in Andalusia a cavallo dell’anno mille e nei secoli
successivi. Simbolo di sapienza agronomica e, nello stesso tempo, di
diletto. Ma gli agrumi diventano, poi, in qualche modo, protagonisti del
Rinascimento italiano, e, in particolare, della bellezza delle Ville
Medicee, che ne sono simbolo imperituro.

























 L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta
a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia
come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia
delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con
evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome
che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie
che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina
erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una
delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.
Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa
collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo
giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in
Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti
alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;
sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il
prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della
Sicilia!
L’acetosella gialla (Oxalis Pes-Caprae L.) propriamente conosciuta
a Lentini col nome di “iauradduci” e in altre zone della sicilia
come “trifogghiu acitusu” oppure “sucameli”, fa parte della famiglia
delle Oxalidaceae. Alle oxalis in genere si attribuiscono olre 600 specie ed e’ diffusa in Europa, Sud-Africa, Messico, Cina, Brasile e Sud-America. Il nome deriva dal greco Oxys = acido e Sal = sale con
evidente attinenza al sapore delle parti aeree della pianta. Il nome
che indica la specie invece fa riferimento alla forma delle foglie
che assomiglierebbe allo zoccolo della capra. Questa piantina
erbacea perenne dall’aspetto gentile è nota in realtà per essere una
delle piante più infestanti delle coltivazioni e dei giardini.
Invasiva di ampie zone della Sicilia, occupa dal mare fino alla basa
collina campi coltivati e incolti che si ammantano di un bellissimo
giallo in inverno e all’inizio della primavera. La fioritura, in
Sicilia, avviene tra gennaio-marzo. I fiori hanno colori splendenti
alla luce del Sole; si chiudono al tramonto o quando è brutto tempo;
sono davvero deliziosi e meravigliosi quando riempiono tutto il
prato e diffondono una luce gialla intensa. Sono i Fiori della
Sicilia!





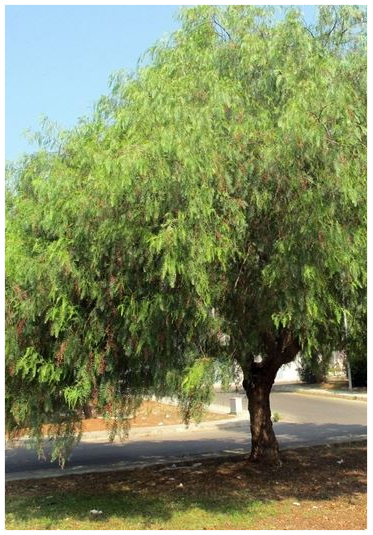


























 ale
del 60/40 all’interno di una quaddara (il tradizionale calderone di
rame) e riscaldato a circa 45 gradi “Don Peppino e gli zammattari
prima di lui non avevano termometri a disposizione: per controllare
che il latte fosse giunto a temperatura mi disse che era sufficiente
infilarci il braccio ‘finchè resiste la mano’. Raggiunta quella
temperatura, si poteva aggiungere il caglio”. Il caglio che usa
Carmelo, ottenuto dalle interiora del capretto, è lo stesso
utilizzato dagli zammattari per generazioni. La quaddara viene
quindi tolta dal fuoco per circa un’ora, in modo che si formi la
cagliata. Quest’ultima viene poi rotta energicamente con l’ausilio
di un attrezzo di legno prima di riportare la quaddara sul fuoco e
riscaldarne nuovamente il contenuto ‘finchè resiste la mano’.
ale
del 60/40 all’interno di una quaddara (il tradizionale calderone di
rame) e riscaldato a circa 45 gradi “Don Peppino e gli zammattari
prima di lui non avevano termometri a disposizione: per controllare
che il latte fosse giunto a temperatura mi disse che era sufficiente
infilarci il braccio ‘finchè resiste la mano’. Raggiunta quella
temperatura, si poteva aggiungere il caglio”. Il caglio che usa
Carmelo, ottenuto dalle interiora del capretto, è lo stesso
utilizzato dagli zammattari per generazioni. La quaddara viene
quindi tolta dal fuoco per circa un’ora, in modo che si formi la
cagliata. Quest’ultima viene poi rotta energicamente con l’ausilio
di un attrezzo di legno prima di riportare la quaddara sul fuoco e
riscaldarne nuovamente il contenuto ‘finchè resiste la mano’. della forma di formaggio stagionato che
veniva fatta rotolare lungo il pendio della via principale di Novara
di Sicilia.Quel formaggio era il Maiorchino, e ancora oggi, durante
il Carnevale, con le forme stagionate, nei comuni di Basicò e Novara
di Sicilia, in provincia di Messina, si continua a giocare: i
pastori gareggiano facendole rotolare lungo il pendio della via
principale del paese.Il Maiorchino è un formaggio di antica
produzione, sembra che abbia fatto la sua prima apparizione nel
Seicento.
della forma di formaggio stagionato che
veniva fatta rotolare lungo il pendio della via principale di Novara
di Sicilia.Quel formaggio era il Maiorchino, e ancora oggi, durante
il Carnevale, con le forme stagionate, nei comuni di Basicò e Novara
di Sicilia, in provincia di Messina, si continua a giocare: i
pastori gareggiano facendole rotolare lungo il pendio della via
principale del paese.Il Maiorchino è un formaggio di antica
produzione, sembra che abbia fatto la sua prima apparizione nel
Seicento.













































